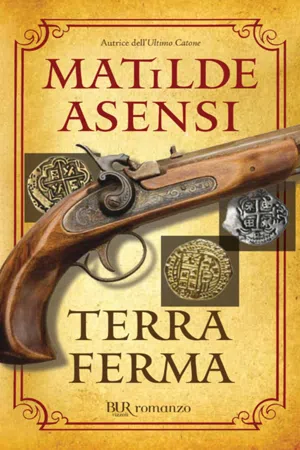![]()
Capitolo 1
Martín, mio fratello minore, morì combattendo valorosamente contro i pirati inglesi che, dopo aver colpito a cannonate la nostra galera per buona parte della notte, all’alba lanciarono i grappini di abbordaggio e ci accostarono alla loro fiancata di dritta per rubarci tutte le mercanzie che il nostro vascello trasportava dai mercati di Siviglia alle colonie della Terra Ferma,* nel Nuovo Mondo. Il mio povero fratello aveva soltanto quattordici anni, ma usava la spada meglio di tanti hidalgos e di tanti soldati del re, perché il nostro signor padre, uno dei più apprezzati fabbricanti di spade di Toledo, era stato suo maestro e gli aveva insegnato l’arte a dovere. Per disgrazia, con gli stessi occhi che stanno vedendo queste lettere mentre le scrivo, vidi come quel maledetto inglese gli assestava sulla testa, con una mazza di ferro, un colpo mortale che gli fece saltare le cervella.
I pirati ci avevano seguiti fin dal tramonto come cani affamati in attesa degli avanzi di un banchetto. Ma, anche se la nostra galera faceva parte della grande flotta conosciuta come Los Galeones, che una volta all’anno navigava in direzione di Cartagena de Indias, nessuna delle navi da guerra — la capitana e l’ammiraglia, più altre cinque, munite di artiglieria per la difesa dei vascelli mercantili —, nessuna, dico, accorse in nostro aiuto, e io ignoravo allora la ragione per la quale il generale Sancho Pardo, al comando della flotta, ci avesse abbandonati al nostro destino in quella maniera così vile. Siccome il nostro mercantile era vecchio e aveva le stive colme, navigava molto lentamente, così i cani dei mari ci diedero la caccia come parve e piacque a loro.
Noi donne che viaggiavamo a bordo di quel mercantile eravamo poche, cinque o sei al massimo; ci eravamo nascoste in una delle stive, dietro fagotti, botti e casse di mercanzia, morte di paura e di angoscia per il futuro. Poco dopo l’inizio dell’assalto, nel pieno fragore dello scontro e sentendo l’eco degli spari degli archibugi, la mia fedele balia Dorotea, mettendo a rischio la nostra vita, mi trascinò fino a dove dormivano i passeggeri e, facendo scorrere il telo che separava i nostri giacigli, mi disse: «Presto, indossa i vestiti di tuo fratello!».
Io, sconvolta dal pericolo e dal rumore, mi tolsi il velo e presi una sottana di panno che si trovava su un baule.
«Non metterti abiti tuoi, Catalina!» mi gridò Dorotea, strappandomi l’indumento dalle mani.
Dorotea era di poco senno e di scarso ingegno, ma il pericolo sveglia le menti più ottuse, e in un batter d’occhio la balia mi trasformò in un ragazzo con una camicia, una giubba scamosciata, una casacca di pelle e un paio di brache; mi raccolse i lunghi capelli neri e lisci sulla testa, poi mi mise il cappello che Martín si era comprato al mercato di Toledo per il giorno delle mie nozze, un cappello rosso a tesa larga rialzata da un lato, con un bel cordone attorno. Tanto stavano a cuore alla buona e dolce balia il mio onore e la mia virtù!
«Mettiti gli stivali» mi sollecitò mentre mi appendeva al collo l’astuccio di latta con i miei documenti. Il clangore delle spade e le grida degli uomini risuonavano sempre più vicini, sotto la seconda coperta. La balia, con il rosario in mano, continuava a pregare e a farsi il segno della croce.
Mi sedetti su una cassa e calzai gli stivali di renna di Martín, che avevo perso di vista dal momento in cui il capitano aveva ordinato a tutti gli uomini di difendere la nave con le armi. Per fortuna i piedi di mio fratello erano solo poco più grandi dei miei, dal momento che io ero piuttosto alta per essere una donna, e tutti i suoi indumenti mi andavano bene.
«E ora andiamo!» mi incalzò Dorotea, sistemandomi abilmente una bandoliera nel cui fodero aveva infilato una delle tre belle spade forgiate dal mio signor padre, spade che portavamo in dono al mio sposo sconosciuto, a mio suocero e al mio signor zio Hernando.
«Voglio anche una daga!» esclamai, dandole un violento strattone.
«E che altro desidera vostra signoria? Un archibugio?» si disperò lei.
«Non mi dispiacerebbe» affermai, risoluta. Forse l’abito non fa del tutto il monaco, ma indossare i vestiti di mio fratello mi conferiva sicurezza e intraprendenza. Nel corso dei miei sedici anni di vita non avevo fatto altro che attenermi ai miei obblighi come donna e mi ero sempre comportata in modo da procurarmi un buon marito. E ora mi ero veramente stancata. «Voglio una daga per la mano sinistra.»
«La signora prenda la sua daga e andiamo! Il Signore Gesù Cristo ci assista in questa sventura, poiché siamo in grave pericolo!»
Dorotea, afferrandomi per un braccio, cominciò a correre verso la poppa facendosi strada fra una gran quantità di oggetti vari che ingombravano gli stretti corridoi tra i giacigli dei passeggeri. Non sapevo dove si stava dirigendo né che intenzioni avesse, ma per il momento non mi opposi: tutto sembrava molto divertente. Inglesi? Che li lascino tutti a me, pensai, tastando la mia spada. Sono pronta a sfidarli! Eccomi qui, Catalina Solís, nativa di Toledo, figlia orfana e legittima di Pedro Solís e di Jerónima Pascual e, sventuratamente, recente sposa per procura di un tale Domingo Rodríguez, il cui padre è socio del mio signor zio Hernando nell’officina di lavorazione di metalli che entrambi possiedono in un’isola caribica chiamata Margarita.
Usando la prima scaletta che trovammo nel tragitto salimmo direttamente sulla tolda e, proprio mentre stavamo raggiungendo la cabina del capitano, vidi un maledetto pirata inglese colpire brutalmente la testa di mio fratello. Rimasi pietrificata. L’assurda allegria che un attimo prima m’aveva infiammata era del tutto scomparsa. Ebbi la sensazione di morire ed essere massacrata come il mio povero Martín. Stivali inglesi e spagnoli calpestavano sul ponte principale il suo sangue, i suoi capelli, le sue cervella. Per allontanarmi da quell’orrore, la mano di Dorotea mi tirò con maggior forza.
«Andiamo, andiamo!» mi implorò, tremando e piangendo. La seguii senza pensare a niente. Il mondo per me si era fermato.
Da quel momento i miei ricordi sono molto confusi. Entrammo nella cabina e Dorotea ruppe i vetri per gettare dalla poppa il piccolo scrittoio del capitano. Nonostante fosse piuttosto anziana, dai suoi gesti risoluti trapelava la forza di quando era una giovane contadina. Poi mi fece il segno della croce sulla fronte, mi diede un bacio e mi disse qualcosa che non capii, prima di obbligarmi a saltare nelle fredde e azzurre acque dell’oceano. Il sole stava sorgendo da est e già si percepiva il forte calore che, in quei luoghi sperduti del mondo, non dava tregua a uomini e a bestie.
Io all’epoca non sapevo nuotare, e quando il mio corpo affondò nelle profondità del mare per la forza della caduta, mi dissi che sarei morta annegata. Ma la stessa spinta dell’acqua mi fece risalire e respirai una gran boccata d’aria mentre, per istinto, i miei piedi e le mie braccia facevano tutto il possibile per mantenermi con la testa fuori dall’acqua. Le armi pesavano, i vestiti mi toglievano il respiro, il cappello rosso galleggiava accanto a me e, un poco più in là, lo scrittoio del capitano, capovolto, fluttuava tranquillamente sulle onde. Dorotea gridava, cercava di indicarmi qualcosa, ma, per la distanza, il fragore della battaglia e i miei continui, angosciosi tentativi di rimanere a galla su quell’acqua salata, non fui in grado di capire che cosa mi dicesse. Giurerei di aver visto una mano che la afferrava per i capelli e per la cuffia facendola scomparire all’interno della cabina del comandante. Non la vidi più affacciarsi e io, povera sventurata, tra bracciate, immersioni e sorsate d’acqua, raggiunsi a fatica lo scrittoio di legno.
La corrente mi portò lontano dalle navi piuttosto velocemente, ma non abbastanza da impedirmi di vedere il fumo nero che si alzò nel cielo quando i pirati appiccarono il fuoco alla nostra galera. La triste immagine non durò a lungo, e presto mi trovai circondata dalle onde del vuoto oceano, sola come non lo ero mai stata in vita mia, aggrappata allo scrittoio e immersa in un silenzio inquietante. Le lacrime mi scorrevano lungo le guance. Per fortuna avevo recuperato il cappello rosso: il sole rovente di quelle latitudini non avrebbe impiegato molto a bruciarmi il cervello. Ricordai anche che quelle acque erano infestate da grandi animali marini cui piaceva nuotare nelle vicinanze delle imbarcazioni, quindi, con grandi sforzi e tentando di non ribaltare il mio povero vascello a quattro gambe, riuscii a salirvi e a rannicchiarmici sopra. Passai tre giorni e tre notti in quella posizione, in balìa delle onde e delle correnti. La gola mi ardeva per la sete e mi dolevano gli occhi, bruciati dal sale e dai riflessi del sole. Le labbra mi sanguinavano e mi si riempirono di croste. A volte dormicchiavo, a volte mi disperavo per la mia cattiva sorte e arrivavo al punto di chiedermi se non avrei dovuto, magari, recitare una di quelle orazioni che Dorotea aveva insegnato di nascosto a Martín e a me quando eravamo piccoli. Ma resistevo per non offendere la memoria di mio padre facendo quello che lui tanto disprezzava. Oggi sono orgogliosa di poter affermare che in quel frangente sono stata forte, che ho affrontato la paura e che mi sono preparata a morire bene, come mi avevano insegnato: in pace e rassegnazione, senza bigotterie.
E allora, mentre reclinavo il capo in uno di quei leggeri sopori notturni pieni di incubi, il tavolo urtò piano contro qualcosa e girò su se stesso. Mi svegliai di soprassalto. Era notte, sì, ma il chiaro di luna era sufficiente per distinguere qualcosa. Una gigantesca ombra nera si stagliava contro il cielo, e si sentiva un quieto sciabordio di onde. Terra! Tentai di scivolare con attenzione nell’acqua, pronta a spingere la mia imbarcazione verso la costa, ma mi resi conto che il fondo si trovava a meno di un palmo dalla superficie. Sorpresa, mi alzai e avanzai sguazzando fino alla riva. Era una spiaggia, una spiaggia di sabbia molto fine e bianca quasi quanto la neve. Trascinai la mia prode lancia fuori dal mare e mi gettai a terra, più morta che viva, sfinita da tre giorni di ansie, paure e veglie.
Quando mi svegliai, grondante di sudore e fredda come la morte, il giorno stava terminando. Mi scossi e mi riavviai verso la spiaggia in cerca del calore della sabbia. Solo io so quanto mi sia costato quel percorso! Stavo molto male, e in quel luogo non si vedeva nessuno cui chiedere aiuto. Forse c’era un villaggio dall’altra parte della montagna, o a un’estremità della spiaggia, ma io non avevo né le forze né il fiato per raggiungerlo. Di nuovo mi preparai a morire lasciandomi abbracciare dalla calda e bianca sabbia di quella spiaggia deserta.
Impiegai due giorni a riprendermi da quelle strane febbri, che mi stremarono nello spirito e nel fisico, sulla costa più deserta del mondo. Durante quelle giornate non mi si avvicinò anima viva, nessuno cui chiedere assistenza, nemmeno un pescatore solitario o una pastorella. Andavo come uno spirito in pena verso la pozza quando la sete mi vinceva e ritornavo verso il mare quando il freddo mi gelava. Così, alternando sole e ombra, freddo e caldo, finalmente mi ristabilii, anche se una debolezza atroce, forse causata dalla malattia o dalla fame, non volle abbandonarmi.
Quando tornai a essere padrona della mia volontà e del mio senno, pensai che dovevo procurarmi con urgenza del cibo, se volevo recuperare le forze necessarie per andare in cerca del villaggio più vicino. In tutto quel tempo non avevo visto niente che si potesse considerare un alimento, ma per tranquillizzarmi mi dissi che, per poco che fosse, qualcosa doveva pur esserci. Cominciai allora a cercare della frutta o altro, ma, non avendo trovato niente dopo una lunga esplorazione, mi rassegnai all’idea di costruirmi una canna da pesca come quelle che avevo visto usare a Toledo. Camminai nell’acqua per vedere se nelle vicinanze galleggiasse un bastone o un pezzo di legno e scoprii che quel mare era pieno di pesci. Mi venne l’acquolina in bocca e tentai disperatamente di catturarne qualcuno con le mani, ma non ebbi fortuna, e comunque ero troppo debole per riuscire a prenderli. Non vidi né rami né bastoni, e nemmeno un pezzo di legno che potesse essermi utile. Al contrario di quelle del fiume Tago o di quelle del Guadalquivir, a Siviglia, le acque di quel mare erano assolutamente prive di sozzura e di rifiuti, cosa che mi dispiacque per le difficoltà che mi causava in quel momento l’assenza assoluta di detriti. Avanzai lungo la costa e di lì a poco, con mia grande gioia, trovai delle rocce entro le quali alcuni pesci erano rimasti intrappolati in piccole buche piene d’acqua. Le maree o le onde me li avevano lasciati a portata di mano. Ma come cucinarli? Come accendere un fuoco? Come prenderli e portarli fino al mio riparo, presso lo scrittoio-vascello? Risolvere il problema richiedeva tempo e io non riuscivo a sentire altro che fame, molta fame, cosicché guardai i pesci, ne presi uno con le mani e, senza pensarci due volte, gli mozzai la testa con un colpo di pugnale, gli tolsi le interiora e la lisca e lo mangiai. Fu come una magia. Ogni pesce che ingoiavo mi restituiva le forze; dopo sei o sette resuscitai e dopo tredici o quattordici mi sentii sazia e soddisfatta.
«Adesso basta, Catalina!» mi rimproverai, lavandomi le mani insanguinate nell’acqua e bagnando il cappello per proteggermi la testa dal calore. Mi sentivo talmente bene che, nonostante avessi ancora le gambe deboli, avrei potuto correre, come un destriero al galoppo, fino al mio vascello.
Quel pomeriggio stesso mi misi in cammino e percorsi tutta la spiaggia verso ponente. Scoprii alcune insenature e calette, ma nessun villaggio; poi, finalmente, arrivai dove terminava la sabbia e cominciava una scogliera, che cadeva a picco sul mare. Le onde si frangevano contro la parete rocciosa, formando pericolosi mulinelli. Non proseguii e ritornai a quella che cominciavo a considerare la mia casa, decisa a continuare l’esplorazione fino a quando avrei scoperto dove mi trovavo. Il mattino dopo presi la direzione contraria, calpestando con i miei stivali la sabbia morbida verso oriente, per arrivare, dopo una lega abbondante di cammino, alla stessa scogliera della sera precedente, ma all’estremità opposta. Scoprire questo fatto mi mise in ansia. Non avevo altra possibilità che raggiungere la cima della montagna per confermare i miei sospetti: ero capitata su una di quelle piccole e deserte Isole Sopravento* delle quali parlavano i marinai della galera quando raccontavano, all’imbrunire, storie di pirati e di tesori nascosti. Erano talmente tante, dicevano, che era impossibile inserirle nelle carte di navigazione. Molte di loro non erano mai state esplorate e nessuna imbarcazione aveva mai gettato l’ancora nelle loro acque. Solo pirati e corsari conoscevano quei luoghi perché servivano loro da rifugio e da nascondiglio.
In quel momento mi parve che la spiaggia, il mare e il monte girassero intorno a me come...