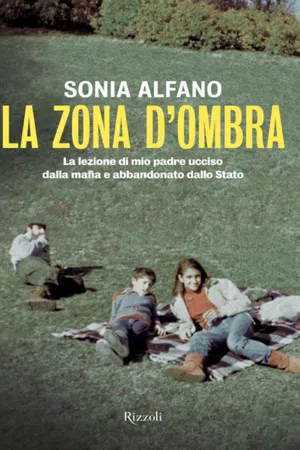![]()
1
Mio padre era un uomo inflessibile. Difficilmente ammetteva compromessi e spesso peccava perfino di eccesso di zelo. Come quella volta dell’incidente in classe, per esempio.
Aveva sempre fatto il professore di educazione tecnica alle scuole medie e, quando eravamo tornati in Sicilia dal Trentino nel 1976, aveva ottenuto un posto alla Galileo Galilei di Terme Vigliatore, in provincia di Messina. Divideva le sue ore di lezione tra la sede centrale e quella distaccata, che si trovava a Vigliatore, dove abitavamo.
Anche io, come tutti i ragazzini della frazione, ero iscritta lì nella sezione unica e per poter essere sua alunna c’era voluta una dispensa speciale del provveditorato. Siccome inoltre era vicepreside, capitava spesso che me lo ritrovassi dietro la cattedra anche come supplente.
Ero a casa con la febbre il giorno in cui uno dei miei compagni ruppe la maniglia della porta, e io venni a sapere dell’accaduto quando mio padre rientrò, all’ora di pranzo. Il mattino dopo tornai a scuola e lui entrando in aula con aria seria, esordì: «Mi ha detto il bidello che è stata rotta la maniglia».
Sulla classe calò il silenzio. Tutti gli studenti lo amavano e pendevano dalle sue labbra. Li aveva conquistati lasciandoli liberi durante le sue ore di discutere di ciò che li interessava e partecipando ai loro dibattiti con curiosità; quando però era ora di dedicarsi allo studio, esigeva la massima concentrazione e non ammetteva repliche. I ragazzi sapevano che non si arrabbiava gratuitamente, che considerava la lealtà e la trasparenza valori fondamentali. Capirono immediatamente che per la questione della maniglia sarebbe andato fino in fondo.
«Voglio sapere chi è stato» proseguì infatti, guardandoci negli occhi, uno a uno.
Nessuno aprì bocca e tra i banchi iniziò a serpeggiare un lieve disagio, benché tutti dissimulassero.
Papà girò attorno alla cattedra, ci si appoggiò e incrociò le braccia: «Se non viene fuori il colpevole» proseguì «rischiamo di far saltare la gita. O mi dite chi è stato, o sono costretto a pescare qualcuno io».
Ancora silenzio. Io osservavo la scena dal mio posto, tranquilla e distaccata, perché la vicenda questa volta non mi riguardava. Passarono alcuni istanti che parevano infiniti, poi mio padre trasse un profondo sospiro e si girò nella mia direzione.
«Sonia.»
«Che c’è?» sobbalzai, destandomi dal mio torpore.
«Se nessuno si fa avanti, paghi tu per gli altri.»
Sgranai gli occhi: «Ma io ero assente!».
Improvvisamente tutta l’attenzione si concentrò su di me, anzi su noi due: io ero allibita dalla sua mossa, lui sembrava amareggiato ma irremovibile. Adesso erano i miei compagni che si godevano lo spettacolo e, com’era prevedibile, nessuno di loro si fece avanti per difendermi.
Naturalmente non ci fu verso di fargli cambiare idea: fece rapporto additandomi come la responsabile del danno.
Mi arrabbiai da morire e quel giorno a scuola non gli rivolsi più la parola. Una volta a casa fu però costretto a rendermi conto del suo comportamento.
«Dobbiamo dare l’esempio» fu la sua lapidaria giustificazione.
«Questa è l’esasperazione dell’esempio!» protestai.
Non servì a nulla: a pagare dovevo comunque essere io.
E pagai. Non solo quella volta, ma per tutti e tre gli anni che lo ebbi come insegnante. Non voleva che qualcuno pensasse che mi favoriva, che ero avvantaggiata in quanto sua figlia, così mi trattava anche molto più severamente degli altri. Per esempio, mi interrogava tutti i giorni. Ero una delle prime della classe, con pagelle piene di 8 e 9; solo nella sua materia avevo 6. Agli esami, la commissione mi voleva promuovere con 9 e anche allora si intromise insistendo che dovevano darmi 7. Non c’era verso di fargli capire che anche farmi scontare al negativo quella nostra parentela era un’ingiustizia. Fortunatamente, agli esami, la professoressa di italiano lo prese in disparte e, senza troppi giri di parole, lo ridusse a più miti consigli. Fu probabilmente solo grazie a lei che uscii con il voto che mi spettava.
Ma si trattò di un’eccezione: di solito mi toccava rassegnarmi. Del resto, è quello che succede con le persone dotate di carisma. Di fronte a un padre tanto caparbio e trascinatore, non potevo che alzare le mani.
I miei genitori erano entrambi siciliani, anche se le loro radici rappresentavano una bella mescolanza di Nord e Sud. Mia madre è messinese, ma sua nonna veniva dalla provincia di Parma; aveva sposato un maestro di musica che suonava il fagotto con Toscanini e si era trasferita in Sicilia assieme a lui. La loro figlia (ovvero mia nonna) aveva a sua volta sposato il commendator Vincenzo Barbaro, anche lui di Messina. Mio nonno materno aveva affari in America e nei primi anni Cinquanta arrivò a festeggiare il quinto milione di lire guadagnato, una cifra da record per quei tempi. Era molto noto, oltre che per la sua ricchezza, anche perché faceva molta beneficenza, ma morì giovanissimo, lasciando una famiglia quasi completamente composta da donne.
Anche un ramo paterno del mio albero genealogico era settentrionale: mia nonna era nata e cresciuta in Piemonte, ad Alessandria, ma aveva sposato un medico condotto di Barcellona che aveva fatto la guerra in Africa rimettendoci un braccio. La loro era una delle famiglie borghesi più in vista della città e fu proprio mio nonno a trasmettere a mio padre una forte fede politica di destra.
Entrambi i miei genitori, dunque, provenivano da famiglie benestanti ed ebbero la possibilità di studiare. Si conobbero all’università, alla fine degli anni Sessanta: lui frequentava Economia, lei Giurisprudenza. All’epoca, mio padre militava nelle file di Ordine Nuovo, il movimento di destra che aveva seguito Pino Rauti nella sua scissione dal MSI di Almirante. Ne faceva parte dal 1967, ma Ordine Nuovo aveva cominciato, proprio in quel periodo, a prendere una deriva estremista che lui disapprovava; per questo se ne allontanò, pur senza rinunciare del tutto alla passione politica. L’attivismo era, del resto, una delle molte cose che aveva scoperto di avere in comune con la ragazza di cui presto si scoprì innamorato.
Poco dopo, la morte di mio nonno costrinse mio padre a lasciare l’università per trovarsi un lavoro. Fece il concorso come insegnante e vinse un posto a Cavedine, un minuscolo paesino delle Dolomiti. I miei genitori si sposarono il 2 gennaio del 1971 e mio padre si trasferì in Trentino da solo. Io e mia madre lo raggiungemmo alla fine di quell’anno: avevo appena compiuto un mese.
Cavedine arrivava a stento a tremila abitanti e ci si conosceva un po’ tutti. Molti facevano lavori stagionali: andavano per esempio in Val di Non a raccogliere le mele o i funghi. Anche mia madre aveva trovato un impiego come insegnante e, quando le capitava qualche supplenza, mi affidava ai vicini. Fu così che finii per essere svezzata a polenta, luganega e grappino nel latte, invece che a cannoli, arancini e pasta di mandorle. Per quattro anni, fummo solo noi tre in questo posto incantato che sapeva di favola. Un’istantanea racconta bene come fossi felice: io in mezzo alla neve con una mantellina rossa, su uno slittino dello stesso colore, costruito per me dagli alunni di papà. Mi chiamavano Cappuccetto.
Mio padre era sempre molto indaffarato, perché in quel periodo aveva ripreso l’attività politica: Almirante, con cui dopo aver lasciato Ordine Nuovo aveva riallacciato buoni rapporti, gli aveva affidato una missione. Si conoscevano da tempo: mio padre lo stimava molto e lui ricambiava l’affetto. Lo chiamava «il mio piccolo Goria» perché, anche a causa della sua folta barba, assomigliava molto al futuro ministro. Almirante aveva occhi miti e molto profondi. Da piccola mi pareva una specie di nonno, per quella sua aria simpatica e bonaria. Soprattutto dopo, quando eravamo già tornati in Sicilia, veniva da noi per i comizi, sempre solo, senza donna Assunta. Alla fine delle manifestazioni, andavamo tutti a cena insieme. La missione di cui aveva incaricato papà era rifondare la sezione del partito a Trento, e così lui ogni tanto partiva per darsi da fare con i banchetti per il reclutamento di nuovi iscritti.
Le giornate di Beppe Alfano si dividevano dunque tra l’attività di partito e il lavoro: la scuola al mattino e qualche ora in una fabbrica di jeans come operaio al pomeriggio. Ma non era ancora finita: quando usciva da lì, andava ad allenare la squadra di calcio dei suoi alunni e poi passava a scambiare qualche chiacchiera con gli amici al bar, prima di rientrare per cena. Io ero quasi sempre con lui: ogni volta che poteva, mi portava con sé, come una mascotte. Il sabato o la domenica pomeriggio, poi, andavamo tutti e tre a fare un giro a Innsbruck ed era una festa quando, per ripararci dal freddo, ci infilavamo in qualche stube a bere una cioccolata calda.
Nel 1975, nacque mio fratello Chicco (Fulvio, l’altro, sarebbe arrivato solo qualche anno dopo, nel 1982) e tornammo in Sicilia per sempre perché mio padre aveva finalmente ottenuto il trasferimento che sognava; sebbene avesse uno straordinario spirito d’adattamento sentiva infatti nostalgia della sua terra. Per me, invece, fino ad allora la Sicilia era rimasta un luogo quasi sconosciuto: ci vivevano i nostri parenti, d’accordo, ci andavamo ogni tanto per qualche breve periodo durante le vacanze, ma allora mi erano più familiari le Dolomiti, dove l’estate terminava a fine agosto, quando cadeva la prima neve.
Arrivammo a Messina che era giugno: sarei rimasta a vivere lì da mia nonna materna, assieme alla bisnonna e a una zia, mentre i miei avrebbero cercato una sistemazione vicino Barcellona.
Ricordo ancora l’interminabile viaggio in treno, poi il traghetto e la madonnina dorata che ci accolse dall’alto, all’imboccatura del porto di Messina, come un angelo buono. Gli ultimi chilometri fino a casa di mia nonna li facemmo in autobus: con gli occhi sgranati, guardavo fuori dal finestrino e ogni dettaglio mi sembrava sorprendente. Mia madre vide che ero un po’ stranita e mi chiese cosa avessi.
«Cio’, mama, quante machine!» le risposi, con un accento assai poco siciliano.
Tutti si voltarono a guardarmi come se fossi un marziano: «E questa? Da dove scende?». Scendevo dalle montagne, appunto. E stavo per iniziare un nuovo capitolo della mia vita.
Alla fine degli anni Settanta un po’ in tutta Italia esplose il fenomeno delle radio libere. Mio padre aveva avuto i primi contatti con quel mondo già in Trentino, ma una volta tornato in Sicilia volle entrare nel circuito, anche perché nel frattempo aveva maturato l’altra sua grande passione: quella per il giornalismo.
Era il 1977 e mentre Peppino Impastato a Cinisi, vicino a Palermo, dava vita a Radio Aut, lui cominciò a lavorare per Radio Canale 30, un’emittente messinese. Impastato denunciava la mafia e stava già attirando su di sé molta attenzione, decretando così la sua condanna a morte (lo uccisero la notte dello stesso giorno in cui venne ritrovato il cadavere di Aldo Moro, cosa che fece passare purtroppo in secondo piano il suo assassinio, altrettanto efferato), mentre mio padre era ancora ben lontano da quell’ambito: si occupava quasi esclusivamente di cronache sportive. Trasmetteva con un pionieristico sistema di fili volanti direttamente dallo stadio dove giocava il Messina, ma conduceva anche il programma notturno, parole e musica.
Al giornalismo vero e proprio, quello delle prime inchieste, arrivò negli anni immediatamente successivi, all’inizio degli Ottanta, quando cominciò a lavorare per Telemediterraneo, una tv locale di Milazzo. Qualche stagione dopo, approdò a un canale barcellonese, Telecity, il cui proprietario, un imprenditore tessile del posto, gli lasciava molta libertà di movimento. Da lì passò a Telenews, l’emittente di un suo amico, Antonio Mazza. Questi era una persona pacata e riflessiva, di indole molto diversa dalla sua, ma con cui papà, nonostante la differenza di tempra, sentì da subito di avere in comune la volontà di fare qualcosa per la loro terra. La piccola tv si rivelò presto uno strumento capace di raggiungere molte persone e di coprire buona parte della punta nordorientale della Sicilia, territorio che aveva come centro Barcellona Pozzo di Gotto. Ovvero, a parere di tutti, la zona più tranquilla e pulita dell’isola.
Barcellona, nella prima metà degli Ottanta, sembrava infatti diversa dal resto della Sicilia. Sfiorava i 45.000 abitanti e passava per una cittadina quasi sonnolenta. Affacciata sulla costa tirrenica con una campagna costellata di agrumeti e alberi d’ulivo, viveva di agricoltura, allevamento di bestiame e piccola industria. Un paese da sussidiario. Era speciale proprio perché nel suo territorio non succedeva mai nulla di rilevante: nessuna sparatoria, nessun fatto di sangue, nessun tentativo di estorsione. Niente lupare e coppole, insomma. La mafia pareva estranea e Barcellona, una specie di zona franca rispetto al resto della Sicilia, dove la malavita organizzata si faceva sia sentire sia vedere. Ma la realtà era un’altra, anche se io non potevo accorgermene perché ci crescevo dentro. Molte cose non sono alla portata di una bambina di sette, otto, poi nove, dieci anni. A Barcellona qualcosa si muoveva eccome: lo faceva da tempo e sottotraccia. Qualcosa che molti, quasi tutti, fingevano di non vedere.
Nessuno sembrava essersi accorto che fin dagli anni Settanta la nostra cittadina era l’epicentro del contrabbando. Nessuno aveva mai visto scaricare sugli approdi costieri centinaia di casse di sigarette, così come nessuno si era mai reso conto che lo stesso tratto di costa stava diventando il punto di smistamento di un enorme traffico di droga: a Furnari c’era una vera e propria raffineria, gestita direttamente da un tale che chiamavano «’u dutturi» per via della sua passione per la chimica. Il merito di quella generale ignoranza era da attribuirsi a certi rispettabili signori palermitani che sovrintendevano alle operazioni, gente discreta, abilissima a non fare rumore. «’U dutturi» era infatti Francesco Marino Mannoia, un criminale che si era sempre occupato dello smistamento di eroina. All’inizio operava per conto del boss palermitano Stefano Bontate e poi passò con i corleonesi.
Nessuno pareva sapere, per esempio, che Francesco «Ciccio» Rugolo non era il rispettato notabile del luogo, vicino a molti politici importanti. Rugolo operava sì nel campo agricolo ed edilizio, ma dedicandosi a una forma particolare di imprenditoria: l’estorsione. Forse perché avevano bisogno della sua protezione, o forse perché svolgeva le sue attività illecite senza spargimento di sangue, tutti fingevano di non sapere che si trattasse del boss locale. Così come fingevano di non sapere che nessun boss, nemmeno il «galantuomo» Rugolo appunto, poteva comandare un territorio senza essere affiliato a cosche più potenti, nella fattispecie quelle palermitane e catanesi. Il nostro mafioso locale doveva dunque essere collegato quantomeno al clan di Nitto Santapaola, che dominava il capoluogo etneo e da tempo aveva allungato le mani sul messinese, perché quella punta di Sicilia era pur sempre la miglior testa di ponte per espandersi fino alla Calabria.
Si chiudevano gli occhi anche sul manicomio di Barcellona, che dal 1952 era divenuto luogo di detenzione oltre che per i malati veri anche per una particolare tipologia di pazienti: i mafiosi siciliani, calabresi e campani. La sorveglianza, nella struttura, aveva maglie più larghe rispetto alle carceri normali e così, complici attestazioni di presunte infermità mentali, negli anni Settanta e Ottanta molti boss di Cosa Nostra riuscirono a farsi trasferire lì. Il nosocomio divenne dunque una comoda base operativa: i «degenti» mantenevano i contatti con i loro uomini e proseguivano indisturbati il loro «lavoro». Tra i reclusi c’erano per esempio nomi importanti, tra cui Agostino Badalamenti, un giovane condannato a vent’anni per un omicidio che aveva compiuto appena diciottenne. Sarebbe uscito da lì nel 1999 per avviare una fulgida carriera con i corleonesi, diventando reggente del mandamento di Porta Nuova a Palermo, uno dei più prestigiosi, ma già a metà degli Ottanta, in quel manicomio, stava probabilmente ponendo le basi per la sua ascesa. Con lui c’era anche Antonino Santapaola, fratello del più potente Nitto, il vero capo della mafia catanese; facile immaginare che quest’ultimo, presumibilmente in ansia per lo stato di salute del congiunto, andasse spesso a fargli visita.
C’era infine un’altra serie di eventi «invisibili» più o meno a tutti, nonostante accadessero in parte sotto la luce del sole. Negli anni Ottanta Barcellona e i comuni vicini videro una straordinaria fioritura dell’edilizia. Nascevano cantieri un po’ ovunque, era come un’epidemia: c’erano ruspe e gru in ogni angolo. A Furnari, nel 1985 presero il via i lavori di sbancamento e costruzione dei moli turistici di Porto Rosa, un enorme complesso residenziale di lusso di cui si parlava sin dagli anni Settanta e che già aveva attirato la curiosità di numerosi vip dello spettacolo intenzionati a comprare proprio lì la loro casa al mare.
Poi c’erano i lavori per il completamento dell’autostrada che univa Messina a Palermo: l’unica via di raccordo tra i due capoluoghi passava per la costa ed era una miniera a cielo aperto. Sulla medesima tratta era in corso, proprio nello stesso periodo, il raddoppio dell’asse ferroviario, che comportava anche la costruzione di due nuove stazioni: Barcellona e Milazzo.
Insomma: anche da noi stava arrivando il progresso sotto forma di grandi opere. E questo non solo era noto a tutti ma era anche fonte di un certo orgoglio. Mentre la nostra terra si riempiva di operai e mezzi pesanti, nessuno veniva però sfiorato dal dubbio che quei lavori significassero principalmente una cosa: appalti pubblici. E, aspetto ancora più interessante, nessuno sembrava ricordarsi che gli appalti, in una terra come la nostra (e purtroppo non solo lì), equivalevano a un immenso fiume di denaro: fondi che sarebbero piovuti dall’alto per anni e che prima di finire nelle tasche di chi lavorava sarebbero per forza passati per le mani della mafia.
Perché la mafia a Barcellona non c’era, no? Era una zona tranquilla, dove non succedeva nulla, come il resto del messinese: la provincia «babba», l’unico angolo della regione dove la gente era così tonta da non riuscire nemmeno a essere malavitosa.
A mio padre invece queste evidenze non erano sfuggite. E sapeva anche che tutti fingevano, che restavano in silenzio e si rendevano complici. Ma era convinto di non essere il solo a volere che fosse fatta luce, sebbene nessuna voce si leva...