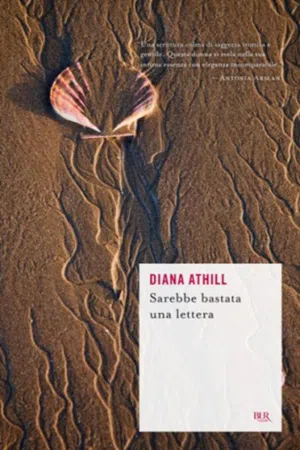1
Mia nonna materna morì di vecchiaia, un processo lungo e doloroso. A novantadue anni il cuore e le arterie cominciarono a mostrare segni di usura, ma solo due anni dopo la abbandonarono per precipitarla, sempre lucida, sempre uguale a se stessa, nell’agonia. Alla fine, il dolore e la stanchezza le avevano fatto allentare la presa sulla vita, tanto che quando si «riprese» dall’ennesimo attacco di cuore chiese con un filo di voce «Perché Dio non mi lascia morire?», ma per diverso tempo fu spaventata da ciò che le stava accadendo. Aveva paura della morte, ed era addolorata, cosa ancora peggiore, perché aveva molto tempo per domandarsi a cosa fosse servita la sua vita, e spesso non trovava risposta.
A quel tempo non stavo molto con lei. Il figlio e le figlie, che vivevano vicino o con lei, si alternavano al suo fianco, ma i nipoti erano sparsi qua e là e la vedevano solo in occasione delle visite in famiglia. Una volta mi capitò di trovarmi a casa sua quando era molto malata e tutti erano più esausti del solito, perciò feci io la notte al suo capezzale. Ero seduta nella sua camera gelida (con le finestre chiuse si sentiva soffocare) e osservavo i suoi occhi infossati e scuri e l’agghiacciante buco nero della sua bocca: era intollerabile che Nonna, sempre così attenta al proprio aspetto, dovesse giacere a bocca spalancata. Ascoltavo il ritmo del suo respiro. Ogni tanto si fermava per un minuto intero e la notte invernale diventava completamente immobile. In quei lunghi silenzi pregavo il suo Dio, «Ti prego, ti prego, fa’ che non riprenda a respirare» e sapevo anche che, se fosse morta, non avrei avuto paura; mi sarei, invece, sentita in pace. Ma ogni volta i respiri faticosi e pesanti ricominciavano, trascinandola verso un nuovo risveglio e un accresciuto dolore e all’umiliazione del corpo malato. Alcune settimane dopo quella notte, quando si era ripresa al punto di scrivere una lettera di veemente protesta al giornale locale per la costruzione di una nuova strada che disapprovava, e di far venire un dentista al suo capezzale per una dentiera nuova, un pomeriggio si girò a guardarmi con i suoi begli occhi screziati e mi disse queste parole: «Per cosa ho vissuto?».
Avrebbe dovuto essere in grado lei di dirlo a me. Per tutta la vita era stata una buona cristiana, un’assidua frequentatrice di chiese, con una fede apparentemente incrollabile. Ma in quel momento doveva cavarsela da sola: non temeva, come il dottor Johnson, le conseguenze di una vita peccaminosa secondo gli insegnamenti della fede; semplicemente non ne ricavava alcun sostegno. Le dissi quello che pensavo: che aveva vissuto, per lo meno, per ciò che era stata la sua vita. I lunghi e difficili mesi dell’agonia potevano oscurare la sua esistenza, ma non l’avrebbero cancellata. Ciò che aveva fatto per noi, la sua famiglia, amando e venendo amata, era ancora reale, avrebbe continuato a esistere, e senza di lei non sarebbe mai esistito. «Pensi davvero che ne sia valsa la pena?» mi domandò, e io le presi le mani e le dissi che lo credevo con tutto il cuore. Poi me ne andai, riflettendo su quella domanda. Per lei avrebbe potuto essere la verità. Aveva davvero creato un mondo per noi. E anche se io fossi stata l’unica, tra i suoi discendenti, a mettere radici in quel mondo (e io, tra tutti, ero probabilmente quella con le radici meno profonde), qualcuna delle cose nate dal suo amore sarebbe rimasta viva. Ma che dire di una donna che non avesse mai avuto la possibilità, o avesse perso l’occasione di creare qualcosa del genere? Che dire di me? Era una domanda in grado di sollevare un vortice di vento gelido, al cui centro mi trovavo io. Aspettavo che cominciassero i brividi.
Be’, non sono ancora cominciati, e mi piacerebbe sapere perché. Questa è precisamente la ragione per cui sono qui seduta a scrivere.
2
È strano pensare di avere amato qualcuno come mia nonna, con la quale mi sono trovata in disaccordo praticamente su tutto ciò che contasse. In chiunque altro, i valori in cui lei credeva mi sarebbero apparsi assurdi o sconvolgenti, eppure eccola lì: la figura dominante nella mia famiglia curiosamente matriarcale, il ricordo di lei riscaldato dall’amore, dalla gioia e dalla gratitudine.
Quando era ragazza, una delle quattro belle figlie del preside di una facoltà di Oxford, giurò che non si sarebbe mai fatta baciare da nessuno, se non dall’uomo che avrebbe sposato, e così fu. Conobbe il suo futuro marito quando lui era ancora studente: un ragazzo dagli occhi azzurri e un vago accento dello Yorkshire, un avvocato tirocinante che non esercitò a lungo, poiché ereditò i beni paterni, e che chiamerò Beckton. Non era dello Yorkshire ma dell’Anglia orientale, dove la famiglia si era trasferita perché si diceva che la madre fosse di costituzione delicata e avesse bisogno di vivere in un clima più mite. In realtà doveva essere stata una donna forte, nonostante le fattezze delicate, perché visse molto a lungo e, anche se il clima dell’Anglia orientale è più mite di quello dello Yorkshire, voglia il cielo che io non debba mai passarci un inverno.
Mia nonna ebbe con il nonno quattro figlie, la minore delle quali era mia madre; e alla fine, quando secondo me un senso di fallimento iniziava ad aleggiare su di lei, un figlio maschio. Disprezzava le donne, o perlomeno ne era convinta. Lei stessa era una donna intelligente, che era stata ben felice di mandare due delle figlie a studiare a Oxford quando ancora non si usava, e fiera di qualunque risultato potessero ottenere le sue nipoti impegnate in lavori poco femminili, eppure diceva sempre che il cervello della donna è inferiore a quello dell’uomo. Qui c’era qualche contraddizione ambigua, perché, pur non mettendo mai in discussione la superiorità maschile, in casa della nonna si respirava un’atmosfera nettamente femminile, e i mariti delle figlie sembravano sempre figure solo di contorno. Su argomenti di pertinenza maschile (la guerra, la politica, una questione di amministrazione locale, la nomina di un ecclesiastico) lei si rivolgeva a qualcuno dei generi con deferenza formale: «Volevo giusto chiederti... dovrei forse scrivere al vescovo?» ma, se aveva intenzione di scrivere al vescovo, l’avrebbe fatto e basta, checché ne dicesse il genero. Non che fosse falsa deferenza, ma forse era un sentimento rivolto a una figura troppo virile e infallibile per essere vera: un modello di mascolinità cui gli uomini reali di famiglia non si adeguavano per niente.
Non so se mio nonno rispondesse a questo modello, perché morì quando avevo sei anni. Se non lo fece, non era colpa di sua moglie. Tutto ciò che so del loro rapporto è che nella biblioteca di Beckton le loro due scrivanie erano sistemate in modo che quella di lui si trovasse accanto al fuoco e quella di lei a congrua distanza, e che, dopo la sua morte, quando la nonna si riferiva a lui era per ammantare di inconfutabilità tutto ciò che aveva detto o fatto. Non ne parlava spesso, ma si riferiva a lui sempre nello stesso modo: «Il Nonno diceva sempre...», ed era così; «Il Nonno non avrebbe mai permesso che i bambini...» e quindi non veniva loro permesso; «Al Nonno piaceva molto...» e quella certa cosa diventava la migliore. Che lei lo avesse adorato era un dogma della famiglia, ma nell’ultimo periodo della sua vita disse una cosa sconcertante a una delle figlie. Stavano parlando della sua paura della morte. «Non capisco perché tu abbia tanta paura» disse la figlia. «Sei sempre stata così religiosa, quindi sicuramente crederai nella vita dopo la morte e che ritroverai papà.» La nonna, sembra, non rispose. Mi raccontarono, però, che «mi guardò in modo molto strano, mi ha davvero spaventata». L’occhiata poteva essere riferita alla vita dopo la morte in generale, ma sua figlia aveva avuto la spiacevole sensazione che si riferisse al nonno.
Cosa so di lui? Che aveva i lineamenti netti dei nordici; che aveva molto gusto e sapeva riconoscere il buon argento e il buon vino; che aveva messo insieme una vasta ed eccellente biblioteca, con particolare riguardo alla storia; che quando ampliò la casa padronale di Beckton, trasformandola in un edificio dalla pianta a U anziché a L, ordinò di costruire una fornace per produrre mattoni come quelli originali della casa, risalente al 1760 circa, e assunse manodopera specializzata per intagliare la pietra che avrebbe abbellito la nuova porta d’ingresso e per creare il drappeggio di gesso che adornava il caminetto in stile Adam nel nuovo salotto. Un uomo di gusto, ma un po’ reazionario. Era il tipo di persona che dà sei penny ai figli per imparare a memoria Lycidas prima degli otto anni, compone un trattato sui serbi (lui li chiamava servi) in una buona imitazione dello stile letterario di Samuel Johnson e viaggia con frugalità dall’Italia alla Grecia, portandosi a casa urne di pietra per il parapetto della terrazza e insistendo affinché i figli che lo hanno accompagnato disinfettino con il permanganato l’acqua di ignota provenienza con cui devono lavarsi i denti. Gestiva in modo sapiente le sue terre. La proprietà di Beckton era di mille acri, in parte affittati a mezzadri, ma per lo più annessi alla Manor Farm, il podere della tenuta. Il nonno aveva a libro paga un amministratore dello Yorkshire, ma la gestione era per lo più compito suo e se la cavava piuttosto bene.
Non ricordo che il nonno mi abbia mai rivolto la parola. I suoi figli lo consideravano intoccabile, proprio come la vedova, e talora ne parlavano anche con affetto. Forse non era proprio un tiranno, ma tutti concordano sul fatto che dominasse la sua proprietà, famiglia inclusa, come per diritto divino, e non penso che mi sarebbe stato simpatico. La morte gli conferì per un certo periodo una sorta di aureola di santità. La sua anima volò fuori da una finestra a ghigliottina aperta e «andò in cielo per restare con Dio», col che si guadagnò la sua parte di benevolenza divina. Dopo di quello si adoperò per fare un miracolo in mio favore, dato che uscii incolume da un cespuglio di ortiche. In primavera, quando raccoglievamo primule per farne mazzetti per il compleanno della nonna, portavamo i più belli sulla tomba del nonno, una semplice lapide di pietra grigia che portava inciso il verso di Milton «Domani a boschi freschi e nuovi pascoli», ma il senso di pietà e amore che accompagnava quell’omaggio era conseguenza dell’atto in sé, anziché essere rivolto alla memoria di un uomo in carne e ossa. E le cose che dovevo a lui – Beckton in quanto luogo dove crescere, i libri in quanto componente indispensabile della vita – molto presto sembrarono elargizioni della nonna e non sue.
Lei continuò a esserci. Dopo colazione indossava un grembiulone e spazzolava i cani sulla terrazza, accanto ai gradini che conducevano alla biblioteca. Con indosso i suoi guanti di cuoio si occupava delle piante nella serra o dei roseti, coglieva fiori da portare in casa e li arrangiava in composizioni nella «stanza dei fiori», dove venivano tenuti i vasi e dormivano i cani. Soleva scrivere lettere su piccoli fogli di carta bordata di nero, in una grafia stenografica che solo le figlie riuscivano a decifrare. Ogni giorno andava a fare lunghe passeggiate e tutte le sere assumeva una dose abbondante di baccelli di senna schiacciati: l’aria fresca e l’intestino in ordine erano, a suo modo di vedere, tutto ciò che serviva per una buona salute. La gestione della casa, che sorvegliava con vigile attenzione, era agevolata dall’abitudine. Verdure, latte, uova e burro provenivano tutti dalla proprietà; si stagionavano i prosciutti, si raccoglieva il miele e si preparava la marmellata in periodi stabiliti, e tutti i mesi si ordinavano generi alimentari diversi per posta, presso i Civil Service Stores di Londra. Era una vita semplice, con i suoi ritmi, in cui lei si occupava della gestione e non dell’esecuzione; quando però, molti anni dopo, si trasferì in una casa più piccola e, a causa dei problemi di reperimento del personale di servizio, sommati a un reddito fisso in continua erosione, fu costretta a fare le cose da sola, ecco che era capace di pulire, spolverare, lucidare l’argenteria e così via molto meglio di noi, che lo facevamo da anni come se fosse la cosa più normale del mondo.
Le gioie della sua vita erano la sua casa e la sua terra, che adorava, la famiglia e la lettura: avrebbe dovuto essere un’esistenza tranquilla. E allora perché l’ansia era un segno distintivo della nonna? Per esempio, nessuno poteva allontanarsi da Beckton senza che dagli occhi di mia nonna trasparisse una sincera tristezza. Anche se si trattava di un viaggio breve, di puro piacere, lei si faceva attanagliare dalla paura. Di certo non avremmo mangiato abbastanza, e avremmo mangiato solo cibo indigesto; avremmo dormito con le finestre chiuse; avremmo preso qualche malattia infettiva; la macchina sarebbe andata fuori strada, il treno sarebbe deragliato. Sarebbero accadute disgrazie varie a chiunque partisse. Ho notato altre volte questo atteggiamento in persone che conducono vite sicure, comode e al riparo del privilegio, dalle quali ci si aspetterebbe che non pensino mai al disastro. Suppongo, sebbene non se ne rendano conto, che sia un riconoscimento delle forze che minacciano la loro posizione. Mia nonna aveva una buona conoscenza della storia e leggeva il «Times» tutti i giorni: sapeva quello che accadeva nel mondo. Guerre e voci di guerra; i comunisti all’estero e i socialisti in patria; l’aumento delle tasse e il declino del rispetto per le tradizioni. Lei, che era una conservatrice, una gentildonna, una devota cristiana protestante e una proprietaria terriera, si metteva automaticamente sulla difensiva contro le forze che non poteva controllare. Non si fidava di ciò che era «fuori» e trasformava la propria diffidenza in un timore per incidenti e alimentazione disordinata. Più e più volte ho sentito lei e altre persone del suo genere dire in tono sinceramente sgomento: «Ma non puoi prendere quel treno, salterai il pranzo!», quasi fossero ossessionate dal valore del cibo per qualche esperienza passata di privazioni o carestia. Nella loro epoca, misurata non con i cucchiaini di caffè ma con piatti di roast beef, pudding di carne e rognoni, torta di mele e panna, mai avevano provato, né si erano aspettati di provare, il morso della vera fame, e quindi da dove veniva questo panico irrazionale, se non era un simbolo di qualcos’altro?
Invecchiando mia nonna divenne sempre più ansiosa, perché convinta che prendersi cura di tutti noi fino alla sua morte fosse nell’ordine giusto e naturale delle cose, ma era chiaro che lei non era in grado di farlo; quando io ero piccola, però, questo era meno evidente. Lei era solo la cara nonnina in ansia, e se la prendevi in giro per questo ti faceva un sorriso mesto, tra il divertito e il pensieroso: «Ridi, ridi pure, se solo tu sapessi!».
Mio padre aveva una famiglia, che però non era la proprietaria di Beckton. Non possedeva neppure un acro di terra. Mio nonno paterno, un religioso che economicamente stava piuttosto bene, si suicidò senza un motivo apparente quando io ero ancora bambina (secondo me non gli avevano consegnato il carbone in tempo: soffriva di pressione alta e andava soggetto a violenti attacchi di collera per questioni di poco conto). Era una «buona» famiglia, tanto quanto quella di mia madre e, pur avendo lasciato l’Anglia orientale da molto tempo, poteva vantare più di quella antiche origini nel nostro amato Paese, poiché esistevano diverse tombe e targhe commemorative a provare l’esistenza di rustici cavalieri Athill, più un pescivendolo, a una rispettabile distanza di tempo. Ciononostante, mia madre riteneva che la famiglia di suo marito fosse inferiore alla propria e, in qualche modo, non saprei neppure dire esattamente come, trasmise quest’idea a noi figli. Era convinta di possedere i nove decimi del valore di qualunque cosa, anche di un cane. Era una donna che amava gli animali in maniera quasi assurda, eppure raramente ammetteva che il cane di qualcun altro fosse bello o di una buona razza. «Non è un brutto cagnolino» diceva, «ma gli verranno le zampe troppo lunghe», oppure «È uno di quei cagnetti isterici, sempre pronti ad agitarsi in presenza di estranei». Allo stesso modo, la famiglia del marito la annoiava e le dava sui nervi. Come quando erano appena sposati e stavano iniziando a emergere dei conflitti di lealtà – con chi dovevano trascorrere il Natale, per esempio? – e lei aveva detto, come una bambina, «Prima io con la mia famiglia», e da allora l’aveva sempre fatta franca.
Per via di Beckton, era stato semplice. Era una casa di venti stanze, al centro di un grande parco con giardino e circondata da mille acri di terra: poteva assorbire la presenza di bambini molto più facilmente di quanto avrebbe potuto mai fare una semplice casetta di sei camere con giardino di due acri, come quella della mia nonna paterna, che viveva nel Devon. Era molto più saggio andare a Beckton per le vacanze. E se uno di noi o dei nostri cugini era stato ammalato, o i nostri genitori erano in viaggio, la nonna di Beckton poteva ospitarci con molto piacere e poco fastidio, mentre la nonna del Devon, per quanto affetto nutrisse per...