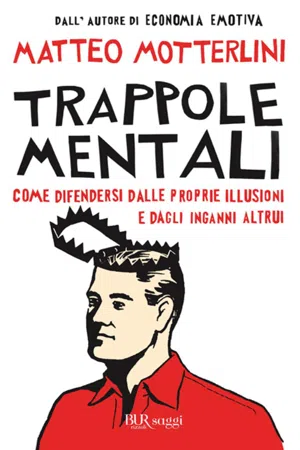![]()
Per saperne di più
Ogni trappola è una piccola sfida con cui mettere alla prova il nostro modo di pensare per svelarne i meccanismi. Volevo che fossero le nostre intuizioni e i processi cognitivi a occupare il centro della scena, e ho preferito non appesantire il testo con indicazioni bibliografiche, note e citazioni, limitandomi all’essenziale. Il lettore che cercasse un maggiore rigore scientifico lo troverà nei libri, capitoli e articoli che contengono gli studi, le ricerche e gli esperimenti a cui rimando puntualmente in questa sezione. Per chi volesse saperne di più, fornisco inoltre una guida ragionata per ulteriori approfondimenti, argomento per argomento.
Introduzione
→ Il termine «inconscio cognitivo» è stato coniato da J. F. Kihlstrom, The Cognitive Unconscious, «Science», 1987, vol. 237, n. 4821, pp. 1445-1452.
→ Kahneman non usa l’espressione ma riprende la distinzione, cara a molti altri autori, tra le operazioni del cosiddetto sistema 1, che «sono rapide, automatiche, non costose in termini di sforzo, associative, e difficili da controllare e modificare»; e del sistema 2, che sono «più lente, seriali, costose in termini di sforzo e deliberatamente controllate […] relativamente flessibili e potenzialmente governate da regole», p. 81 di D. Kahneman «Mappe di razionalità limitata. Indagine sui giudizi e le scelte intuitivi», in M. Motterlini, M. Piattelli (a cura di), Critica della ragione economica, Il Saggiatore, Milano 2005, cap. 2.
→ Sui giudizi e le decisioni come risultato di processi duali e sull’autocontrollo cognitivo: D. Kahneman, S. Frederick, A model of heuristic judgment in K.J. Holyoak, R.G. Morrison (a cura di), The Cambridge handbook of thinking and reasoning, Cambridge University Press, Cambrige 2005, pp. 267-293; e S. Frederick, Automated choice heuristics, in T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (a cura di), Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment, Cambridge University Press, Cambridge 2001, pp. 548-558.
→ Su inconscio psicanalitico e inconscio cognitivo: M. Minsky, Jokes and their Relation to the Cognitive Unconscious in L. Vaina, J. Hintikka (a cura di), Cognitive constraints on communication, Reidel, Dordrecht 1981; M.H. Erdelyi, Freud cognitivista, il Mulino, Bologna 1988; ma soprattutto J. LeDoux, Il cervello emotivo. Alle origini delle emozioni, Baldini e Castoldi, Milano 1998, pp. 31-37, e tutto il libro per quanto riguarda i percorsi cerebrali della paura e la funzione dell’amigdala.
→ Sulla presunta intelligenza dell’inconscio e sull’inconscio «adattivo»: G. Gigerenzer, Gut Feelings, Penguin, New York 2007; e T. Wilson, Strangers to ourselves: Discovering the adaptive unconscious, Harvard University Press. Per una critica, M. Motterlini, Il ventre ha le sue ragioni, «Il Sole-24 Ore», 16 settembre 2007.
→ Per la posizione di Vernon Smith sulla razionalità ecologica come «ordine emergente basato su un processo evoluzionistico culturale e biologico che apprende per tentativi ed errori», vedi la sua Nobel lecture, «Razionalità costruttivista e razionalità ecologica», in M. Motterlini, M. Piattelli (a cura di), Critica della ragione economica, Il Saggiatore, Milano 2005. La citazione è a p. 147.
→ L’immagine dell’evoluzione come un bricolage frutto di tanti piccoli cambiamenti e soluzioni parziali accumulatesi in un lunghissimo arco temporale è di Francois Jacob Evolution and tinkering, «Science», 1977, 196, pp. 1161-1166, quindi ripresa da Richard Dawkins e molti altri.
→ Per la citazione di A. Moro, I confini di Babele. Il cervello e le lingue impossibili, Longanesi, Milano 2006, p. 203.
→ Sull’illusione ottica degli oggetti ombreggiati e i meccanismi cognitivi che la generano: D.A. Kleffner, V.S. Ramachandran, On the perception of shape from shading, Perception and Psychophysics (1992) 52, pp. 18-36; da cui è stata adattata la figura (p. 20 dell’originale). Più in generale, sul modo in cui il cervello va oltre le informazione che riceve dall’occhio, P.Z. Pylyshyn, Seeing and visualizing: It’s not what you think, MIT press, Cambridge 2003; e R. Gregory, Occhio e cervello. La psicologia del vedere, Raffaello Cortina, Milano 1998. Sulle implicazioni delle inferenze inconsce della percezione visiva in chiave di euristiche «adattive» e «intelligenti» vedi ancora G. Gigerenzer, I think, therefore I err, «Social Research», 2005 vol. 72, 1, pp. 1-24.
→ L’esempio del turista che attraversa la strada a Londra, e ciò che sottintende dal punto di vista dei processi cognitivi, si trova in E.K. Miller, J.D. Cohen, An integrative theory of prefrontal cortex function, «Annual Review of Neuroscience», 2001, 24, pp. 167-202.
→ Sulla madre di tutte le trappole ovvero sulla tendenza sistematica con cui le persone sottovalutano il fatto di essere finite intrappolate loro stesse (ma curiosamene si rendono immediatamente conto quando in trappola è finito qualcun altro): E. Pronin, D.Y. Lin, L. Ross, The bias blind spot: Perceptions of bias in self versus others, «Personality and Social Psychology Bulletin», 2002, 28, pp. 369-381; e E. Pronin, M.B. Kugler, Valuing thoughts, ignoring behavior: The introspection illusion as a source of the bias blind spot, «Journal of Experimental Social Psychology», 2007, 43, pp. 565-578.
→ Sul cervello come macchina quasi perfetta: R. Montague, Why choose this book?: How we make decisions, Penguin, New York 2006; riedito nel 2007 con il titolo Your brain is (almost) perfect, Plume, New York.
Ancoraggio
→ Per l’esperimento originario della ruota della fortuna con cui è stata scoperta la trappola, così come per il test della moltiplicazione, si veda il super citato articolo di A. Tversky e D. Kahneman, Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, «Science», 1974, nn. 185, 211, pp. 1124-1130.
→ Il rompicapo del foglio si trova in S. Plous, Psychology of judgment and decision making, McGraw-Hill, New York 1993, cap. 13.
→ L’esempio della data del primo presidente della Repubblica e della temperatura a cui ghiaccia la vodka è adattato da N. Epley e T. Gilovich, Putting adjustment back in the anchoring and adjustment heuristic: self-generated versus experimenter provided anchors, «Psychological Science», 2001, n. 12, pp. 391-396.
→ Per l’esperimento dell’asta con gli studenti del MIT: D. Ariely, G. Loewenstein, D. Prelec, Coherent arbitrariness: Stable demand curves without stable preferences, «Quarterly Journal of Economics», 2003, n. 118, pp. 73-106; e D. Ariely, G. Loewenstein e D. Prelec, Determinants of anchoring effects, «Working Paper», 2000.
→ Per l’esperimento su come ridurre l’effetto: G.B. Chapman ed E.J. Johnson, Anchoring, activation and the construction of value, «Organizational behavior and human decision processes», 1999, vol. 79, pp. 115-153; e The limits of anchoring, «Journal of Behavioral Decision Making», 1994, vol. 7, pp. 223-242.
→ Per non cadere in trappola,T. Mussweiler, F. Strack, T. Pfeiffer, Overcoming the inevitable anchoring effect: Considering the opposite compensates for selective accessibility, «Personality and Social Psychology Bulletin», 2000, n. 26, pp. 1142-1150.
→ Su ancoraggio e giudizio dei professori, J.P. Caverni, J.L. Péris, The anchoring-adjustment heuristic in an «information rich, real world setting»: knowledge assessment by experts, in J.P. Caverni, Jean-Marc Fabre, Michel Gonzalez (a cura di), Cognitive biases, North-Holland, New York 1990.
→ Per un eccellente survey, G.B. Chapman, E.J. Johnson, Incorporating the irrelevant: Anchors in judgments of belief and value, in T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (a cura di), Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment, Cambridge University Press, Cambridge 2002, cap. 6.
→ Per la battuta di Luttazzi: Decameron, La7, 1 dicembre 2007.
Attenzione
→ Per l’esperimento sul batter di ciglia e il cambiamento di immagini, J.K. O’Regan, H. Deubel, J.J. Clark, R.A. Rensink, Picture changes during blinks: Looking without seeing and seeing without looking, «Visual Cognition», 2000, vol. 7, pp.191-211.
→ Per l’esperimento della sostituzione dell’interlocutore, D.J. Simons, D.T. Levin, Failure to detect changes to people in a real-world interaction, «Psychonomic Bulletin and Review», 1998, vol. 5(4), pp. 644-649.
Attribuzione
→ I riferimenti classici per questa trappola sono: L.D. Ross, The intuitive psychologist and his shortcomings: Distortions in the attribution process, in L. Berkowitz (a cura di), Advances in experimental social psychology, Academic Press, New York 1977, vol. 10, pp. 173-220; E.E. Jones, R.E. Nisbett, The actor and the observer: Divergent perceptions of the causes of behavior, General Learning Press, New York 1971.
→ Per l’esperimento degli studenti universitari, R.E. Nisbett, C. Caputo, P. Legant, J. Marecek, Behavior as seen by the actor and as seen by the observer, «Journal of Personality and Social Psychology», 1973, vol. 27, pp. 154-164.
→ Sulla scoperta dell’orbita di Marte e la vita di Kepler è imperdibile A. Koestler, I sonnambuli, Jaca Book, Milano 2002.
Autocompiacimento
→ La storiella filosofica iniziale su Aristippo è di Egesandro di Delphi ap. Ath.8.343d, A. Naucratita, I Deipnosofisti: i dotti a banchetto, Salerno editrice, Roma 2001 (prima traduzione italiana commentata su progetto di Luciano Canfora).
→ Per la scoperta della trappola e i primi esperimenti, D.T. Miller, M. Ross, Self-serving biases in the attribution of causality: Fact or fiction?, «Psychological Bulletin», 1975, vol. 82, pp. 213-225.
→ Su depressi e ottimisti: M. Seligman, L. Abramson, A. Semmel, C. von Baeyer, Depressive attributional style, «Journal of Abnormal Psychology», 1979, vol. 88, pp. 242-247; e J.D. Campbell, Similarity and uniqueness. The effects of attribute type, relevance, and individual differences in self esteem and depression, «Journal of Personality and Social Psychology», 1986, vol. 50, pp. 281-294.
→ Sul self-handicapping, per la definizione e primo esperimento, E.E. Jones, S. Berglas, Control of attributions about the self through self-handicapping strategies: The appeal of alcohol and the role of under achievement, «Personality and Social Psychology Bulletin», 1978, vol. 4, pp. 200-206.
→ Sulle differenze di genere: E.R. Hirt, S.M. McCrea, H.I. Boris, I know you self-handicapped last exam: Gender differences in reactions to self-handicapping, «Journal of Personality and Social Psychology», 2003, 84, pp. 177-193; e How we know what isn’t so: The fallibility of human reason in everyday life, The Free Press, New York 1991, cap. 5.
→ Per l’esperimento con le coppie di sposi, M. Ross, F. Sicoly, Egocentric biases in availability and attribution, «Journal of Personality and Social Psychology», 1979, vol. 37, pp. 322-336.
→ L’aforisma di Leo Longanesi è un «si dice» riferito a Curzio Malaparte.
→ Godibile e molto ben documentata l’esposizione della trappola in C. Fine, Gli inganni della mente. Psicologia delle bugie che raccontiamo a noi stessi, Mondadori, Milano 2006, cap. 1 (dove si citano lo studio sui test di intelligenza e quello sulle suore felici).
→ Per un’esposizione divulgativa, C. Tavris, E. Aronson, Mistakes were made (but not b...