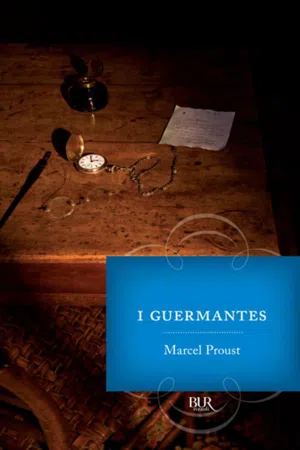PARTE PRIMA
Il cinguettio mattutino degli uccelli sembrava insipido a Françoise. Ogni parola delle «donne» la faceva trasalire, i loro passi la irritavano e suscitavano la sua curiosità; il fatto è che avevamo traslocato. Certo i domestici del sesto piano della nostra vecchia casa non erano meno turbolenti di questi, ma quelli lei li conosceva; i loro andirivieni le erano divenuti famigliari. Ora prestava un’attenzione dolorosa perfino al silenzio. E siccome il nostro nuovo quartiere appariva quieto quanto il viale sul quale si affacciava la nostra casa di prima era rumoroso, la canzone (percepita anche da lontano, quando è flebile come un motivo d’orchestra) di qualcuno che passava faceva salire le lacrime agli occhi di Françoise in esilio. Inoltre, se mi ero preso gioco di lei che, desolata di dover abbandonare un palazzo dove eravamo «così ben stimati dappertutto», aveva fatto i bagagli piangendo secondo il rituale di Combray, e dichiarando la migliore delle case esistenti quella che era stata la nostra, in compenso, io che assimilavo con tanta difficoltà le cose nuove quanto con facilità abbandonavo le vecchie, mi riavvicinai alla nostra anziana domestica quando mi accorsi che per lei insediarsi in una casa dove non aveva ricevuto dal portiere che ancora non ci conosceva gli attestati di considerazione necessari alla sua buona nutrizione morale, l’aveva gettata in uno stato prossimo al deperimento. Era l’unica che poteva capirmi. Non ci sarebbe certo riuscito quel suo giovane aiutante; per lui che era tanto poco di Combray, traslocare, andare ad abitare in un altro quartiere era come prendersi una vacanza dove ogni novità era riposante quanto un viaggio; credeva di essere in campagna; e un raffreddore di testa gli diede, come un colpo d’aria preso in treno dove un finestrino non chiuda bene, l’impressione deliziosa di aver visto un po’ di mondo; ad ogni starnuto si rallegrava di aver trovato un posto tanto chic, avendo sempre desiderato dei padroni che viaggiassero molto. Così, senza curarmi di lui, andai direttamente da Françoise; siccome avevo riso delle sue lacrime a una partenza che m’aveva lasciato indifferente, lei si mostrò gelida davanti alla mia tristezza perché la condivideva. L’egoismo dei nervosi cresce con la loro pretesa sensibilità; non possono sopportare da parte degli altri l’esibizione di malesseri ai quali prestano, quando si tratta di loro stessi, la massima attenzione. Françoise, che non lasciava passare il più lieve di quelli che lei provava, se ero io a soffrire voltava la testa perché non avessi la soddisfazione di vedere la mia sofferenza compatita, nemmeno notata. Si comportò allo stesso modo quando volli parlarle della nostra nuova casa. Del resto, in capo a due giorni, avendo dovuto andare a cercare degli indumenti dimenticati nell’appartamento che avevamo appena lasciato, mentre io, in seguito al trasloco, avevo ancora un po’ di «temperatura» e, simile a un grosso serpente che avesse inghiottito un bue, mi sentivo penosamente ammaccato a causa di un’enorme cassapanca che la mia vista doveva «digerire», Françoise, con l’infedeltà tipica delle donne, ritornò dicendo che le era sembrato di soffocare sul nostro viale di prima, che per recarvisi si era trovata tutta «fuori strada», che mai aveva visto scale più scomode, e che non sarebbe ritornata ad abitare là «nemmeno se le avessero offerto un impero o dei milioni» — ipotesi gratuite — e che tutto (vale a dire ciò che concerneva la cucina e i corridoi) era molto meglio «arrangiato» qui, nella nostra nuova casa. Ora, è tempo di dire che questa — e noi ci eravamo venuti ad abitare perché la nonna che non stava troppo bene aveva bisogno di aria più pura, ragione che ci eravamo ben guardati dal dirle — era un appartamento che faceva parte del palazzo dei Guermantes.
All’epoca in cui i Nomi, dandoci l’immagine dell’inconoscibile che in essi abbiamo riversato, nel momento stesso in cui designano per noi anche un luogo reale, ci obbligano a identificare l’uno con l’altro al punto che partiamo per cercare in una città un’«anima» che essa non può contenere ma che non abbiamo più il potere di espellere dal suo nome, non conferiscono un’individualità soltanto alle città e ai fiumi come fanno le pitture allegoriche, non soltanto screziano di sfumature diverse, popolano di meraviglioso l’universo fisico ma anche l’universo sociale; allora ogni castello, ogni dimora o palazzo famoso avrà la sua dama o la sua fata come le foreste i loro geni e le acque le loro divinità. A volte, nascosta in fondo al suo nome, la fata si trasforma seguendo il capriccio della nostra immaginazione che la nutre; così l’atmosfera in cui Madame de Guermantes esisteva in me, dopo esser stata per anni nient’altro che il riflesso di un vetro di lanterna magica e di una vetrata di chiesa, cominciava a spegnere i suoi colori quando fantasie tutte diverse l’impregnarono della schiumosa umidità dei torrenti.
Tuttavia la fata si estingue se ci avviciniamo alla persona reale alla quale corrisponde il suo nome, perché il nome quella persona comincia a rifletterla ed essa non ha in sé niente della fata; la fata può rinascere se noi ci allontaniamo dalla persona ma se restiamo accanto a lei la fata muore definitivamente e con lei il nome, come quella famiglia di Lusignano che doveva estinguersi il giorno in cui sarebbe scomparsa la fata Melusina. Allora il Nome, sotto i cui successivi strati di colore potremmo finire col ritrovare all’origine il bel ritratto di un’estranea mai conosciuta, non è più che la semplice fotografia alla quale ci riferiamo per identificare, per sapere se conosciamo, se dobbiamo o no salutare una certa persona che passa. Ma se una sensazione del passato — come quegli strumenti musicali meccanici che mantengono il suono e lo stile dei differenti artisti che li suonarono — permette alla nostra memoria di farci risentire quel nome con il timbro particolare che aveva per il nostro orecchio a suo tempo, allora in quel nome, apparentemente immutato, sentiamo la distanza che separa l’una dall’altra le fantasie che rappresentarono successivamente per noi le sue sillabe rimaste sempre uguali. Per un istante nel risentire il cinguettio che esso aveva in quella tal lontana primavera possiamo estrarre, come dai tubetti di colore che usiamo per dipingere, la sfumatura giusta, dimenticata, misteriosa e fresca dei giorni che avevamo creduto di ricordare quando, come certi cattivi pittori, davamo a tutto il nostro passato, steso su una medesima tela, i toni convenzionali e monotoni della memoria volontaria. Ora, al contrario, ognuno dei momenti che composero quel passato usava, per una originale creazione, armoniosamente omogenea, i colori di allora che non conosciamo più e che mi riempiono ancora d’improvvisa meraviglia, se, per esempio, per un caso qualsiasi, il nome di Guermantes, avendo ripreso per un istante dopo tanti anni il suono, così diverso da quello di oggi, che aveva per me il giorno del matrimonio di Mademoiselle Percepied, mi restituisce quel color malva così dolce, troppo brillante, troppo nuovo, che dava riflessi vellutati alla cravatta rigonfia della giovane duchessa e ai suoi occhi illuminati di un azzurro sorriso, come una pervinca impossibile a cogliersi e rifiorita. Per me il nome di Guermantes di allora è anche come un palloncino in cui sia stato compresso un po’ d’ossigeno o qualche altro gas: quando riesco a farlo scoppiare e a farne uscire il contenuto, respiro l’aria di Combray di quell’anno, di quel giorno, mista a quel profumo di biancospini portato dal vento foriero di pioggia che soffiava dall’angolo della piazza e successivamente faceva scomparire il sole o lo lasciava espandersi sul tappeto di lana rossa della sacrestia accendendolo di una tinta brillante, quasi rosa, di geranio, e di quella dolcezza, per così dire wagneriana, nell’allegria, che conferisce tanta nobiltà al giorno di festa. Ma anche al di fuori di simili rari momenti in cui sentiamo l’entità originale trasalire bruscamente e riprendere la sua forma e la sua cesellatura dentro le sillabe ormai morte, se nel turbinio vertiginoso della vita di tutti i giorni, in cui i nomi, non avendo più che una funzione essenzialmente pratica, hanno perso ogni colore come una trottola prismatica che girando troppo velocemente ci appaia di colore grigio, in compenso quando nell’immaginazione riflettiamo, cerchiamo, per riandare al passato, di rallentare, di sospendere il movimento perpetuo in cui siamo trascinati, a poco a poco rivediamo apparire, giustapposti ma completamente distinti gli uni dagli altri, i colori che nel corso della nostra esistenza ci ha presentato successivamente uno stesso nome.
Veramente non so quale forma si delineasse ai miei occhi in quel nome di Guermantes, quando la mia balia — che probabilmente ignorava, al pari di me oggi, in onore di chi era stata composta — mi cullava con quella vecchia canzone: Gloria alla marchesa di Guermantes o quando, qualche anno più tardi, il vecchio maresciallo di Guermantes agli Champs Elysées riempiendo la mia «bambinaia» d’orgoglio, si fermava dicendo: «Che bel bambino!» ed estraeva da una bomboniera tascabile un cioccolatino. Quegli anni della mia prima infanzia non sono più in me, mi sono esterni, non posso saperne nulla, se non, come per i fatti che hanno avuto luogo prima della nostra nascita, dai racconti degli altri. Ma più tardi, trovo successivamente, perii tempo in cui perdurò in me quello stesso nome, sette o otto immagini diverse; le prime erano le più belle: a poco a poco il mio sogno costretto dalla realtà ad abbandonare una posizione insostenibile, all’inizio si era soltanto parzialmente ritirato, ma poi dovette indietreggiare ancora. E, contemporaneamente a Madame de Guermantes, mutava anche la sua dimora, anch’essa scaturita da quel nome che veniva fecondato di anno in anno dalla tale o tal’altra frase che mi capitava di udire e che modificava le mie fantasticherie: quella dimora le mie fantasticherie le rispecchiava nelle sue stesse pietre divenute riflettenti come la superficie di una nube o di un lago. Un torrione senza spessore che non era che una striscia di luce aranciata e dall’alto della quale il signore e la sua dama decidevano della vita e la morte dei loro vassalli, aveva lasciato il posto — al termine di quella «parte di Guermantes» dove, in tanti bei pomeriggi, seguivo con i miei parenti il corso della Vivonne — a quella terra percorsa da torrenti dove la duchessa mi insegnava a pescare le trote e a conoscere i nomi di quei fiori dai grappoli violetti e rossastri che ornavano i muretti degli orti circostanti; poi c’era stata la terra ereditaria, il poetico dominio in cui quella razza altera dei Guermantes, come una torre biondeggiante e fiorita che passi attraverso i secoli, si innalzava già sulla Francia quando il cielo era ancora vuoto là dove, più tardi, dovevano sorgere le cattedrali di Notre-Dame de Paris e Notre-Dame de Chartres; quando sulla sommità della collina di Laon la nave della cattedrale non si era ancora posata, come l’Arca del Diluvio, sulla cima del monte Àrarat, piena di Patriarchi e di Giusti ansiosamente affacciati alle finestre per vedere se la collera di Dio si fosse placata, carica di tutti i tipi di vegetali che avrebbero fruttificato moltiplicandosi sulla terra, traboccante di animali fuggenti fuori dalle torri dove si vedono dei buoi passeggiare tranquillamente sui tetti»?1, contemplando dall’alto le pianure della Champagne; quando il viaggiatore che lasciava Bouvais, al termine della giornata, non vedeva ancora le fiancate nere e ramificate della Cattedrale seguirlo lungo le curve della strada sullo sfondo dorato del tramonto. Quel nome, Guermantes, era come la cornice di un romanzo, un paesaggio immaginario che stentavo a rappresentarmi e tanto più desideravo scoprirlo, rinchiuso in mezzo a terre e strade reali che di colpo a due leghe da una stazione si sarebbero impregnate di particolarità araldiche; mi tornavano in mente i nomi delle località vicine quasi fossero ai piedi del Parnaso o dell’Elicona, e mi sembravano preziose come le condizioni materiali che — in topografia — provocano un fenomeno misterioso. Rivedevo gli stemmi dipinti alla base delle vetrate di Combray e di cui i quarti si erano riempiti, di secolo in secolo, di tutte le signorie che attraverso matrimoni o acquisizioni, quell’illustre casato aveva fatto accorrere a sé da ogni angolo della Germania, dell’Italia e della Francia: terre immense del Nord, città potenti del Mezzogiorno, venute a ricongiungersi e a comporsi in Guermantes, e, perdendo la loro materialità, a iscrivere allegoricamente il loro torrione di smalto verde o il loro castello d’argento in campo azzurro. Avevo sentito parlare dei celebri arazzi di Guermantes e me li immaginavo medioevali e blu, un po’ rozzi, stagliarsi come una nube sul nome amaranto e leggendario, ai piedi dell’antica foresta dove tanto spesso Childeberto si recava a cacciare, e mi sembrava che avrei potuto facilmente penetrare, come viaggiando, nel segreto profondo e misterioso di quelle terre e di quei secoli lontani soltanto avvicinando un istante, a Parigi, Madame de Guermantes, sovrana del luogo e signora del lago, come se il suo volto e le sue parole avessero dovuto possedere il fascino locale delle foreste e delle rive e le stesse particolarità secolari conservate nelle vecchie raccolte di carte dei suoi archivi. Ma allora avevo conosciuto Saint-Loup, che mi aveva informato che il castello aveva assunto il nome Guermantes soltanto dal XVII secolo quando la sua famiglia l’aveva acquistato. Questa aveva risieduto fino allora nei dintorni e il suo titolo non veniva da quella regione. Il villaggio di Guermantes aveva preso il nome dal castello accanto al quale era stato costruito e, affinché non ne venisse distrutta la prospettiva, una «servitù» rimasta in vigore regolava il tracciato delle strade e limitava l’altezza delle case. Quanto agli arazzi, erano di Boucher, acquistati nel XIX secolo da un Guermantes appassionato di queste cose, ed erano stati collocati a fianco di mediocri quadri di caccia che lui stesso aveva dipinto, in un orrendo salone tappezzato di tessuto di raso rosso e di peluche. Con queste rivelazioni Saint-Loup aveva introdotto nel castello elementi estranei al nome di Guermantes che non mi permisero più di continuare a estrarre unicamente dalla sonorità delle sillabe la materia delle costruzioni. Allora, al fondo di quel nome si era cancellato il castello riflesso come in un lago e, attorno a Madame de Guermantes, come sua dimora, era apparso il palazzo di Parigi, il palazzo Guermantes limpido come il suo nome, infatti nessun elemento materiale ed opaco ne veniva a interromperne o ad appannarne la trasparenza. Come la chiesa non significa soltanto il tempio ma anche l’accolta dei fedeli, quel palazzo di Guermantes comprendeva tutti coloro che condividevano la vita della duchessa; ma tutte quelle persone che non avevo mai visto erano per me soltanto nomi famosi e poetici, e, conoscendo a loro volta soltanto persone che non erano nient’altro che nomi, non facevano che accrescere e proteggere il mistero della duchessa, stendendo attorno a lei un immenso alone che andava via via attenuandosi.
Nelle feste che dava Madame de Guermantes, siccome non riuscivo ad attribuire nell’immaginazione agli invitati, né corpo, baffi, scarpe, nessuna frase da essi pronunciata che fosse banale o magari anche originale in maniera umana e razionale, quel turbinio di nomi, infondendo meno realtà di quanto non avrebbe fatto una cena di fantasmi o un ballo di spettri intorno a quella statuina in porcellana di Sassonia che era Madame de Guermantes, serbava una trasparenza di bacheca al suo palazzo di vetro. Poi quando Saint-Loup mi ebbe raccontato alcuni aneddoti relativi al cappellano, ai giardinieri di sua cugina, il palazzo Guermantes era diventato — come forse era stato un tempo il Louvre — una specie di castello, circondato, nel cuore della stessa Parigi, dalle sue terre, possedute ereditariamente in virtù di un diritto antico che bizzarramente sopravviveva, e sulle quali lei esercitava ancora alcuni privilegi feudali. Ma quest’ultima dimora era anch’essa svanita quando eravamo venuti ad abitare vicino a Madame de Villeparisis, in un appartamento accanto a quello di Madame de Guermantes, in un’ala del suo palazzo. Era una di quelle antiche case, come ne esistono forse ancora, e nelle quali il cortile d’onore — sia per le alluvioni recate dalla marea montante della democrazia, o per lasciti di tempi più antichi per i quali i diversi mestieri erano raggruppati intorno al signore — aveva spesso, lungo i suoi lati, dei retrobottega, dei laboratori, perfino qualche botteghina di calzolaio o di sarto, come quelle che si vedono addossate alle fiancate delle cattedrali che l’e...