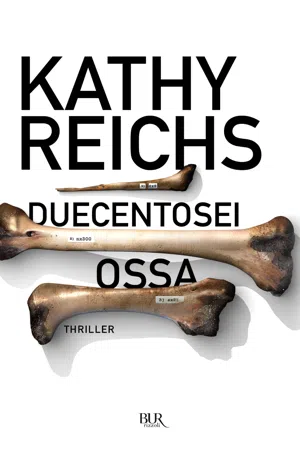![]()
1
Freddo.
Torpore.
Confusione.
Aprii gli occhi.
Buio. Più buio di un inverno artico.
Sono morta?
Obbedendo a un qualche stimolo del sistema limbico, inspirai a fondo.
Il mio cervello registrò degli odori.
Muffa. Terra umida. Qualcosa di organico che evocava il trascorrere del tempo.
Ero all’inferno? In una tomba?
Mi misi in ascolto.
Silenzio. Impenetrabile.
No… dei rumori c’erano: il sibilo dell’aria attraverso le mie narici, il sangue che martellava nelle orecchie.
I cadaveri non respirano. I cuori dei morti non battono.
Sopraggiunsero altre sensazioni: la durezza della terra sotto di me e un bruciore sul lato destro del volto.
Sollevai la testa.
Sentii la bile inondarmi la bocca.
Spostai il bacino per alleviare la pressione sul collo piegato.
Un dolore lancinante esplose nella mia gamba sinistra.
Un gemito ruppe il silenzio.
Istintivamente, il mio corpo si raggomitolò in posizione fetale. Il martellare si fece più forte.
Restai così, ripiegata su me stessa, ad ascoltare il ritmo della mia paura.
Poi capii: il lamento era uscito dalla mia stessa gola.
Sento dolore. Reagisco. Sono viva.
Ma dove sono?
Sputando bile, cercai di allungare la mano, ma sentii che qualcosa la bloccava. Avevo i polsi legati.
Provai a sollevare un ginocchio al petto: i piedi salirono, entrambi, i polsi furono trascinati verso il basso.
Tentai una seconda volta, con più forza: i neuroni si eccitarono nuovamente lungo la gamba.
Soffocando un altro grido di dolore, mi sforzai di imporre un po’ d’ordine nel caos della mia mente.
Ero stata legata, le mani ai piedi, e abbandonata. Dove? Quando? Da chi? Perché?
Scandagliai invano la memoria alla ricerca di fatti recenti. Ma il vuoto mi portava troppo lontano.
Ricordavo un picnic con mia figlia Katy, ma era d’estate: la temperatura, ora, suggeriva il gelo invernale.
Tristezza. Un ultimo addio a Andrew Ryan. Era stato in ottobre. L’avevo più rivisto?
Un maglione rosso a Natale. Natale di che anno? Non ne avevo idea.
Disorientata, vagai con la memoria in cerca di un dettaglio recente: tutto era sfocato.
Vaghe sensazioni irrazionali apparvero e poi svanirono. Una figura che emergeva dall’ombra. Uomo o donna? Rabbia. Grida. Per che cosa? Contro chi?
Neve che si scioglie. Schegge di luce su vetri rotti. Le fauci oscure di una porta socchiusa.
I vasi dilatati pulsavano contro le pareti del mio cranio. Per quanto mi sforzassi, non un ricordo affiorava dalla mia mente in stato di semincoscienza.
Ero stata drogata? Colpita alla testa?
La gamba era messa davvero così male? Sarei riuscita a camminare? O almeno a strisciare?
Le mani erano intorpidite, le dita inutili. Con uno strattone cercai di divaricare i polsi: nessun segno di cedimento delle corde.
Lacrime di frustrazione mi bruciarono l’interno delle palpebre.
Vietato piangere!
Serrando la mascella, ruotai sulla schiena, sollevai i piedi e divaricai di scatto le caviglie. Un bruciore insopportabile divampò lungo l’arto inferiore sinistro.
Poi il nulla.
Mi risvegliai. Mesi dopo? Ore? Impossibile dirlo. Avevo la bocca più secca, le labbra più aride. Il dolore alla gamba si era trasformato in un indolenzimento sordo.
Nemmeno lasciare alle pupille il tempo di abituarsi all’oscurità servì a qualcosa. Come potevano adattarsi? Non c’era un filo di luce in quel nero denso.
Le stesse domande si ripresentarono alla mia mente. Dove? Perché? Chi?
Evidentemente ero stata sequestrata. Ero vittima di un gioco perverso o di un preciso disegno di morte?
Quel pensiero innescò un primo ricordo distinto: la foto di un’autopsia, un cadavere carbonizzato, le mascelle spalancate in un ultimo grido d’agonia.
Poi un susseguirsi convulso di immagini. Due obitori. Due sale autopsia. Le targhe sulla porta di due laboratori. TEMPERANCE BRENNAN, ANTROPOLOGA FORENSE. TEMPERANCE BRENNAN, ANTHROPOLOGUE JUDICIAIRE.
Ero a Charlotte? Davvero troppo freddo per il North Carolina, anche in inverno. Ma era inverno? Mi trovavo nel Québec?
Ero stata aggredita in casa? Per strada? In macchina? Davanti all’Édifice Wilfrid-Derome? Al laboratorio?
Ero stata scelta per caso dal mio aguzzino? O qualcuno mi aveva presa di mira a causa del mio mestiere? Poteva essere la vendetta di un ex condannato o di un parente con la fissazione del complotto. A quale caso avevo lavorato ultimamente?
Dio, quel luogo era così freddo, e buio, e silenzioso.
E perché quell’odore, di una familiarità allarmante?
Cercai nuovamente di divincolare le mani e i piedi. Invano. Non riuscivo nemmeno a mettermi a sedere.
«Aiuto! Sono qui! Qualcuno mi aiuti!»
Urlai fino a ridurmi la gola in fiamme.
«C’è qualcuno? Per favore…»
Le mie invocazioni rimasero inascoltate.
Il panico minacciava di sopraffarmi.
Non morirai senza reagire!
Tremando per il freddo e la paura, smaniando di tornare a vedere, mi misi sul dorso e cominciai a dimenare i fianchi, tendendo le mani il più possibile verso l’alto, cercando di non pensare al dolore lancinante alla gamba. Una spinta, due, tre. La punta delle dita sfiorò qualcosa di duro poco più di trenta centimetri sopra la mia faccia.
Mi allungai ancora. Contatto. Una pioggia di pietrisco mi finì negli occhi, in bocca.
Sputacchiando e sbattendo le palpebre, ruotai sul fianco destro e mi spinsi indietro con un braccio e i piedi. Il suolo accidentato mi escoriava la pelle del gomito, delle ginocchia. La caviglia levò un grido di protesta. La ignorai: dovevo muovermi. Dovevo uscire di lì.
Avevo percorso un brevissimo tratto quando incontrai una parete: forme rettangolari con della malta intorno. Mattoni.
Il cuore batteva all’impazzata, ruotai sull’altro fianco e arrancai nella direzione opposta. Di nuovo, urtai quasi subito un muro.
L’adrenalina mi inondò il corpo mentre il terrore si sommava al terrore. Il sangue mi si gelò nelle vene, dai polmoni uscivano solo brevi respiri affannosi.
La mia prigione era alta non più di cinquanta centimetri e larga meno di due metri! Poco importava la lunghezza: sentivo le pareti premere su di me.
Persi il controllo.
Trascinandomi in avanti, cominciai a gridare e a battere i pugni contro la parete. Le lacrime mi rigavano le guance. Chiamai, più e più volte, sperando di attirare l’attenzione di un passante, un operaio, un cane.
Quando mi fui scorticata le nocche, iniziai a usare i palmi. E quando non riuscii più ad agitare le braccia, ruotai su me stessa e presi a picchiare con i piedi.
Dall’anca mi partì un dolore lacerante. Insopportabile. Le grida di a...