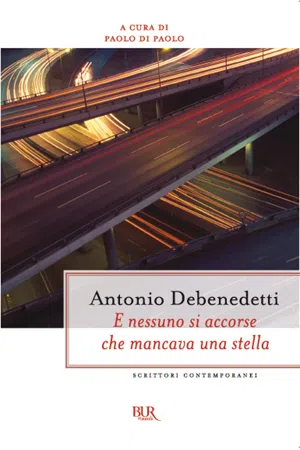![]()
Italia appena ieri
![]()
E fu settembre
Un sabato mattina del settembre 1938, quantunque sulle bancarelle del mercato facesse invitante mostra di sé la prima uva pizzutella, la sua preferita, Enrichetto Norzi tirò via, gettando appena uno sguardo ai grappoli d’un invitante verde dorato e tornò a tuffare precipitosamente gli occhi nel giornale. Che disastro! Sulla prima pagina del “Messaggero” si leggeva infatti una notizia purtroppo attesa ma ugualmente inaccettabile. Gli insegnanti e gli scolari di razza ebraica, informava già un titolone a otto colonne, erano adesso esclusi dalle scuole di ogni ordine e grado. Quindi, nel sommario, si precisava con odiosa puntualità burocratica che il provvedimento riguardava anche “Accademie, Istituti e Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti”.
«Incredibile, davvero incredibile!» non riusciva a trattenersi dal dar sfogo al suo sbigottimento Enrichetto, riguadagnando casa e manifestando senza accorgersene quel suo sconcerto anche a voce alta. E da qualche momento l’inquietudine, che lo alterava, aveva una testimone nella persona di Clotilde Bonifazi. Una zitella, una donnetta di chiesa, presso cui Norzi aveva preso alloggio dall’anno successivo al suo trasferimento a Roma, vale a dire da un quinquennio o quasi. Allarmata, se non ancora esterrefatta, Clotilde lo stava osservando già pronta a una rapida ritirata.
«Possibile? Un tipo sempre così rispettoso, così controllato» si stupiva e un poco anche si scandalizzava quella creatura grigia, minuta, ritratto vivente della prudenza e della solerzia. Non era tanto la paura a turbarla, in quel momento, quanto l’idea di dover rivedere il giudizio che era venuta formandosi del suo inquilino.
Quello che la Bonifazi aveva accolto sotto il proprio tetto, dopo non poche esitazioni e ripensamenti, si era difatti mostrato, poi confermato un pensionante irreprensibile. Da portare a esempio qualora Clotilde avesse avuto a chi fornire degli esempi. Ma quel qualcuno le mancava. Che fare? Ecco il punto. Come sostituire Norzi se qualcosa, chissà che cosa, lo avesse indotto d’improvviso a cambiare contegno e a imbarbarirsi?
«Non riesco a mandarla giù, proprio non riesco. Che cosa dà a quei signori il diritto di trattare così noi ebrei? Siamo uomini come gli altri, italiani come tutti quelli che vivono, lavorano e muoiono in questo paese. O sbaglio? Abbiamo mostrato di saper essere grandi artisti, grandi scienziati» insisteva frattanto Enrichetto, evidentemente fuori di sé.
Sospettosa e guardinga come una gatta troppo grossa, una gattona dal pelo bianco cosparso di un paio o tre voglie color caffellatte, Clotilde aveva fino a quell’istante osservato la scena standosene affacciata sull’uscio della cucina. Un piede di qua e l’altro di là della soglia. Poi, quasi avesse capito che non era questione da potersi sbrigare alla svelta quella che ispirava a Enrichetto tali e tante espressioni di sbalordita riprovazione, la donna aveva ritenuto opportuno reagire. Come fosse tornata pienamente padrona di sé, anche se così non era, si era accostata alla tavola che arredava il tinello. Aveva però dimenticato, tanta era ancora la sua emozione, di posare una carota che teneva in mano assieme al coltello per pulirla.
«È un’infamia, mi creda, signorina Bonifazi, quella che i fascisti si preparano a commettere!» ripeteva frattanto Norzi, guardando fissamente la padrona di casa, quasi volesse sollecitarla a esprimere una parola di solidarietà o almeno di conforto.
La Bonifazi, che alla parola “fascisti” era trasalita, non sapeva ancora che cosa pensare né quale orientamento prendere. Così, quasi a tangibile espressione del suo interrogarsi senza trovare risposta, aveva cominciato a girare attorno al suo inquilino. Faceva un mezzo giro, si fermava e senza averne consapevolezza riprendeva a camminare inquisitiva e impaziente attorno a Enrichetto. I suoi occhi intanto, come smorzati dall’abitudine a posarsi senza neppure vederlo sul solito scenario domestico, si sarebbe detto custodissero a fatica una domanda che ne portava con sé almeno altre due. “Parliamoci chiaro, sor Enrico. Lei è nei guai? Ha fatto qualcosa che non doveva?”, “Quali saranno le conseguenze immediate di quanto sta accadendo?”, “Può esserci un pericolo anche per me?”.
Norzi frattanto continuava a tenere “II Messaggero” teatralmente aperto, anzi spalancato davanti a sé. Certe umiliazioni, si diceva, prima bruciano quindi si rivelano gradatamente in tutta la loro dolente, insidiosa gravità.
«Beva!» La Bonifazi, ben sapendo che a mostrarsi caritatevoli non si sbaglia mai, si era provveduta con cristiana pietà d’un bicchiere colmo d’acqua. «Beva, le farà comunque bene!» tornò a raccomandare quella sacrestana mancata.
Dopo aver inghiottito a fatica un paio di sorsi, Norzi si schiarì la voce. Si ascoltò quindi leggere alla donna quel che già tante volte quella mattina aveva letto e riletto.
«Fra tutti i provvedimenti deliberati dal Consiglio dei Ministri di ieri è di gran lunga il più significativo quello che si riferisce alla difesa della razza nel campo della scuola. La difesa della razza avrebbe un senso limitato qualora…» Norzi alzò leggermente il tono e tornò a ripetere «…qualora si limitasse a una semplice tutela fisica. La biologia non deve far dimenticare la psicologia, l’educazione fisica quella spirituale. Non sono ammissibili antitesi e contraddizioni quando si tratta dell’avvenire del popolo italiano…»
Enrichetto si chiedeva frattanto, pur continuando a leggere, se la tristezza, una sconfinata tristezza avrebbe vinto in lui sull’angoscia o se sarebbe stata quest’ultima a vincere sulla tristezza. O a prendere il sopravvento sarebbe stata invece la vergogna del cane bastonato? Si figurava persino le parole che sarebbero puntualmente tornate ad attizzare la coscienza di quell’onta: “Io sono, io rappresento quell’ebreo che gli ariani non vogliono, che si schifano di vedere a fianco dei loro figli nelle scuole! Sì, proprio così, si schifano!”.
Ormai Enrichetto era giunto alle ragioni del provvedimento così come le illustrava, peggio ancora le giustificava quel dannato articolo. «…Il Regime procede sempre più verso l’attuazione dei suoi principi fondamentali, che esigono un metodo severo e coerente. Non sono ammissibili deviazioni, specie in un momento storico come l’attuale, che è senza dubbio contrassegnato dalla lotta fra due opposte concezioni della vita: da una parte i valori millenari di origine ariana, che hanno promosso la civiltà occidentale, attraverso le gloriose imprese di Atene, di Roma, del Rinascimento italiano; dall’altra la negazione tipicamente semitica, che è il presupposto teoretico e morale di tutte le rivoluzioni e che oggi, sotto il potente reagente fascista, perviene alle estreme conseguenze della propria logica, al bolscevismo, abbandonando quelle posizioni medie, che per lungo tempo simularono l’insidia corrosiva di una mentalità immutabile…»
Fosse stato solo, Enrichetto avrebbe pianto e quel suo pianto si sarebbe esaurito in pochi singulti disperati. Avrebbe pianto in nome dei suoi avi umiliati nelle loro tombe, in nome di quella madre che gli aveva dato la vita per vederlo trattare così! Si sarebbe lasciato andare sopraffatto dallo sgomento che sentiva già soffiare come vento tempestoso sugli interrogativi senza risposta che venivano affollandosi in modo disordinato, tumultuoso nella sua mente. Che cosa doveva o poteva fare per difendersi, per non lasciarsi annullare?
Enrichetto aveva, però, precisa coscienza di non essere solo e avvertiva, quantunque in modo confuso, di dover stringere i denti e drizzare la schiena. A imporgli quella recita era la presenza della Bonifazi, di quella mite e sbiadita creatura con cui aveva condiviso cinque anni di silenzi, di sguardi che non erano mai riusciti a suggerire altro che un inconcludente, casto e timido desiderio di comunicare. Così, pur essendo giunto ad avere una certa dimestichezza con la sua padrona di casa, Norzi non poteva tuttavia dire di conoscerne l’animo. Prudenza, dunque! Il minimo errore, lo sbaglio più insignificante avrebbe potuto avere, in quel momento e in quella precisa congiuntura, conseguenze anche gravi.
Proprio dalla signorina Clotilde, andava rapidamente convincendosi Enrichetto, sarebbe dipeso per lui, in un domani non lontano, qualcosa di più che un tetto e una sistemazione logistica. Chi non ha più diritti, c’è poco da fare, viene a trovarsi alla mercé di tutti e deve saperlo. Eccome!
Enrichetto capì di doversi tenere a ogni costo buona quell’innocua donnetta, di doverla blandire e assecondare come fosse un’autorità. Questo fu il primo avvertimento giunto da un futuro buio e fu l’avvio d’una graduale, sempre più invasiva consapevolezza di essere un cittadino di seconda scelta e, dunque, di doversi considerare un essere umano appena tollerato e senza peraltro ispirare mai, o quasi mai, vera tolleranza.
In quel preciso momento Norzi avvertì, come sarebbe più tardi tornato a succedergli, di dipendere da quella comprensione altrui che spesso è figlia d’un capriccio estemporaneo e coincide con uno sguardo, con un sì o un no che passano veloci nell’espressione.
Tutto questo contribuì a fargli apparire la signorina Clotilde, la padrona, all’improvviso mutata in una creatura diversa da quella che aveva visto sino ad allora. Gli sembrò quasi che, da un momento all’altro, fosse cresciuta di una spanna. E ci mancò poco che Enrichetto, altrimenti così abbottonato nella sua dignità di scapolo, si abbassasse a confidarle: «Sono a terra. Lo vede anche lei, signorina Clotilde, in quale situazione mi sto venendo a trovare? Mi dia un po’ di sollievo, dunque! Sarebbe già molto una parola di stima».
Fatto sta che, al posto di andarsi a rinchiudere nella propria stanza e rimanerci fino all’ora di pranzo come era ormai uso consolidato, Enrichetto si lasciò prendere da un inusitato bisogno di parlare, di commentare con chi non poteva capirne nulla o quasi, i provvedimenti della legislazione antisemita.
E lei, la Bonifazi? Chiunque altro, non il Norzi però, si sarebbe reso conto che non sapeva quale faccia fare e tantomeno era in grado di escogitare qualcosa di appropriato, di plausibile da dire in risposta a quanto veniva sciorinando il suo inquilino. Un tipo che, per la verità, Clotilde apprezzava più di quanto non la spingesse a fare l’appartenenza a una razza e a una religione di cui aveva sempre sentito parlare in termini più o meno negativi.
Per cominciare, Norzi non sembrava particolarmente avaro e non si comportava da miscredente. Era anzi puntualissimo nei pagamenti e sempre corretto nella condotta. Non l’aveva mai udito bestemmiare. Quanto a quella faccenda del sangue, puro o impuro, che cosa poteva saperne una zitella cattolica, in perfetta regola con le leggi di Dio e di Mussolini? Che cosa poteva pensarne di quelle astruserie una creatura tutta casa e chiesa che sarebbe andata al cinema una sola volta in vita sua, quattro anni dopo, a vedere Pastor angelicus sulla vita di Pio XII? Che cosa poteva capirne di ariani e non ariani?
«Parli piano, per carità. Non gridi, sor Enrico, non gridi così» si affannò frattanto a suggerire Clotilde in nome e per conto di quella prudenza che aveva sempre avuto quale compagna inseparabile.
«Che dice, signorina Bonifazi? Io non sto gridando!»
«Sì, invece! Povero lei, con rispetto parlando, nemmeno se ne accorge e poco ci manca s’affacci alla finestra per dire a tutta Roma quello che va dicendo a me. Beva un altro goccetto d’acqua, vedrà che le giova!»
Norzi, stavolta, si sforzò di sorridere e fu il suo un sorriso languido, amaro. Poi, quando riprese a parlare, non era più quello di poco prima. Sembrava cercasse, ubbidendo ad un mutato umore e consiglio, di ridimensionare con le colpe anche le responsabilità del Regime in merito alla famigerata (era proprio lui a aggettivarla così, adesso) questione ebraica. Si mostrava d’un tratto più accomodante.
«Sono il primo ad ammetterlo! Bottai è, per molti versi, un buon ministro dell’Educazione nazionale. Nessuno può negargli di essere un uomo colto, un intellettuale di grande livello» si sorprese a concedere Enrichetto mentre la sua interlocutrice, la Bonifazi, pareva chiamare a sostegno della sua muta incomprensione, della sua sordità pressoché metafisica, le mura stesse del tinello e persino la credenza (ereditata da una zia d’acquisto, la marchigiana Gigliola Lanciani). «Posso capire che il cocciuto attaccamento degli ebrei alle tradizioni, l’obbedienza alle leggi dei padri, rappresenti un ostacolo in più alla diffusione del fascismo. Mi rendo conto che la penetrazione degli ideali del Regime nelle comunità israelitiche dia luogo a qualche difficoltà in più. Da questo però a… a…»
Norzi non finì quella frase, lasciandola in sospeso e scuotendo il capo. Quasi fosse preda di un’improvvisa resipiscenza, quasi quel che aveva detto gli fosse apparso d’un tratto esagerato, inaccettabile.
Enrichetto non era il solo a comportarsi così, a cedere per qualche attimo alla tentazione di capire le inique ragioni dei fascisti. Altri ebrei, in quei momenti della grande persecuzione, si sforzavano di comprendere. Non era, tuttavia, debolezza la loro. Come chiamarla allora? Ingenuità? In parte, solo in parte dal momento che l’ingenuità nascondeva anche dell’altro. È verosimile, infatti, che l’irragionevolezza dei nuovi persecutori, degli antisemiti con o senza camicia nera, non potesse inizialmente, a botta calda, generare in risposta che l’irragionevolezza appunto delle vittime. Era, insomma, un’irragionevolezza nata proprio come risposta a un’altra, ben più colpevole irragionevolezza, quella che spingeva gli ebrei, privati assurdamente dei loro diritti, a cercar di capire. A spingerli a essere due volte ebrei, onorando quell’intelligenza e quella comprensione che fanno appunto degli ebrei gli unici esseri viventi che riescono a sentirsi, a immaginare di essere complici d’un dio che tutto sa, tutto vede, tutto sente.
«Qui, da me, è al sicuro» la Bonifazi se ne uscì una domenica come quella rassicurazione fosse il dolce della festa. I giorni erano diventati frattanto settimane e le settimane mesi. La signorina Clotilde aveva così avuto tempo di pensare e ripensare prima di abbandonarsi a una dichiarazione che la impegnava, compromettendola come mai le era accaduto prima nella vita.
Approfittando dei suoi precocissimi risvegli, che spesso precedevano l’alba, era più volte tornata a consultarsi con la sua coscienza. La stessa che le faceva da specchio ogni domenica quando, al momento dell’Elevazione, pregava in ginocchio con quanto ardore poteva e sapeva. Pregava a mani giunte, serrando le palpebre più e più forte allorché temeva di abbandonarsi alla meccanicità delle giaculatorie. Clotilde si sforzava infatti di condursi, al momento della consacrazione dell’ostia, come se fosse ogni volta la grande occasione e avesse davanti chi doveva darle un lasciapassare per il Paradiso. Con quella stessa tensione era tornata a interrogarsi una, due, dieci volte su che cosa fare nei confronti del suo inquilino. Sopra un piatto della bilancia aveva messo il rispetto d’una legge che non sapeva bene come interpretare e sull’altro la carità. Che cosa privilegiare? Un sentimento confuso e tiepido, che si teneva tuttavia nascosto dietro alla prescrizione antica come il verbo cristiano di consolare gli afflitti, aveva finito con l’avere la meglio.
«Nonostante sia ebreo, anche lei è un po’ figlio di Dio. Voglio dire del nostro Dio» fu un’altra delle uscite consolatorie di Clotilde che, intanto, non sapeva fare a meno di chiedersi se fosse o meno il caso di consigliarsi anche con don Luigi. Sì? No? Qualcosa le suggeriva di farlo, e subito. Tuttavia procrastinava, e non da quel giorno, quasi temesse una risposta severa quanto inappellabile del suo parroco. E se l’avesse sconsigliata di dare asilo e protezione a un miscredente? Meglio perciò evitare di coinvolgerlo, almeno per il momento.
«Grazie, signorina Clotilde. Verrà tuttavia il giorno che, figlio di Dio o no, la costringeranno a mettermi per la strada. Vedrà!»
Erano due piccole vite che giocavano, in quei brevi momenti, una partita quale mai avrebbero immaginato d’essere chiamati a disputare. Enrichetto, d’altronde, non si rendeva ancora conto d’essere alle soglie d’un pericolo mortale. Immaginava la solita croce, fatta con il legno e i chiodi dell’umiliazione. Quella stessa che da secoli, con feroce puntualità, torna a crocifiggere il popolo ebreo. E l’esperienza insegnava che per secoli, quanti fra i suoi avi avevano mostrato animo e risorse sufficienti a sopportare, alla fine erano riusciti a scamparla. Si erano salvati, anzi erano stati risparmiati dalla magnanimità dei loro aguzzini. Certo, il prezzo era stato sempre molto alto ma non impossibile. E Norzi – che fra l’altro aveva imparato a sorridersi nello specchio del bagno come a salutare tutto quello che in lui gli ricordava un’origine da tenersi poi sempre più nascosta – confidava già in una tale salvezza. Ce l’avrebbe fatta, insomma, sia pure per il rotto della cuffia!
Dall’altra parte Clotilde, zitella da quando aveva iniziato a essere donna, non poteva immaginare che quella volta, l’unica in tutta la sua vita, sarebbe stata proprio la natura femminile a soccorrerla. L’avrebbe cioè portata a ribellarsi in un suo modo confuso, senza calcoli e senza programmi, all’odiosa prepotenza della legislazione antisemita. Nemmeno don Luigi d’altronde, che più tardi avrebbe cercato di spiegarle come stavano le cose invocando sul più bello quell’obbedienza che accetta e china il capo anche senza capire, sarebbe riuscito ad ammansirla al giusto punto. A ottenere da lei qualcosa di più d’un «va be’!» a mezza voce, poco convinto.
«Costringermi a cacciarla da questa casa?»
«Propr...