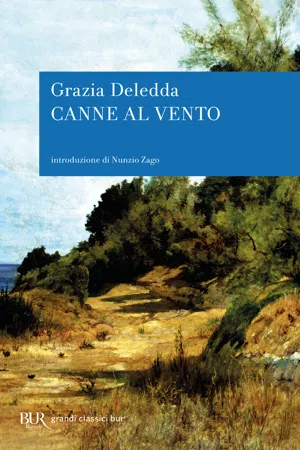![]() CANNE AL VENTO
CANNE AL VENTO![]()
I
Tutto il giorno Efix, il servo delle dame Pintor, aveva lavorato a rinforzare l’argine primitivo da lui stesso costrutto un po’ per volta a furia d’anni e di fatica, giù in fondo al poderetto lungo il fiume: e al cader della sera contemplava la sua opera dall’alto, seduto davanti alla capanna sotto il ciglione glauco di canne a mezza costa sulla bianca Collina dei Colombi.
Eccolo tutto ai suoi piedi, silenzioso e qua e là scintillante d’acque nel crepuscolo, il poderetto che Efix considera più suo che delle sue padrone: trent’anni di possesso e di lavoro lo han fatto ben suo, e le due siepi di fichi d’India che lo chiudono dall’alto in basso come due muri grigi serpeggianti di scaglione in scaglione dalla collina al fiume, gli sembrano i confini del mondo.
Il servo non guardava al di là del poderetto anche perché i terreni da una parte e dall’altra erano un tempo appartenuti alle sue padrone: perché ricordare il passato? Rimpianto inutile. Meglio pensare all’avvenire e sperare nell’aiuto di Dio.
E Dio prometteva una buona annata, o per lo meno faceva ricoprir di fiori tutti i mandorli e i peschi della valle; e questa, fra due file di colline bianche, con lontananze cerule di monti ad occidente e di mare ad oriente, coperta di vegetazione primaverile, d’acque, di macchie, di fiori, dava l’idea di una culla gonfia di veli verdi, di nastri azzurri, col mormorio del fiume monotono come quello di un bambino che s’addormenta.
Ma le giornate erano già troppo calde ed Efix pensava anche alle piogge torrenziali che gonfiano il fiume senz’argini e lo fanno balzare come un mostro e distruggere ogni cosa: sperare, sì, ma non fidarsi anche; star vigili come le canne sopra il ciglione che ad ogni soffio di vento si battono l’una contro l’altra le foglie come per avvertirsi del pericolo.
Per questo aveva lavorato tutto il giorno e adesso, in attesa della notte, mentre per non perder tempo intesseva una stuoia di giunchi, pregava perché Dio rendesse valido il suo lavoro. Che cosa è un piccolo argine se Dio non lo rende, col suo volere, formidabile come una montagna?
Sette giunchi attraverso un vimine, dunque, e sette preghiere al Signore ed a Nostra Signora del Rimedio, benedetta ella sia, ecco laggiù nell’estremo azzurro del crepuscolo la chiesetta e il recinto di capanne quieto come un villaggio preistorico abbandonato da secoli. A quell’ora, mentre la luna sbocciava come una grande rosa fra i cespugli della collina e le euforbie odoravano lungo il fiume, anche le padrone di Efix pregavano: donna Ester la più vecchia, benedetta ella sia, si ricordava certo di lui peccatore: bastava questo perché egli si sentisse contento, compensato delle sue fatiche.
Un passo in lontananza gli fece sollevar gli occhi. Gli sembrò di riconoscerlo; era un passo rapido e lieve di fanciullo, passo d’angelo che corre ad annunziare le cose liete e le tristi. Sia fatto il volere di Dio: è lui che manda le buone e le cattive notizie; ma il cuore cominciò a tremargli, ed anche le dita nere screpolate tremarono coi giunchi argentei lucenti alla luna come fili d’acqua.
Il passo non s’udiva più: Efix tuttavia rimase ancora là, immobile, ad aspettare.
La luna saliva davanti a lui, e le voci della sera avvertivano l’uomo che la sua giornata era finita. Era il grido cadenzato del cuculo, il zirlio dei grilli precoci, qualche gemito d’uccello; era il sospiro delle canne e la voce sempre più chiara del fiume: ma era sopratutto un soffio, un ansito misterioso che pareva uscire dalla terra stessa: sì, la giornata dell’uomo lavoratore era finita, ma cominciava la vita fantastica dei folletti, delle fate, degli spiriti erranti. I fantasmi degli antichi Baroni scendevano dalle rovine del castello sopra il paese di Galte, su, all’orizzonte a sinistra di Efix, e percorrevano le sponde del fiume alla caccia dei cinghiali e delle volpi: le loro armi scintillavano in mezzo ai bassi ontani della riva, e l’abbaiar fioco dei cani in lontananza indicava il loro passaggio.
Efix sentiva il rumore che le panas* facevano nel lavar i loro panni giù al fiume, battendoli con uno stinco di morto, e credeva di intraveder l’ammattadore, folletto con sette berretti entro i quali conserva un tesoro, balzar di qua e di là sotto il bosco di mandorli, inseguito dai vampiri con la coda di acciaio.
Era il suo passaggio che destava lo scintillio dei rami e delle pietre sotto la luna: e agli spiriti maligni si univano quelli dei bambini non battezzati, spiriti bianchi che volavano per aria tramutandosi nelle nuvolette argentee dietro la luna: e i nani e le janas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia a tesser stoffe d’oro in telai d’oro, ballavano all’ombra delle grandi macchie di fillirèa, mentre i giganti s’affacciavano fra le rocce dei monti battuti dalla luna, tenendo per la briglia gli enormi cavalli verdi che essi soltanto sanno montare, spiando se laggiù fra le distese d’euforbia malefica si nascondeva qualche drago o se il leggendario serpente cananèa, vivente fin dai tempi di Cristo, strisciava sulle sabbie intorno alla palude.
Specialmente nelle notti di luna tutto questo popolo misterioso anima le colline e le valli: l’uomo non ha diritto a turbarlo con la sua presenza, come gli spiriti han rispettato lui durante il corso del sole; è dunque tempo di ritirarsi e chiuder gli occhi sotto la protezione degli angeli custodi.
Efix si fece il segno della croce e si alzò: ma aspettava ancora che qualcuno arrivasse. Tuttavia spinse l’asse che serviva da porticina e vi appoggiò contro una gran croce di canne che doveva impedire ai folletti e alle Tentazioni di penetrare nella capanna.
Il chiarore della luna illuminava attraverso le fessure la stanza stretta e bassa agli angoli, ma abbastanza larga per lui che era piccolo e scarno come un adolescente. Dal tetto a cono, di canne e giunchi, che copriva i muri a secco e aveva un foro nel mezzo per l’uscita del fumo, pendevano grappoli di cipolle e mazzi d’erbe secche, croci di palma e rami d’ulivo benedetto, un cero dipinto, una falce contro i vampiri e un sacchetto di orzo contro le panas: ad ogni soffio tutto tremava e i fili dei ragni lucevano alla luna. Giù per terra la brocca riposava con le sue anse sui fianchi e la pentola capovolta le dormiva accanto.
Efix preparò la stuoia, ma non si coricò. Gli sembrava sempre di sentire il rumore dei passi infantili: qualcuno veniva di certo e infatti a un tratto i cani cominciarono ad abbaiare nei poderi vicini, e tutto il paesaggio che pochi momenti prima pareva si fosse addormentato fra il mormorio di preghiera delle voci notturne, fu pieno di echi e di fremiti quasi si svegliasse di soprassalto.
Efix riaprì. Una figura nera saliva attraverso la china ove già le fave basse ondulavano argentee alla luna, ed egli, a cui durante la notte anche le figure umane parevan misteriose, si fece di nuovo il segno della croce. Ma una voce conosciuta lo chiamò: era la voce fresca ma un po’ ansante di un ragazzo che abitava accanto alla casa delle dame Pintor.
«Zio Efisé, zio Efisé!»
«Che è accaduto, Zuannantò? Stanno bene le mie dame?»
«Stanno bene, sì, mi pare. Solo mi mandano per dirvi di tornare domani presto in paese, che hanno bisogno di parlarvi. Sarà forse per una lettera gialla che ho visto in mano a donna Noemi. Donna Noemi la leggeva e donna Ruth col fazzoletto bianco in testa come una monaca spazzava il cortile, ma stava ferma appoggiata alla scopa e ascoltava.»
«Una lettera? Non sai di chi è?»
«Io no; non so leggere. Ma la mia nonna dice che forse è di sennor Giacinto il nipote delle vostre padrone.»
Sì, Efix lo sentiva; doveva esser così: tuttavia si grattava pensieroso la guancia, a testa china, e sperava e temeva d’ingannarsi.
Il ragazzo s’era seduto stanco sulla pietra davanti alla capanna e si slacciava gli scarponi domandando se non c’era nulla da mangiare.
«Ho corso come un cerbiatto: avevo paura dei folletti...»
Efix sollevò il viso olivastro duro come una maschera di bronzo, e fissò il ragazzo coi piccoli occhi azzurrognoli infossati e circondati di rughe: e quegli occhi vivi lucenti esprimevano un’angoscia infantile.
«Ti han detto s’io devo tornare domani o stanotte?»
«Domani, vi dico! Intanto che voi sarete in paese io starò qui a guardare il podere.»
Il servo era abituato a obbedire alle sue padrone e non fece altre richieste: tirò una cipolla dal grappolo, un pezzo di pane dalla bisaccia e mentre il ragazzo mangiava ridendo e piangendo per l’odore dell’aspro companatico, ripresero a chiacchierare. I personaggi più importanti del paese attraversavano il loro discorso: primo veniva il Rettore, poi la sorella del Rettore, poi il Milese che aveva sposato una figlia di questa ed era diventato, da venditore ambulante di arance e di anfore, il più ricco mercante del villaggio. Seguiva don Predu, il sindaco, cugino delle padrone di Efix. Anche don Predu era ricco, ma non come il Milese. Poi veniva Kallina l’usuraia, ricca anche lei ma in modo misterioso.
«I ladri han tentato di rompere il suo muro. Inutile: è fatato. E lei rideva, stamattina, nel suo cortile, dicendo: “anche se entrano trovano solo cenere e chiodi, povera me, povera come Cristo”. Ma la mia nonna dice che zia Kallina ha un sacchettino pieno d’oro nascosto dentro il muro.»
Ma ad Efix in fondo poco importavano queste storie. Coricato sulla stuoia, con una mano sotto l’ascella e l’altra sotto la guancia, sentiva il suo cuore palpitare e il fruscio delle canne sopra il ciglione gli sembrava il sospiro d’uno spirito malefico.
La lettera gialla! Giallo, brutto colore. Chissà cosa doveva ancora accadere alle sue padrone. Da venti anni a questa parte quando qualche avvenimento rompeva la vita monotona di casa Pintor era invariabilmente una disgrazia.
Anche il ragazzo s’era coricato, ma non aveva voglia di dormire.
«Zio Efix, anche oggi la mia nonna raccontava che le vostre padrone erano ricche come don Predu. È vero o non è vero?»
«È vero» disse il servo sospirando. «Ma non è ora di ricordar queste cose. Dormi.»
Il ragazzo sbadigliò.
«Ma mia nonna racconta che dopo morta donna Maria Cristina, la vostra beata padrona vecchia, passò come la scomunica, in casa vostra. È vero o non è vero?»
«Dormi, ti dico, non è ora...»
«E lasciatemi parlare! E perché è fuggita donna Lia, la vostra padrona piccola? La mia nonna dice che voi lo sapete: che l’avete aiutata a fuggire, donna Lia: l’avete accompagnata fino al ponte, dove si è nascosta finché è passato un carro sul quale ella è andata fino al mare. Là si è imbarcata. E don Zame, suo padre, il vostro padrone, la cercava, la cercava, finché è morto. È morto là, accanto al ponte. Chi l’ha ucciso? Mia nonna dice che voi lo sapete...»
«Tua nonna è una strega! Lei e tu, tu e lei lasciate in pace i morti!» gridò Efix; ma la sua voce era roca, e il ragazzo rise con insolenza.
«Non arrabbiatevi, che vi fa male, zio Efix! Mia nonna dice che è stato il folletto, a uccidere don Zame. È vero o non è vero?»
Efix non rispose: chiuse gli occhi, si mise la mano sull’orecchio, ma la voce del ragazzo ronzava nel buio e gli sembrava la voce stessa degli spiriti del passato.
Ed ecco a poco a poco tutti vengono attorno, penetrano per le fessure come i raggi della luna: è donna Maria Cristina, bella e calma come una santa, è don Zame, rosso e violento come il diavolo: sono le quattro figlie che nel viso pallido hanno la serenità della madre e in fondo agli occhi la fiamma del padre: sono i servi, le serve, i parenti, gli amici, tutta la gente che invade la casa ricca dei discendenti dei Baroni della contrada. Ma passa il vento della disgrazia e la gente si disperde, come le nuvolette in cielo attorno alla luna quando soffia la tramontana.
Donna Cristina è morta; il viso pallido delle figlie perde un poco della sua serenità e la fiamma in fondo agli occhi cresce: cresce a misura che don Zame, dopo la morte della moglie, prende sempre più l’aspetto prepotente dei Baroni suoi antenati, e come questi tiene chiuse dentro casa come schiave le quattro ragazze in attesa di mariti degni di loro. E come schiave esse dovevano lavorare, fare il pane, tessere, cucire, cucinare, saper custodire la loro roba: e sopratutto non dovevano sollevar gli occhi davanti agli uomini, né permettersi di pensare ad uno che non fosse destinato per loro sposo. Ma gli anni passavano e lo sposo non veniva. E più le sue figlie invecchiavano più don Zame pretendeva da loro una costante severità di costumi. Guai se le vedeva affacciate alle finestre verso il vicolo dietro la casa, o se uscivano senza suo permesso. Le schiaffeggiava coprendole d’improperi, e minacciava di morte i giovani che passavano due volte di seguito nel vicolo.
Egli intanto passava le giornate a girovagare per il paese, o seduto sulla panca di pietra davanti alla bottega della sorella del Rettore. Le persone scantonavano nel vederlo, tanto avevan paura della sua lingua. Egli litigava con tutti, ed era talmente invidioso del bene altrui, che quando passava in un bel podere diceva “le liti ti divorino”. Ma le liti finivano col divorare le sue terre, e una disgrazia inaudita lo colpì a un tratto come un castigo di Dio per l...