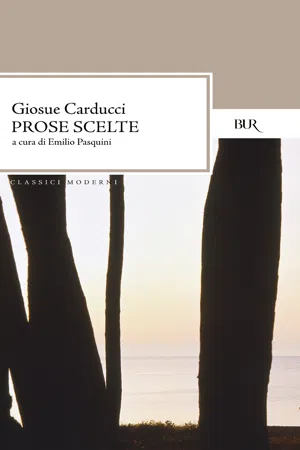
- 460 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Prose scelte
Informazioni su questo libro
Pagine vigorose e delicate, testi di natura diversissima, come saggi letterari, interventi giornalistici, lettere ad amici, familiari e donne amate, quelli raccolti in questa inedita e preziosa antologia che svela un Carducci lontano dagli stereotipi trasmessi dalla tradizione scolastica. Uno strumento nuovo e aggiornatissimo per accostarsi a uno dei più grandi intellettuali italiani di fine Ottocento, la cui desueta immagine di poeta-professore, legata a una funzione di enfatico vate, viene ricondotta al suo vero segno distinto: un costante e coerente sperimentalismo.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Print ISBN
9788817014571eBook ISBN
9788858649947Prose scelte
1
L’«uccellaccio selvaggio» e le delizie del ponce
Tratta dal primo volume dell’epistolario nell’ed. naz. (e ora anche da G. Carducci, Opere scelte, II, Prose, commenti, lettere, a cura di Mario Saccenti, Utet, Torino 1993, pp. 676-678), questa lettera a Felice Tribolati, datata San Miniato, 4 dicembre 1856, ci mostra un Carducci ventunenne alle prese col suo primo libro (la Giunta alla derrata) e col suo lavoro di insegnante al ginnasio di San Miniato in provincia di Pisa. L’autoritratto chiama in causa scherzosamente la cerchia degli “Amici pedanti”: con Felice Tribolati, Narciso Pelosini e Beppe Puccianti. Naturalmente, ponce è la riduzione toscana dell’inglese punch (acqua, rum e scorza di limone: si serve bollente).
Carissimo Felice,
Il silenzio c’ho tenuto con te, amico buono, non è scusabile. Ma, che vuoi? la pigrizia, il lavoro del libro; le occupazioni fortissime, e nel medesimo tempo le distrazioni che necessariamente portava seco cotesto nostro tumulto letterario, quindi la malattia, poi San Miniato, han congiurato a farmi parere amico pessimo. Pazienza: e dalla parte tua perdono. Ora ti dirò che in questa città io son rovinato: questa, senza metafora, per me è come un sepolcro, o almeno come una prigione: in cui bisognerà ch’io per forza mi fiacchi, e moia di consunzione spirituale. Mancan biblioteche: manca campo agli esercizii letterarii: la lezione ch’io debbo fare, bisogna che la limiti all’intelligenza di ragazzi di quattordici anni: manca l’anima e la vita che vicendevolmente si comunica dove è una società giovenile ben pensante, ben leggente, bene istudiante: com’io avevo in Pisa, come in Firenze. Ahi, ahi, cantatemi il De profundis: Giosuè è morto, sì morto; a dispetto della credenza ch’io avevo che in me ci fosse tanta vita da bastare a diecimila degli uomini moderni. E non è morto per vizio proprio: ma perché i figliuolacci di Adamo, in quella lor congiura cannibalesca che chiamano società, han preso quest’uccellaccio selvaggio: a poco a poco gli han tarpato l’ale: poi l’han chiuso in una gabbia di ferro: e a lui avvezzo a cibarsi di carne fresca o di sangue danno la pappa coll’uovo: poi gli stanno pure attorno facendo rumore come di una bella cosa che abbiano fatto. Birboni e sciocchi. Ma non ho voglia di arrabbiarmi: tanto, son morto. E bene sta: che importa operare e pensare? meglio è mangiare bere e fumare. Oh, viva il ponce: la sola cosa bella angelica che sia per me nel mondo. Quello che per me ragazzo erano certe idee che mi formavo della felicità anzi beatitudine ch’io avrei conseguito nell’amore di certe donne; ora, sì, quel mistico idealismo poetico mi si è verificato in fatto, realmente, sustanzialmente, chi il crederebbe? nel ponce. Oh datemi ponci; e datemi, quando sono arrabbiato, la facoltà di potere scrivere un sonetto colla coda, e sto bene anche in San Miniato.
Ho saputo, mio caro Felice, che tu hai voluto scrivere alcuna cosa, certo bellissima, sulla Giunta: e te ne ringrazio, se bene non ho ancora avuto il piacere di vederla. A pena stampata, me la manderanno. So che anche Pelosini scrive su questo: scriva, ché mi farà piacere grandissimo. Ma Beppe Puccianti non si desta? dorme l’ira di Beppe Puccianti? Anche lui scriva, predichi, urli, si faccia vivo: per Dio! Ora noi non iscendiamo più in campo.
Abbiti i miei saluti, di cuore veramente; rispondimi: saluta tutti gli amici: amami: e tu scrittor bellissimo di lettere, perdona all’infame epistola del tuo amico.
2
Al di là della «Toscanina»: la vocazione del Giusti
Sono pagine che risalgono al 1859, con un’appendice nel ’74, dedicate alla figura di Giuseppe Giusti (1809-1850), di cui Carducci pubblicò nel 1860 l’edizione delle Poesie (Barbèra, Firenze), con simile introduzione. Ricomparvero nei Bozzetti critici e discorsi letterari (Vigo, Livorno 1876), poi nell’ed. naz. (XVIII 261 ss.), da cui l’antologia delle Prose, a cura di Giovanni Falaschi, Garzanti, Milano 1987, p. 3 ss.
Ne trascegliamo i passi che lumeggiano le esperienze esistenziali (fra cui le «contumelie d’un birro») dietro gli esordi del poeta civile e la sua esplosione creativa nel solco dei grandi eventi risorgimentali. Viene poi una serie di colpi d’obiettivo sui suoi capolavori (il Re travicello e la Terra dei morti, Gingillino e il Brindisi di Girella), culminante nel Papato di prete Pero (satira del Primato del Gioberti e di papa Pio IX): insomma, la conferma di una contagiosa popolarità in terra di Toscana, misurata dal Carducci nella sua stessa adolescenza.
Quasi mimetica la patina toscana nel lessico e nello stile di queste pagine. Ma vi si pongono i fondamenti dell’ideologia carducciana.
[…] Di questa condizione, e dell’indeterminazione politica e letteraria dei tempi barcollanti tra repubblica e monarchia, tra Voltaire e Chateaubriand, tra l’Alfieri e il Manzoni; e degli esempi d’un famoso canzoniere francese, e di un poeta toscano1 rallegrante allora con la sua briosa loquacità la scolaresca di Pisa, ritengono tutti insieme i primi versi del Giusti. Pure in alcune di quelle terzine e qua e là ne’ sonetti è finitezza di composizione e verso ben temperato: è in qualche strofe della Tirata a Luigi Filippo maschia pienezza e talvolta ardimento e sicurtà di andatura e di tono: che, tra l’incertezza annebbiata e la liquida esilità e la improvvista nullaggine delle poesiucce che allora e piú dopo tennero il campo, ti mostrano buoni studi e conoscenza dell’Alighieri e l’avviamento dato al giovane ingegno da Andrea Francioni amatore di Virgilio e del Petrarca; che che degli ozi suoi e delle scapataggini dica il poeta. E la ciarla della vecchia lusinghiera nella Mamma educatrice, e il malumore del Vetturale divenuto impresario, e la piana bonarietà degli ottonari, e la vispa scioltezza del decasillabo, e il saffico già sacro ai numi e agli eroi domato ad accogliere la parodia e l’ironia, e il quinario famoso per le fiorettature degli arcadi, variato ora e spezzato e condensato e disciolto, mostrano già piú che in embrione il Giusti futuro.
A formare il quale né i plausi degli eguali mancarono né i fastidi della polizia. È nota a tutti la ripassata del birro che «in riga di paterna cura lo ricopri di contumelia»; non noto ugualmente un fatterello, che a quella ripassata fu forse cagione, narrato dal Giusti con la solita festività: «C’era una volta (comincio come cominciano le nonne quando raccontano ai bambini la novella di Paghettino), c’era una volta un tale mio condiscepolo, anzi amico e fratello mio svisceratissimo, che dotato dalla natura d’una mente tirata a tutto pulimento e d’un cuore come ce ne sono pochi, quando mi vedeva leggere certi libri o scarabocchiare certi fogli, mi diceva cosí: – Beppe, bada a quello che fai: tu m’esci dal sentimento: te lo dico per tuo bene; se dovessi dirlo a un altro, me ne riguarderei; ma qui, fra di noi, a quattr’occhi, via, si può parlare senza complimenti; prendilo in buona parte. Si parla molto di te, e non tutti quelli che lodano sono amici: io ho fatto vista di non essere io, ma sai come sono questi amici di caffè: pensa ai casi tuoi, e non ci siamo visti. – Ed io, sbalestrato e imprudente come sono, ascoltavo questo consiglio come se mi venisse dalla voce della verità e per otto giorni leggevo le rime oneste del Mazzoleni e recitavo agli amici certi sonettucciacci scritti in illo tempore sulla falsa-riga di ser Francesco Petrarca. Ma di lí a poco ricascavo nei soliti spropositi, ed èccoti l’amico a battere da capo con le sue ammonizioni. Dopo molte ricadute dalla parte dell’amico, un giorno mi venne battuta sulla carta una delle solite cose strambe per l’appunto pochi minuti dopo che il mio compagno m’aveva esortato a non lo far piú. Fermo come era per allora nel proposito di non leggerla agli altri, per isfogarmi in qualche maniera dalla voglia che n’avevo di farla sentire, la lessi al mio fedel compagno che ne parve incantato e ne volle una copia per conservarla fra le altre care memorie di me. Due giorni dopo m’entra in camera tutto scalmanato, e mi dice: – Ho una brutta nuova da darti: quella copia non so come mi venne fatto di mettermela in tasca per iscambio, e, abbi pazienza, l’ho persa. – Io, che su quel súbito credevo che gli fosse accaduto qualche gran malanno, dissi: – Oh santo Dio! e ti pigli di queste cose? E se l’hai persa, o che m’importa a me? – Ed egli, tutto rasserenato, mi messe la mano sur una spalla, e mi disse: – Ci credi? mi rendi la vita. Non avevo coraggio di comparirti davanti: ma giacché non te n’importa, meglio cosí. Ah sai, a proposito, ho pensato d’andare a fare la pasqua a casa: vuoi nulla? parto stasera. – Io gli dissi: – Stai bene, fai buon viaggio, e dammi un bacio: – oh proprio il bacio d’un vero amico e d’un gusto ineffabile! – Addio sai. – Vedete un po’, quando il diavolo ci mette la coda! quella copia (che casi che si dànno!) oh non l’aveva trovata per l’appunto un agente di polizia! Ma eh! Oh buon per me se avessi dato retta ai savi consigli del mio fratello di studio: Guàrdati da chi consiglia a fine di bene». E chi sa che quella copia dalle mani di quell’agente di polizia non passasse nell’altre di quel commissario che fece al Giusti quella ripassata; e che il Giusti, fissato il chiodo in cotesto ingerirsi d’un birro fin de’ pensieri e degli scritti d’un cittadino, non si movesse per ciò a studiare il perché e il come dei cattivi governi e ad assalirli colla tremenda arme del riso? e di qui derivasse la Rassegnazione e proponimento e dietro tutte le altre poesie? È destino: gli oppressori e gli oscuratori con l’opera stessa che mettono ad opprimere e a spegnere risollevano e rischiarano: le lettere di imprigionamento e la Bastiglia formarono nella Francia despotica Voltaire e Mirabeau: nella patriarcale Toscana le contumelie d’un birro dettero la mossa alle poesie civili del Giusti. […]
Sotto la impressione di questi avvenimenti; quando già la rivoluzione, di militare, era venuta alle mani dei letterati e giornalisti; e campeggiava la declamazione, e le sètte si rinfocolavano a distruggere senza curarsi, o poco, del sostituire; e le pubblicazioni de’ fuorusciti crescevano l’agitazione, pur disconoscendo non di rado le condizioni vere del paese; e dalle letture straniere s’imbeveano sentimenti e bisogni non nostri; e la gioventú s’infervorava alla opposizione, vuoi coll’affrontare le prigionie, vuoi co ’l fischiare o coll’applaudire in teatro; e si disperdeva nelle congiure il senno pratico e la vigoria e il gentil sangue italiano; e quali dei pensatori miravano alle riforme d’avanti l’89, quali alla constituzione, e chi alla Francia e chi all’Inghilterra, e chi alle dinastie regnanti e chi a príncipi stranieri, quasi tutti all’indipendenza, pochi all’unità, molti tra i giovani e gli esuli allo stato popolare; e la nobiltà e la borghesia benestante, infastidite delle imposizioni e pure aspirando a partecipare il governo, dalle sovversioni aborrivano, e il popolo si sdraiava nel materiale ben essere: sotto la impressione di tali avvenimenti e di tali condizioni, la satira dovea prorompere dolente, caustica e arcigna, e proceder violenta a radere dall’edifizio della civiltà nazionale ciò che v’era di vecchio di grottesco e straniero, segnando la traccia ai lavori futuri della libertà. E questa satira, che per riuscire efficace doveva esser pratica e rivolgersi al popolo, non potea forse spiegarsi in tutte le sue forme se non dopo il ’30; quando, dileguandosi a poco a poco quel resto di medio evo e quel mistico e tenebroso di che le eterie2 e le vendite de’ Carbonari aveano involto l’Europa, anche le sètte sentiano il bisogno della pubblicità, e i popoli stavan attesi alle grandi questioni agitate a Parigi, tribuna oramai del mondo. Né forse in altra parte d’Italia potea meglio venir su che nella Toscana, dove, come da scoglio cui dei cavalloni e della burrasca arrivan solamente gli sprazzi, si poteva piú pacificamente contemplare e studiare il perenne sconvolgimento italiano. Che se anche qui dal ’31 al ’33 non mancarono processi, le pene furono assai meno crudeli; e se parvero di sinistro augurio per l’avvenire la soppressione dell’Antologia3 nel ’33 e Ciantelli presidente del Buon Governo, pure dal ’35 in poi ripresero i reggitori la teorica vecchia del lasciar fare e piú d’uno spiraglio aprirono al progredimento. Oltre i bonificamenti del suolo e i miglioramenti delle procedure giuridiche, l’università di Pisa fu rifiorita d’insegnamenti; e casse di risparmio, e asili infantili, e scuole normali, e giornali d’educazione, e studi politici e storici, furono dal governo se non incoraggiati almen sopportati; dal governo, che solo nel ’46 fe’ carezze alla curia romana e al gesuitismo.
A questi tempi e in questo paese Giuseppe Giusti, vedendo che, rotta omai la diga, i popoli, or lenti, proromperebbero prima o poi alla distruzione del vecchio, per istimolarli avviarli e dirigerli, diè mano alla sua satira pratica e popolare. E tutta rappresentò l’Italia dei tempi suoi, e di storico il passato, e nello sfondo l’avvenire, in un’epopea satirica di vari e moltiplici suoni, ma moventi e ritornanti a un medesimo tono.
Incominciasi questa da un grido d’ira e di scherno (Dies irae) su la tomba di Francesco I, imperatore d’Austria; dura personificazione della politica della Sant’Alleanza, che a Praga e a Verona disse parole da Attila contro ogni progresso e libertà; ragion vivente del servaggio d’Italia, e carnefice e carceriere degl’italiani; che confortava un padre pregante per la vita del figliuolo a ritornarsene, se volea giungere in tempo a rivederlo prima della esecuzion capitale; e tra le molli ombre e le belle acque di Schoenbrunn, studiava l’orario dei patimenti del carcere duro, e al Villa mandava una parrucca di pelo di cane, e un barbiere a tagliar la gamba al Maroncelli. Maledetta cosí la cagion prima d’ogni sventura nostra, la politica austriaca, in Francesco I; delle nostre sciagure e delle glorie e delle aspirazioni continue simboleggia la storia nell’allegoria dello Stivale; dove (singolare nella indeterminazione dei fatti e dei pensieri d’allora e fors’anche d’altre poesie del nostro autore) s’invoca la ricostituzione d’Italia nell’indipendenza, nell’unità, nella monarchia. E all’indipendenza grida piú alto e piú forte in quel portento dell’Incoronazione; dove dell’odio e disprezzo degl’italiani pe’ lor dominanti mostra la cagione in quel sudicio inginocchiarsi di questi, men che vassalli, all’austriaco re dei re. E questi, cause seconde del nostro servaggio, son qui aggruppati intorno all’imperator d’Austria, e con vivissima fedeltà delineati: Ferdinando II di Napoli sfoggiante fermezza d’animo e forze proprie all’oppressione; Leopoldo di Toscana, gingillante sé e il popolo con le interne migliorie; le turpi vanità della duchessa di Parma e del duca di Lucca; Francesco IV di Modena, tipo non volgare di profonda pervicacia nel regresso e nella reazione; e l’abiettazion necessaria del pontificato temporale, a cui, senza le illusioni dannose de’ nuovi guelfi, si volge il solo vero e nobil consiglio che possa darsi ai papi da un concittadino dell’Alighieri e del Machiavelli e da un cristiano. Dei prìncipi d’Italia ritócca altrove, specialmente nella canzone pe ’l ritratto di Dante: insiste su ’l granduca, e quella lenta incertezza del governo di lui tra il despotismo al quale stavasi attaccato con tutte le forze e la popolarità cui pure ambiva (incertezza, poi quasi tiberiesca simulazione), rappresenta lepidamente nel Re Travicello, e su ’l mecenate de’ gesuiti ed alleato dei sanfedisti, il duca di Modena, della cui politica son parodia i versi Per il primo congresso e l’Avviso per un settimo congresso.
Fin qui degli oppressori: degli oppressi e agli oppressi parlò nella Terra de’ morti, ben meritata risposta al mal detto d’un poeta straniero:4 non piagnistei né risibili superbie qui, ma dimostrazione di vita potente per quanto nascosa e repressa, ma speranza santissima e minaccia di risorgimento vicino. Ostacolo a questo e puntello della tirannia esterna e interna era la parte guasta del paese. Ricordate la incoronazione di Ferdinando austriaco vergognosamente splendida di pompe e adulazioni lombarde? Or bene: cotesti festeggiatori del signore straniero erano patrizi, che inetti rimpiangevano la facile preminenza dei previlegi e la boria delle pompe servili e la sicurtà degli ozi delle libidini e dei misfatti: erano vecchie dame galanti, già onnipotenti per lascivie e per aderenze di drudi, che a riportare il secol d’oro dileguatosi al brusco suono del «ça ira» repubblicano avvolgevano fili d’intrighi segreti, e a distruzione degli spiriti nuovi diffondevano dalle congreghe gesuitiche la mefite5 d’un egoistico ascetismo: erano que’ nobili, che trascinando la vita go...
Indice dei contenuti
- Prose scelte
- Copyright
- Dedica
- Introduzione di Emilio Pasquini
- Bibliografia
- Nota ai testi
- Prose scelte
- SOMMARIO