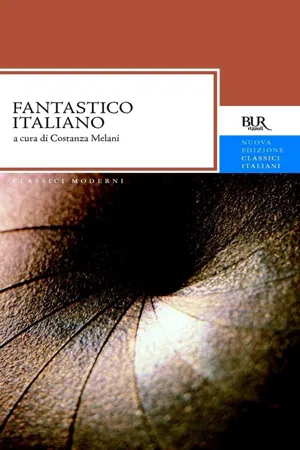![]()
IL RISARCIMENTO DELLA BOHÈME ITALIANA
Per quale ragione la bionda Edwige è così triste? Che cosa fa, seduta in disparte, con il mento nella mano e il gomito sul ginocchio, più tetra della disperazione, più pallida, della statua di alabastro che piange su una tomba? Théophile Gautier, Il cavaliere doppio
«Tutti mi chiedono che cosa io pensi di questo o di quello,» disse Spencer Brydon «e io rispondo come posso: aggirando la domanda, eludendola; insomma, me la cavo con una qualsiasi banalità. Del resto, per loro non farebbe differenza, [...] perché, se anche fosse possibile dar risposta su due piedi a così sciocca domanda su un argomento tanto vasto, i miei pensieri si riferirebbero per lo più a qualcosa che riguarda soltanto me stesso.»
Henry James, L’angolo prediletto
Per quanto tempo in Italia non ci fu nessun racconto fantastico, o meglio, nessun capolavoro fantastico?
I primi esempi di un «fantastico italiano» si devono agli ormai più che dimenticati Diodata Saluzzo, con Il castello di Bagnasco del 1819, Giovan Battista Bazzoni, con Il sotterraneo di Porta nuova del 1832 e al siciliano Vincenzo Linares, con la sua novella Il marito geloso, pubblicata tra i Racconti popolari del 1840. Perfetti esempi, spesso, di una letteratura d’intrattenimento, di un fantastico di maniera, che guardava da una parte al «meraviglioso storico» di Walter Scott e dall’altra alle gothic novels di Ann Radcliffe e Horace Walpole, ma che non raggiungeva mai la profondità letteraria dei propri modelli.
Esiti forse un po’ più incoraggianti di questi vengono raggiunti dagli scrittori della così detta scuola democratica riunita attorno al livornese Francesco Domenico Guerrazzi, autore di numerosi romanzi storico-gotici e fondatore, insieme a Giuseppe Mazzini e Carlo Bini, dell’importante rivista «L’Indicatore livornese».
È, questo, un momento culturale importante, in cui spiccano, come epicentri delle novità letterarie, le città del Nord – soprattutto la Torino di Camerini e la Milano di Baccio Emanuele Maineri, i primi due traduttori italiani di Poe – e quelle del centro, con Livorno e Pisa, dove lavoravano Guerrazzi e Ippolito Nievo.
Si deve a questi scrittori la prima reale apertura alla contemporanea letteratura anglo-americana e un’embrionale strategia culturale europeista: in primis a Guerrazzi – che tradusse dalla Parisina e The Prisoner of Chillon (Il prigioniero di Chillon) di Lord Byron a The Spy (La spia), Lionel Lincoln e The Pilot (Il pilota) di Fenimore Cooper – ; e poi al gruppo torinese del «Gabinetto di Lettura», un club per gentiluomini inaugurato nel ’57, che aveva il suo cuore nella «Rivista Contemporanea» su cui comparvero, tradotti da Camerini e Gustavo Strafforello, i racconti di Dickens, Hawthorne, Irving, Poe, del russo Sologoub, dello spagnolo Castelar, del francese De Nerval e dello scozzese Hogg.
Se la conoscenza da parte di Guerrazzi della letteratura straniera e la sua apertura ad un Romanticismo molto più torbido e fosco di quello inaugurato da Alessandro Manzoni, portano alla scoperta per un’intera generazione di scrittori delle nuove tematiche fantastiche e gotiche, ha però ragione Benedetto Croce, quando sostiene che, nonostante la lettura di Poe, di Ann Radcliffe o di Byron, ai romanzi storici e gotici di Guerrazzi manca qualcosa di «veramente» terrificante:
È un orrendo di testa e non di cuore, un’escogitazione di cose terribili non ispirate dal reale orrore dell’anima. [...] se il Guerrazzi avesse preso vivo e diretto interesse a quelle cose, come Edgardo Poe alle sue storie straordinarie, o qualche artista dei giorni nostri alla voluttuosa crudeltà delle sue fantasie, egli si sarebbe concentrato ed immerso in esse, narrandole con la semplicità che sola rende il terribile del terribile, laddove la struttura dei suoi romanzi è in ogni punto varata da digressioni e conversazioni col lettore e arieggia il modo tenuto dall’Ariosto e dal Manzoni o dai romanzieri e umoristi inglesi.1
Croce ha centrato il punto: ancora una volta qualcosa blocca il «nostro» fantastico al di qua del confine, il cuore non supera l’ostacolo e al racconto manca la vera tensione della paura: manca, cioè, quella che Poe avrebbe definito «l’unità d’effetto», la programmatica strategia narrativa che porta il lettore ad un breve, ma intenso e progressivo, stato di angoscia.
Dovremo aspettare ancora molti anni (quasi cento per l’esattezza) per trovare autori italiani pienamente consapevoli che la paura è un’arte con delle precise regole narrative. Per adesso i nostri scrittori si muovono seguendo delle intuizioni e producendo, isolatamente e sporadicamente, dei racconti ben congegnati.
Bisogna quindi ammettere che i narratori cresciuti all’ombra del romanzo storico-patriottico guerrazziano, che tanto amava indulgere anche sugli aspetti più morbosi e gotici delle storie narrate, meritano di essere ricordati più che per il valore letterario raggiunto (il Ser Lampo2 di Maineri è poco appetibile per il lettore moderno, mentre il racconto Un veglione3 di Nievo mostra tutti i limiti dell’ingenuità di questa stagione romantica italiana), per il ruolo di precursori che hanno svolto a ridosso del compimento dell’Unità d’Italia.
Ancora mancava a questi scrittori la consapevolezza di compiere una precisa operazione culturale, visto che il loro stesso capogruppo, Guerrazzi, il 30 gennaio del ’73 scriveva una lettera emblematica all’amico Maineri, esortandolo a non immergersi troppo nelle letture di Hoffmann e Poe, inadeguate a essere trapiantate nell’armonica terra italiana:
Da molti anni conosco Hoffmann, Arnim, Poe, Dickens, etc., e coteste loro invenzioni per me stanno bene là dove stanno. [...] se con qualche altro bicchiere di questo liquore vole straviziare, i’ non lo paro ma a tutto pasto, no: almeno io non glielo consentirei per la sua salute; poi faccia lei.4
Spetta allora a un’altra città e a un altro gruppo di scrittori con un’altra consapevolezza iniziare davvero a scrivere i primi piccoli capolavori fantastici italiani.
Tra il 1860 e il 1880, è ancora Milano la città da cui prende le mosse quella casalinga bohème italiana che Gadda definiva più «una similarità di destini»,5 che una scuola, in cui erano per l’appunto destinate a intrecciarsi le voci, questa volta sì piuttosto consapevoli, dei primi, veri, narratori fantastici italiani.
Gli scapigliati milanesi, che soprattutto in Poe, Hoffmann, Baudelaire, Hugo e Heine hanno i loro numi tutelari, riescono per primi a rendere nelle loro pagine le inquietudini profonde delle alchimie fantastiche. Nell’animo di questi narratori, pur divisi tra loro da formazioni e risultati artistici assai diversi, si fanno strada un’inquietudine e un’angoscia che affondano le loro radici nella comune delusione post-risorgimentale.
Il rifiuto della borghesia e dei suoi valori moderati, così come del denaro e della proprietà, riflettono il senso d’insicurezza sperimentato dalle giovani generazioni post-unitarie, che, indagando sul loro malessere, scoprono l’altra faccia del perbenismo ottocentesco. Nei racconti degli scapigliati, la follia, la deformità, la malattia, il sogno, l’allucinazione e le perversioni nevrotiche degli uomini trovano il loro ubi consistant.
Per questo gruppo di autori la realtà non è solamente ciò che si vede, perché l’enigma è dentro le cose, che vanno spogliate della loro tragica banalità quotidiana. Il dualismo fisico e psichico del mondo è per Tarchetti, Camerana, Praga e i fratelli Boito sia individuale, sia collettivo: la società e l’individuo sono sia oggetti di una profonda indagine, sia soggetti della ridefinizione dei confini stabiliti.
Come spiega bene Tarchetti nel Riccardo Waitzen, quello che noi chiamiamo reale, o vero, è ciò che accade sotto i nostri sensi, ma ciò che definiamo immaginario, altro non è che quanto accade fuori dalla loro limitata portata. Ossessioni, perversioni sessuali, malattie del corpo e della mente, somatizzazioni di rimorsi e sensi di colpa, ma anche casi di magnetismo, trasmigrazione di anime, amore dopo la morte: i temi del fantastico europeo e americano vengono riproposti in questi racconti, con l’unico «difetto» di essere spesso resi più casalinghi, meno nordici e più mediterranei.
Ancora una volta il limite del fantastico italiano sta nel risultato artistico, nella mancanza di coraggio che fa rimanere lo scrittore sulla soglia, guardando al mondo notturno «da un sottile spiraglio».6
dp n="45" folio="46" ? Tutta concentrata nel breve arco temporale 1865-69, l’opera narrativa di Igino Ugo Tarchetti è quella maggiormente influenzata dalla lettura fantastica di Edgar Allan Poe e dei contes fantastiques francesi ed è prevalentemente incentrata sui moderni temi delle nevrosi e delle ossessioni che impediscono all’uomo di vivere la vita con equilibrio.
Ma se per la trilogia dell’Amore nell’Arte (che comprende non a caso tre racconti intitolati con il nome del protagonista maschile: Bouvard, Riccardo Waitzen e Lorenzo Alviati) è giusto seguire l’influenza di Poe e sottolineare l’importanza della riflessione sulla riformulazione del rapporto tra Arte e Scienza e tra Arte e Morale, per altri racconti come Un osso di morto,7 La lettera U Le leggende del castello nero, Uno spirito in un lampone, vanno piuttosto presi in considerazione i racconti dei due romanzieri alsaziani Erckmann e Chatrian e quelli, mai privi di umorismo, di Dickens e Sterne: in particolare per Un osso di morto bisogna rileggere Le Pied de momie di Gautier, mentre per Le leggende del castello nero o per I fatali sono Aurélia di Nerval e Jettatura di Gautier i riferimenti letterari.
I più riusciti personaggi maschili di Tarchetti sono quegli artisti malati e ipersensibili, nevrotici e sessuofobici, come Bouvard, Lorenzo Alviati e Riccardo Waitzen, che precludono alla scoperta novecentesca dell’inconscio dell’Homo psicanaliticus.
In Lorenzo Alviati 8 l’io narrante racconta la tragica storia dell’amico di adolescenza Lorenzo e, a riprova della veridicità dei fatti narrati (con un omaggio evidente al Foscolo delle Ultime lettere di Jacopo Ortis), riporta le lettere che questi gli scriveva. Musicista e anima sensibile, Lorenzo vive nel culto della perfezione dell’Arte e ha ribrezzo della concretezza materiale e imperfetta del mondo reale. Sempre più nevrotico, malato e isolato, come i personaggi maschili di Poe, dopo la delusione infertagli dalla bella Regina, non riuscirà più ad amare le donne, chiuse nel loro sensuale involucro di carne, che le allontana dal mondo rarefatto e asettico dell’Ideale. Nevroticamente sessuofobico, a Lorenzo è precluso l’amore eterosessuale incarnato dalla sana Regina, specchio, nella sua carnalità, del disordine e dell’ambiguità del Mondo e della Vita: solo quando un’altra donna, Adalgisa, si ammalerà di tisi e si consumerà sotto i suoi occhi, diventando sempre più eterea e spirituale (come la Berenice poesca), Lorenzo se ne innamorerà, vedendo in lei la vittoria dello Spirito sul Corpo: alla morte di Adalgisa, non gli resterà che l’amore narcisistico per se stesso, rinchiuso in manicomio.9
Il suo risultato migliore, tuttavia, Tarchetti lo raggiunge nel romanzo autobiografico Fosca, non includibile in quest’antologia per motivi di estensione. Giorgio, il protagonista maschile «sano», s’innamorerà, lentamente ma inesorabilmente, dell’isterica e deforme cugina di un suo amico, Fosca. Simbolo della malattia personificata, Fosca, come molte donne dell’universo letterario del misogino Tarchetti, non appartiene al mondo dei vivi, ma è un revenant, che appartiene al mondo delle Ombre e della Morte.
Nel bipolarismo femminile-maschile, nel conflitto tra l’Io e l’Altro, la donna diventa la parte vampirescamente prevaricatrice che risolve il due nell’Uno:10 l’uomo soccombe, la donna, portatrice di Eros e Thanatos, ne succhia le energie vitali, per condurlo alla follia, alla morte o alla malattia. E anche Giorgio, dopo la notte del terribile amplesso che porterà Fosca alla morte, è destinato a essere vampirizzato e a ricevere su di sé quella malattia che Fosca gli potrebbe aver realmente trasmesso nell’abbraccio della morte, o che forse lui stesso si è procurato per autosuggestione. E per fare contento Todorov, la narrazione non scioglie il dubbio finale del lettore, lasciandolo nella più totale hésitation fantastica sulla vera genesi e natura della malattia di Giorgio.
Alcuni dei risultati migliori della nostra narrativa fantastica vengono raggiunti proprio in questi anni dai due fratelli Arrigo e Camillo Boito.
Per Benedetto Croce, Arrigo Boito era l’unico vero Romantico italiano, il portatore di una visione dualistica dell’esistenza, in cui gli opposti della luce e dell’ombra, della terra e del cielo, del bello e dell’orrido si cercano continuamente senza ritrovare e ricomporre l’unità perduta.
Sicuramente dualistica è l’impostazione che domina un racconto inquietante e perfettamente riuscito come L’alfier nero,11 in cui il dramma della scissione umana tra parti angeliche e parti bestiali (anticipata già nel 1865 nella fiaba polimetrica del Re Orso), trova una nuova e singolare versione.
Nell’incipit – che molto deve all’inizio di The Murders in the rue Morgue (Gli assassinii della Rue Morgue) di Poe, in cui troviamo una disquisizione sulle diverse capacità di analisi dei vari giocatori di dama, di scacchi e di whist - due uomini, due giocatori di scacchi si stanno sfidando. Da una parte c’è un campione americano, il bianco Giorgio Anderssen, che impersonifica l’ordine, la simmetria e il ragionamento, mentre dall’altra c’è uno sconosciuto viaggiatore etiope, un nero di nome Tom, emblema della confusione, del caos e dell’istinto. Sulla scacchiera, però, si gioca qualcosa di più di una partita e Tom, con il suo alfiere d’ebano nero sta combattendo per la sua gente, per la sua razza: la battaglia si sposta così, virtualmente, mentalmente, nelle foreste delle colonie, dove Tom, per vincere, ha un motivo che il bianco non ha.
Il pugno chiuso,12 considerato da Remo Ceserani «forse la più perfetta “novella fantastica” prodotta in Italia nel secondo Ottocento»,13 è un racconto dalla trama complessa, in cui all’estrema attenzione per i particolari realistici si mescola un’aura fiabesca.
Nel settembre del 1867 il narratore, un medico, si reca in Polonia per studiare una grave malattia tricologica, la plica polonica, e a Czenstokow, durante le feste in onore della Madonna nera, entra in contatto con numerosi malati che chiedono l’elemosina. Tra di loro c’è Paw, uno straccione più malato degli altri, che tiene costantemente chiuso il pugno destro. Nella calda penombra di una taverna, Paw racconterà al medico una doppia storia intrecciata: quella della propria malattia, sorta una notte in seguito a un terribile spavento, e quella dell’usuraio ebreo Simeòn Levy, che di quello spavento era stato la causa. Per cumulare un tesoro da un milione di fiorini al ricco Levy mancava una sola moneta d’oro, quando una notte, il suo ultimo debitore, un giovane morto da poco, gli si presenta in sogno riemergendo dal sepolcro, per estinguere il suo debito e consegnargli un prezioso e antico fiorino. Il vecchio avaro lo serra nel pugno, ma al suo risveglio la mano non si aprirà più, finché, disperato, non la farà saltare con la polvere di dinamite proprio dinanzi agli occhi di Paw, che raccoglierà la moneta maledetta da terra, subendo la stessa «maledizione». Terminato di raccontare il suo doppio racconto al medico, Paw, forse per lo stress o forse per il troppo rhum bevuto, cade in preda al delirio e viene trasportato agonizzante in un letto. Vegliandolo al capezzale, il medico riflette sulla storia che ha appena ascoltato e inizia a pensare che Paw sia vittima del «contagio dell’allucinazione», una sorta di «fissazione maniaca», come quella che a suo avviso induce la comparsa delle stigmate sulle mani dei ferventi credenti. Alla morte di Paw, circondato dai suoi compagni di malattia e di elemosina, che vogliono a tutti i costi aprirgli il pugno per vedere il fiorino maledetto, il medico, per distruggere le loro superstizioni, prende un martello e gli spacca la mano: dal pugno chiuso del malato non esce nessun fiorino. Alla fine della storia, inoltre, il medico non scioglierà il proprio dubbio scientifico, perché non saprà spiegare se la plica sia una malattia che ha la sua origine nella mancanza di pulizia, come sostengono gli igienisti, o se sia invece contagiosa, come sostengono gli epidemiologi. Dall’ambito della certezza scientifica il racconto è infatti slittato, grazie alla presa alla lettera di una metafora, nell’ambito perturbante della psicologia: Paw gli ha raccontato di aver preso la plica, quando gli si sono letteralmente «rizzati i capelli in testa» per lo spavento.
Passando a Camillo Boito, i suoi due racconti più prettamente fantastici, Un corpo14 e La macchia grigia,15 sono tra i più complessi e i meglio riusciti dell’intera stagione scapigliata.
Un corpo esprime in maniera perturbante il rapporto vampiresco che la Scienza e l’Arte instaurano con la Vita. In una Vienna di metà Ottocento, Carlotta, la bellissima ragazza amata dal narratore e da lui ritratta in un quadro che rappresenta Aretusa, diventa l’oggetto del macabro desiderio dell’anatomista Karl Gulz, che, sezionandola sul proprio tavolo di marmo, vuole rubare alla fisicità, all’anatomia del corpo il segreto della sua B...