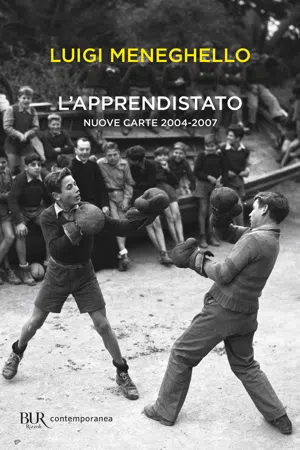[1] Federico innamorato, un’icona. Il suo amore era in realtà una forma di malattia: struggente, spossante, nutrito di debolezza. Gli modificava i placidi tratti del viso, come si vedeva nel drammatico ritratto che gli aveva fatto un amico – il più acuto e più umano di noi – con ardite, commoventi macchie di verde ramarro e rosso mattone: una pelle devastata dall’amore, un viso in subbuglio. Ma grondava malacia amorosa anche il resto di Federico, la fiacchezza del corpo, il cappotto color tortora, troppo attillato e troppo lungo, che lo fasciava come un sudario.
Eravamo un gruppo di coetanei amici, nello sciame dei compagni di studi a Padova, nei primi anni della guerra: la fauna del Liviano, di cui si vedono ancora le facce e le fogge negli affreschi di Massimo Campigli nell’atrio. Ragazzi carichi di elettricità, in bilico su un discrimine. Pochi e poco importanti se visti contro il fondale della storia europea di quegli anni: quattro gatti, ma intensissimi gatti.
Io vivevo con Federico, alloggiavamo insieme dalle parti di Santa Sofia, e ho condiviso, si può dire, il corso dei suoi travagli amorosi. A volte, con assurdi intenti terapeutici, cercavo di spiegargli che l’Amore non esiste, e dunque non è il caso di perderci i sonni: ma ciò che non osavo dirgli era: “Federico, perché ami così? Non senti il vuoto funebre che assedia il tuo amore? Forse agli occhi di lei sei solo un innamorato di comodo, e il costrutto poco meno che sacro della faccenda è solo una tua fantasia...”. La portava davanti a un altare, in chiesette oscure, e la prendeva solennemente in moglie, facendo da sposo e da officiante, «io Federico prendo te Maria Matilde... eccetera», per l’eternità naturalmente.
Lei aveva oscure ambiguità, pareva uscita dai libri di Guido Piovene, con una carica sensuale intensa ma coperta, semi-segreta. Le piaceva l’impero sulla personalità di lui, sulla sua stessa persona fisica, le magre spalle, la debolezza del petto e dei fianchi, fino al grumo del fagottino genitale che gli occhi di lei avevano messo a fuoco un giorno in treno, da Padova a Vicenza, nell’austero lusso del velluto grigio-a-righe delle seconde classi di allora.
Erano conturbanti i capelli di lei, strettamente imparentati con la chevelure della donna di Baudelaire. Nella nostra camera leggevo a Federico il pezzo in prosa nello Spleen che ci pareva, a me e a lui, più emozionante della versione “poetica” rimata, nei Fiori. Lì risaltava più netto, più naturale, l’impulso di mordere quei capelli ricciuti, afforestati: e la clausola finale «quando mordicchio i tuoi riccioli elastici e ribelli, mi sembra di mangiare dei ricordi» dava secondo noi nel sublime. Roba parigina.
E il profumo di quei riccioli, così poco euganeo o berico? Quel sentore di muschio, d’olio di cocco e di catrame: eh sì, catrame, l’icastico ludrón della nostra madrelingua, la zaffata dell’asfalto in fermento... Sì, c’era tutto questo nelle ricche trecce di Maria Matilde, fino all’estasi rivoltante del ludrón... Insomma, si può dire che ho fatto anch’io la corte, un po’ dall’esterno, a quella iconica donna.
***
[2] Legami di amicizia negli anni di studio in quel tempo di guerra: provvisori per lo più, e vivaci – “deboli” ma importanti, si direbbe, come quelli dell’idrogeno nella molecola dell’acido nucleico. Per qualche mese cruciale, le brevi, sconfinate stagioni di allora, Federico e la sua compagna legarono intensamente – il legame partiva dalle due donne, credo – con una coppia di quasi opposto stampo. Non c’era traccia di romanticismo tra Gualtiero e la bionda Lina, o non si vedeva. Lei del tipo biondo slavato, esile, composta: lui aitante, irruente, atletico, bizzarro. Tra loro pareva possibile solo un rapporto di amichevole prepotenza. Era ovvio che lui rischiava (inavvertitamente) di stritolarla, ma per fortuna nella sua foga c’era qualcosa di cordiale, di bonario. Attorno a questi quattro si era formato un ristretto nucleo di compagni più o meno di elezione, accoppiati o spaiati, gente di Lettere, o turisti delle altre facoltà, venuti inizialmente per «vedere le ragazze».
Un po’ ai margini di questo club informale c’ero anch’io, una specie di socio corrispondente. A un certo punto si diffuse tra loro l’idea di una sorta di sondaggio. Qual era la donna più splendida nel gruppo, e quale il suo compagno ideale? Le donne (ma erano poi loro le animatrici) non avevano dubbi: il mistero di Maria Matilde e l’irruenza di Gualtiero... la coppia perfetta era quella, a incrocio rispetto alle coppie reali.
La scelta (unanime) di Gualtiero mi diede un po’ di fastidio. Gualtiero aveva un certo prestigio per l’asciuttezza tagliente del fisico, lo slancio scanzonato, il piglio sportivo e l’inventività capricciosa del modo di vivere: ma non mancava di profondità? oltre che ovviamente di riserbo... Insomma ero quasi offeso di non essere stato io a venir scelto, fuori concorso, come compagno ideale della donna di Federico.
Purtroppo fui invece oggetto di un’altra scelta maturata nel seno del gruppo. Essendo io disaccoppiato, si pensò di organizzare una campagna promozionale per consociarmi con una di noi, l’Alicia, a sua volta temporaneamente scompagnata. Sul momento non mi accorsi di nulla, e penso che anche lei non fosse stata avvertita. E così noi due cominciammo a incontrarci un po’ più spesso, a sostare in chiacchiere nelle sale di ritrovo (ci lasciavano “soli” ad arte), sederci accanto alla mensa, uscire in compagnia, prendere insieme il filobus, aspettare il treno alla stazione.
Era bella l’Alicia? Sì, era bella. Bella in chiave raffaellesca, ovali di velluto, occhi specchianti, placida e prospera venustà delle forme. Un corpo fiorente, di giovane donna, non di ragazza... E allora? perché non mi accesi? Perché non si mosse nulla di intimo dentro di me? Veramente, capisco oggi che in uno strato più profondo della mia intimità – dove pare che anche le donne di Raffaello entrino in opera – l’Alicia doveva aver guizzato. Guizzato è la parola, l’avevo sognata in un contesto acquatico, quasi ittico. Non tutta lei, solo una sua gamba, nitidamente separata dal resto, e vista di fianco. Galleggiava in un tratto di mare vicino a me, dondolando. Una gamba di squisita fattura, nella guaina della calza di seta... dal piede senza scarpa fino a un ricco tratto sopra il ginocchio, a metà coscia. Non era la riproduzione eidetica di una gamba vista con gli occhi, o immaginata, era molto più intima, l’avevo creata io: e benché fasciata dalla seta faceva l’effetto di essere profondamente nuda. La sua essenza reale mi sfuggiva, un po’ pareva un pesce di foggia preternaturale, un po’ un lacerto della Signorina Grandi Firme. L’identità di fondo non era in dubbio. Ma il sogno non lasciò conseguenze.
Uscivo a passeggio con lei, le parlavo con garbo, senza accostarmi davvero. Una volta la portai al cinema: mi sedeva quietamente accanto. Io guardavo il film, a un certo punto girai lo sguardo verso di lei, vidi la sua faccia illuminata a sprazzi dai riflessi dello schermo. Aveva chiuso gli occhi, compostamente, e piangeva. Lagrime tranquille, sconsolate le rigavano il viso.
D’un tratto mi parve di vedere le cose per il verso giusto, e mi sentii in colpa, irrimediabilmente del resto. Non era il caso di ricorrere alle scuse poetiche, provare a dirle: “Alicia, non cercare il mio cuore, lo hanno mangiato le bestie” o qualche altra elettrizzante balla lirica dei miei francesi: roba di un altro secolo, merce scaduta. Il discorsetto di scusa non sarebbe stato del tutto senza costrutto, ma non c’entravano le bestie... Sopravvenne invece un’ondata pungente di compassione, di rammarico e di simpatia, che restò poi alla base dei nostri rapporti personali.
***
[3] Ciò che amavo, lì a Padova, era la tabaccaia del bar di Piazza Spalato. Nel pensiero la chiamavo la tabaccaia dello schermo, perché somigliava alla sibilla Delfica, quella della Sistina, l’amore celeste di cui erano prigionieri i miei sensi. Le somigliava in modo impressionante. Aveva gli stessi occhi, la bocca, la bellezza eroica del viso... Il corpo, non potrei dire: la tabaccaia delfica stava dietro il bancone del bar, e io andavo da lei con la scusa di comprare i cerini. Ne avevo una raccolta ormai, in camera, non fumavo a quel tempo.
[1] Racconta Bruno, sempre in giro per l’Africa, che al lago Giulietti, in Dancalia, nuotando per circa un chilometro verso il largo, si tocca ancora. Giulietti per la verità non c’è mai arrivato, è Franchetti che l’ha scoperto, e col suo nome si chiama l’isola di melma in mezzo al lago. A est del lago c’è un vulcano, e a Roma una baronessa, figlia dello scopritore suppongo, che si chiamano Afdera.
***
[2] Reading, anni Cinquanta.
Qui ogni tanto arrivano italiani di passo, e a ciascuna visita misuro la velocità con cui ci allontaniamo. Come direbbe il massimo dei nostri poeti minori viventi, non è facile sapere chi va e chi resta.
Arriva Giacometti, chimica molecolare, calmissimo. È stato due mesi a Cambridge, sta tornando in Italia. Si sente subito che è un uomo con le carte in regola. Non ama la carriera di amore profondo, ma la farà.
Andiamo a passeggiare lungo il fiume, attraversando la zona dei gassometri. Vedo le cose coi suoi occhi: fanno spavento. C’è il branco dei cigni insudiciati, proprietà della Regina, spiego: ogni tanto li devono catturare per lavarli, altrimenti muoiono. Nel tratto erboso tra il fiume e il terrapieno della ferrovia, ci sono anfratti dove giacciono abbracciate alcune coppie, umane, terminalmente si direbbe.
Il fiume è a livello dei prati, largo una cinquantina di metri. Dico al mio compagno che qui il Tamigi è poco largo ma profondo, perché è stato canalizzato come si deve. Vorrei fare bella figura almeno per ciò che riguarda il fiume, ma poi sento che con questo amico non occorre, è una persona semplice e pratica, non fa teorie sugli inglesi. La sgradevole necessità di contraddirle svanisce.
Giacometti non tornerà a sistemarsi in Inghilterra, farà carriera in Italia. La cattedra già gli spunta sotto la schiena, in maniera del tutto normale. Per questo rispetto è lui l’inglese elettivo.
Mi parla del più e del meno, e la sua testa, la sua grossa testa rapata, mi appare un prodotto casalingo, affidabile. Sento che mi riposo in sua compagnia. Tra l’altro ha un certo riguardo per me, mi considera un vero umanista. Non faccio nulla per disilluderlo, non è importante. Dunque, lui avrà l’incarico entro un paio di anni, sui trenta-trentacinque la cattedra al sud, prima dei quaranta sarà insediato a Padova. Farà studi rispettabili, modesti: non cambierà il quadro delle scienze chimiche, e non gli interessa cambiarlo; avrà famiglia onestamente, tutto quello che farà sarà onesto, anche qualche piccolo sproposito privato, se ne farà. Un accademico intelligente e tranquillo, un “intellettuale” senza rovelli e senza pretese, in armonia con se stesso e con la società. Chi lo crederebbe, che la natura faccia ancora di questi scherzi in seno alla mia generazione?
Il poco che diciamo insieme sull’Italia mi fa quasi sembrare sensata anche l’Italia. Mi sento io stesso, incongruamente, disposto al buon senso – l’espace di un pomeriggio.
***
[3] Una sera sul tardi passa da noi Agostino Costa, preceduto da lettere e telegrammi e incalzato, si direbbe, dalle Furie. È azzimato, un dandy. Ma è in preda a un eccesso di eccitazione. È qui per un viaggio di ricognizione, e ne parla in modo febbrile: dà l’impressione di aver fatto e visto cose straordinarie, corso rischi, azzardato approcci, trovato aperture. Si direbbe che il mondo, cioè il contatto improvviso col mondo di qui, gli abbia dato alla testa, e insieme lo abbia impaurito. Sotto i suoi racconti eccitati, farraginosi, ellittici si avverte distintamente l’enzima di un’apprensione quasi spasmodica. Forse è l’effetto dei cinque anni di prigionia in India, col ritardo – il presunto ritardo – accademico che ne consegue. Ora si è trovato direttamente a contatto col mitico ambiente degli studi di storia dell’arte accasati quassù, ed è come elettrizzato, e insieme insidiato da oscuri patemi. Si lascia travolgere. Non osa dire “cuccia!” alle Furie. Ma cosa vogliono veramente da te? Calmati, prova a sentire. Tratta.
Continua ad alzarsi dalla poltrona, deve passeggiare raccontando. Tenute di campagna, castelli, istituti, persone, personaggi, una febbre che gli lustra gli occhi. Allude turbinosamente a cose che non capiamo. Più ferve e freme e brilla, e più si vede il filo rosso dell’apprensione.
Penso che non ce la farà per la cattedra. Ha ingegno e intuito e passione, ma è troppo sbilanciato. Ha deposto in entrata una valigina elegante. Prende in giro gli inglesi, molto spiritosamente. Scherzando sugli inglesi si disacerba un po’. Mi sento anch’io divertito, e insieme vagamente impermalito. Ho torto: sono forse io il custode degli inglesi?
Guardo lo show del mio amico e mi vengono in mente quelle trottole, nel paradiso di Dante, che vorticano emettendo note. Una raffinata nevrosi isterica.
Fermati. Siediti. Perché non parliamo di storia dell’arte?
***
[4] E una mattina, cauti cauti, con passi felpati, mi arrivano in casa i due banditi di Padova. Hanno barbe non rase, da fuorilegge, cachettiche. Sono cordiali, e pare che mi stimino. Sono scadenti. Si considerano estremisti. Si spartiscono a memoria gli assistentati disponibili, e alcuni altri.
Hanno intuizioni vivaci, svelte. Dicono che qui ci si sente come sulla tolda di una nave, l’Inghilterra è in mezzo ai flutti, per questo la spazzano i venti. E io che sono qua da tanti anni non ci avevo pensato. Si associano al mio breakfast animosamente. In pratica me lo sequestrano, non ne resta molto per me. Parlo di Domenico Rea, perché ho letto da poc...