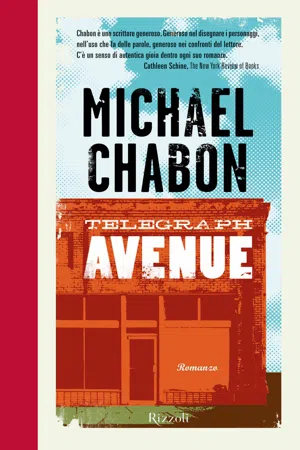![]()
IV
Ritorno all’eterno
Un cambiamento di stato. Molecole in transizione, da liquido a gassoso. Una tazza cinese da quattro soldi da cui, come un aquilone, si levava un drago di vapore.
«Basta dormire!» disse Irene Jew. Con un sibilo, la tendina abbandonò la sua postazione, e dalla finestra fece irruzione la luce del sole. «È ora di alzarsi. Giorno importante!»
Gwen aprì gli occhi. Il pulviscolo tracciava arabeschi nel bagliore: molecole in transizione. E anche Gwen non era che una grassa, gigantesca molecola, sballottata qua e là nello spazio.
«Giorno importante» rispose ironica. «Sai che roba.»
Ormai il suo mondo consisteva di quattro pareti e una finestra solitaria nel retro del dojo, nascoste dietro una porta senza maniglia, a sua volta celata da una fotografia, a grandezza naturale e a figura intera (pettorali e addominali lustri, pantofola sul piede destro levato in aria, denti stretti in un sorriso rapace), del nume tutelare cui era intitolato il Bruce Lee Institute of Martial Arts. La vita di Gwen era un sacco a pelo e un borsone blu, un pasto incartato in un sacchetto, e ogni giorno aggiungeva un’altra penosa pagina alla storia dei senzatetto.
Nella femmina gravida, la trentaseiesima settimana era terreno fertile per l’autocommiserazione e i pensieri di Gwen al risveglio ne erano la prova definitiva.
La maestra Jew reggeva la tazza, col suo paesaggio di montagna dipinto, fra le mani minuscole, allenate tanto a riparare e guarire quanto a sferrare colpi, secondo gli insegnamenti di Lam Sai Wing, che a sua volta aveva studiato col grande medico e raddrizzatore di torti Wong Fei Hung. Stava accovacciata accanto al materassino nei suoi pantaloni di cotone neri e nella tunica bianca informe, in attesa che la sua ultima ospite nascosta nonché fonte di irritazione si decidesse ad alzare almeno la schiena dal sacco a pelo. Gwen prese la tazzina fra le mani smisurate che avevano sorretto i teneri crani di mille neonati, mani la cui abilità era frutto di una formazione che si poteva far risalire fino al diciannovesimo secolo, e a una levatrice di nome Juneteenth Jackson, originaria di Tulsa, nell’Oklahoma, bis-bisavola di Gwen.
«Acqua del rubinetto calda» commentò Gwen con una smorfia. Il suo tono malediceva non solo l’idea di bere acqua calda di rubinetto, ma anche la serie di eventi che l’aveva condotta a un altro risveglio solitario in quello sgabuzzino fatto passare per stanza, il cui unico ornamento era un vaso Ming da quattro soldi nel quale era infilata una gerbera di plastica rossa che in realtà era una penna a sfera. A quel futon dozzinale che odorava di waffel stantii. Al momento in cui una tazza di acqua calda di rubinetto doveva – lei non osava dire di no alla maestra Jew – essere bevuta. «Quel che mi serve è una tazza di caffè.»
«Caffè agita bambino» sentenziò la maestra Jew. «Poi un giorno lui scappa di casa.»
Era evidente, quindi, che insieme alla tazza d’acqua calda Gwen doveva accettare un’implicita critica alla sua fuga da casa e dal focolare. D’altronde non ci si poteva aspettare che un maestro di kung fu cinese e novantenne, benché di sesso femminile, avesse una visione particolarmente progressista dei rapporti fra marito e moglie.
Gwen bevve e si stupì, come sempre, del sapore piacevole che aveva in realtà l’acqua calda, del senso di benessere che procurava mentre scendeva nella gola e nell’esofago, del modo in cui sembrava allentare una corda o sciogliere un gelo che nemmeno sapevi di avere dentro di te. La maestra Jew sosteneva di poter curare ogni sorta di disturbo senza nient’altro che un sigaro di artemisia e la regolare assunzione di acqua moderatamente calda. Nel buio del ventre di Gwen, il figlio o la figlia del suo inetto marito diede un lieve calcetto di gratitudine.
«Come va schiena?» domandò la maestra Jew.
Gwen si appoggiò le dita sul fondoschiena per palparne i muscoli. Negli ultimi giorni, la gravidanza le aveva fatto scoprire nuove e dolorose funzioni dei maggiori gruppi muscolari. Si svegliava in compagnia di crampi, acciacchi da nonnetta, rigidità articolari. Si strinse nelle spalle. «Fa male.»
La maestra Jew s’inginocchiò dietro a Gwen e le affondò le dita alla base dei lombi come un giardiniere in procinto di trapiantare un croco. Gwen inspirò bruscamente per il dolore, ma il tocco ruvido e improvviso delle dita fresche, asciutte e morbide della vecchia fu uno shock per il suo cuore in esilio. Gwen amava la maestra Jew nel modo in cui si amano i maestri di kung fu: furiosamente, come i bambini.
«Meglio» disse la maestra Jew.
«Un po’» ammise Gwen.
Era quello il motivo che l’aveva spinta a intraprendere e a proseguire gli studi al Bruce Lee Institute, allenandosi duramente per quasi quattro anni fino a guadagnarsi la cintura nera: perché al qi gong, come alla maestra Jew, non importava affatto se ci credevi o no.
Gwen restituì la tazza vuota all’anziana donna, che riconobbe senza gesti né parole l’espressione di gratitudine nei suoi occhi. La maestra Jew notò anche un che di appesantito nei graziosi lineamenti di Gwen, un che di tremulo nel suo sguardo. Pareva che nel giro di una notte avesse raggiunto il culmine della gravidanza. Mancava così poco all’arrivo del bambino, e la vita di quella donna era tutta in disordine. Lavorava troppo. Si prendeva cura delle altre future madri e intanto trascurava se stessa. Come se non bastasse, aveva trascorso le ultime tre notti in quello stanzino, un mondo angusto e crepitante di energia maschile. La maestra Jew espettorò una pillola di catarro e con felina delicatezza la depositò in un fazzoletto di lino.
No, così non andava.
Quando Gwen si era presentata al corso lunedì sera, con il borsone nel cofano della BMW decappottabile e tracce di lacrime sulle guance, qualche istinto radicato in profondità aveva spinto la maestra Jew ad arrestarne la caduta. Ma ora l’insegnante capiva di non aver gestito la faccenda come avrebbe dovuto. Irene Jew era una donna molto vecchia – amava vantarsi, in modo improbabile, di essere la cinese più vecchia a ovest delle Montagne Rocciose – e nei suoi lunghi anni di esilio e vagabondaggi, dal Guangdong a Hong Kong a Los Angeles a Oakland, aveva conferito a innumerevoli studenti la fascia nera che coronava lo studio più lungo e l’allenamento più faticoso, e il dolore, la devozione, il tedio e l’impegno che essi comportavano. Alcuni di quegli studenti avevano dato dimostrazione di abilità straordinaria, altri di vero e proprio genio, e pochi avevano esibito entrambe le qualità insieme. Finora, però, nessuno era stato una donna di colore incinta che guidava una BMW. Con Gwen Shanks, la maestra Jew non sapeva mai bene come comportarsi.
«Questo posto molto male per te» disse. «Cattivo odore. E anche per occhi. Brutto.»
«Sì.» Gwen emise un suono, un respiro strozzato che avrebbe potuto preludere tanto alle lacrime quanto a una delle sue grasse, fragorose sghignazzate. Si massaggiò il viso, abbassò le mani e aprì gli occhi. «Cioè no, va bene. Però. Mi scusi.» Si sporse per prendere la giacca da camera di seta buona, marrone metallico, che giaceva piegata accanto al futon, e se la mise intorno alle spalle. Indossava un pigiama di seta abbinato, con i bordini bianchi. «Ho solo bisogno di una notte di sonno decente.»
Il borsone era lì aperto, con tutti i vestiti, le scarpe e i flaconi di cosmetici racchiusi in bustine di plastica. Era ora di alzarsi e vestirsi per quella giornata importante; alle tre di pomeriggio, lei e Aviva dovevano comparire di fronte a una commissione incaricata di confermare o revocare loro la licenza a operare dentro le mura dell’ospedale. Gwen guardò i vestiti che aveva ficcato nel borsone tre sere prima, le canottiere elasticizzate sformate e i pantaloni da yoga, i reggiseni assurdi e le mutandine geriatriche. «Solo una notte di sonno decente.»
«A te serve cuscino.»
«Sì» disse Gwen, ripensando con nostalgia al lungo, fresco cuscino per il corpo della Garnet Hill che per mesi, stretto fra le sue gambe, fra le braccia e sul ventre, era stato il suo amante più fedele. «Eccome se mi serve il cuscino, da morire.»
«Tu va casa» disse la maestra Jew. «Prende.»
«Non posso.»
La maestra Jew le voltò le spalle. In fondo alla stanza, oltre il pavimento di bambù della palestra, lucido e pieno di graffi, quattro alte finestre affacciavano sull’azzurro smagliante di un cielo estivo di Oakland screpolato dai pali telefonici. Dietro la carcassa di cemento del vecchio supermercato Golden State, una palma si sollevava le gonne verdi da sgualdrina.
«Va bene, lo so che devo sloggiare. Le sono davvero grata per avermi permesso di stare qui così a lungo. Superata la giornata di oggi andrò in un albergo, poi mi affitterò un appartamento. Uno di quei posticini giù a Emeryville, vicino al cinema. C’è un’Ikea proprio accanto. Mi compro una culla, un po’ di stoviglie. Tutto quel che può servirmi. So che me ne sono stata qui a fare il muso e piangermi addosso. Mi fa male la schiena, e forse ero un po’ sotto shock. Ci sono un sacco di cose che non so. Se sarò in grado di badare a un bambino da sola. Se potrò continuare a fare il lavoro che ho fatto negli ultimi dieci anni.»
La maestra Jew continuava a darle le spalle, e Gwen capì che il suo discorso era stato irrispettoso e sconsiderato, sia nella lunghezza, sia nel tono.
«Mi spiace» concluse Gwen. «Dico sul serio. Domani, o al più tardi dopodomani, mi levo di torno.»
Gwen si ritrovò in faccia la tazza – più piccola della prima, rossa e dorata con un intricato motivo geometrico e un pesce rosso – prima ancora di accorgersi che la maestra Jew si era mossa, un brusco intoppo della visione, come un blackout o il flash di una macchina fotografica, e quando si rese conto che la vecchia pazza le aveva davvero lanciato contro una tazza mirando alla testa, il palmo della mano destra le doleva, e la tazza intercettata posava fredda contro le sue dita, riversando alla base del pollice un’ultima goccia del suo contenuto.
«Questo è giorno importante. Tu veste» disse la maestra Jew. «Poi va e prende cuscino.»
Gwen era inquieta circa la propria posizione, il proprio status sotto il suo stesso tetto. Così aveva in mente una sorta di Grenada coniugale, l’impiego di forze ingenti a sostegno di un obiettivo modesto, persino risibile. Ma quando passò con l’auto davanti alla casa addormentata, alle 6.51 (un orario con cui il marito non era mai entrato in intimità), quella le sembrò tanto ordinaria, con le tegole di cedro dipinte di azzurro tutte scrostate, il caprifoglio che strangolava le doghe dello steccato, i serbatoi vuoti del distributore d’acqua allineati sulla veranda, da farle passare ogni voglia di combattere. Oltrepassò la casa, e per un istante accarezzò l’idea di non fermarsi.
In effetti, come aveva detto alla maestra Jew, il cuscino per il corpo non si limitava ad agevolarle il sonno: c’erano notti in cui le pareva fosse l’unica cosa al mondo in grado di sentirla e comprenderla. Fedele al suo nome, il cuscino per il corpo dava corpo all’essere sconosciuto dentro di lei, muto e informe, ma imbevuto di una qualche distinta essenza o presenza del bambino che sarebbe venuto. Il cuscino era una bambola che lei di notte cullava mentre, nei suoi bizzarri sogni di gravida, il bambino si trasformava in ogni specie di bestia e vegetale e cose assai più strambe di un cuscino. Allo stesso tempo, Gwen lo sapeva, era solo un cuscino per il corpo da quarantacinque dollari che aveva comprato su internet. Si poteva facilmente sostituire.
«Un corno» disse ad alta voce, e parcheggiò davanti alla casa dei Lahidji. «Io voglio il mio maledetto cuscino.»
Non scese dall’auto. Fece un po’ di respirazione qi. Tentò di afferrare la perlina sfolgorante al centro del suo essere. Cercò di imbrigliare o quantomeno riordinare il proprio qi. Per quel giorno aveva già abbastanza conflitti da gestire, si rammentò, per non parlare dello stress, misurabile in rad, a cui lei e il bambino erano stati esposti. Eppure, il senso di sdegno per tutto quel che Archy aveva fatto e trascurato di fare come marito, come padre e come uomo, non diminuiva di fronte alla sua riluttanza ad affrontarlo, e quello sdegno si fissava, sciamando come una nube d’api, intorno alla somma di quarantacinque dollari. Quei soldi non aveva intenzione di buttarli. Aveva lasciato nella casa molte cose di valore, quando aveva mollato Archy, e se non ne avesse riavuta indietro nessuna, pazienza; almeno il cuscino doveva riprenderselo, per riscattare tutta la vita e gli oggetti abbandonati. Scese dall’auto. Aveva solo una strada davanti a sé: entrare non come un battaglione di marine che irrompe su una remota isoletta di palme da cocco, ma come i corpi speciali: chirurgica. Furtiva. Toccata e fuga.
Decise di provare prima la porta sul retro. Scivolò – senza molto spazio libero sui lati – lungo l’irregolare pelle di serpente del vialetto di mattoni che correva fra la casa e un reticolato metallico, tutto intessuto d’ipomea come una sorta di cestino inselvatichito. Sgattaiolò davanti alle finestre della cucina, i bidoni dell’immondizia e del riciclaggio, lungo tutto il lato ombroso della casa, che negli anni di rado aveva affrontato, un passaggio denso e frondoso, ospitale, o così aveva sempre immaginato, per i ratti. Il pensiero le fece accelerare il passo.
Il cortile sul retro era messo peggio di quanto ricordasse. La zona barbecue di mattoni, l’alberello di datura coi suoi cappelli da mago gialli, la rete metallica inghiottita in più punti da verdi ondate di edera, gelsomino e ipomea. Il pennacchio sfrangiato di erba della pampa. La desolata distesa di cemento che un inquilino precedente, per eccesso di pigrizia o di ottimismo, aveva dipinto di verde prato. Era una giungla misera, incolta e spelacchiata, in grado di deprezzare gli immobili nel raggio di molti isolati, fino a Claremont Avenue. Era vergognosa. Ma Gwen se n’era andata soltanto da una settimana; quella rovina era l’opera di anni. Un documento fedele della sua vita trascurata.
Distolse lo sguardo dai graticci rotti intorno alle fondamenta della casa, dalle guarnizioni scollate che facevano capolino dalle giunture della porta sul retro come i boxer del membro di una gang dai pantaloni. Quando lei e Archy l’avevano comprata, la casa era fatiscente, a buon mercato ma tenuta malissimo. Avevano stilato un el...