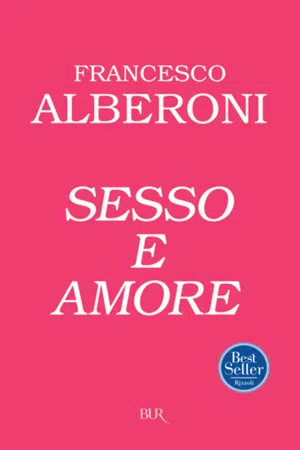CAPITOLO PRIMO
LA COMPLESSITÀ DELL’EROTISMO
1. Sessualità e amore
Nell’animo umano agiscono impulsi contrastanti che creano dubbi, dilemmi, e portano ad agire in modo contraddittorio. Due di queste tendenze che possono entrare in conflitto, rappacificarsi, o scontrarsi di nuovo nel corso della nostra vita sono la sessualità e l’amore. Non sempre ce ne rendiamo conto perché sessualità ed amore ci si presentano spesso fusi, oppure perché in molti casi l’amore sboccia dalla sessualità. Ma la ragione principale della confusione è un’altra: nell’ultimo secolo ha prevalso una scuola di pensiero, la psicoanalisi, che tende ad identificare il piacere, l’amore e il sesso. È sessuale, appartiene alla sessualità orale, il piacere del bambino che, attaccato al capezzolo, succhia il seno. È sessuale, appartiene alla sessualità anale, il piacere di rilassare gli sfinteri nel defecare. Sono forme di sessualità pre-genitale che poi continuano nella vita adulta anche quando si è imposto il primato della sessualità genitale. Ma hanno origine sessuale non solo i piaceri, anche i sentimenti del bambino verso sua madre. È sessuale la gioia, la felicità che prova quando, dopo averla cercata, angosciato le corre fra le braccia e si addormenta dolcemente sul suo seno. È sessuale il desiderio che provo osservando una ballerina, quello con una prostituta, la passione che sento per la mia amata, il desiderio spasmodico di vederla quando sono lontano, la gioia di sentire la sua voce dirmi “ti amo”. Insomma è sessuale tutto.
Troppe cose insieme. Dopo un secolo di adesione pressoché unanime a questa tesi, pur riconoscendo a Freud l’immenso merito di aver capito l’importanza della sessualità nella vita umana, è venuto il momento di tornare a ristabilire alcune distinzioni elementari. Anche prendendo in esame solo l’adulto, e in quella che Freud chiama sessualità genitale, resta pur sempre una differenza fra l’accoppiamento frettoloso, il passaggio per curiosità da un letto a un altro, la passione disperata verso il nostro amato o la nostra amata, e la dolce tenerezza che proviamo verso nostro figlio o nostra figlia.
Esiste una sessualità intrisa di amore ed una che non ha nulla a che fare con esso, anzi che gli è addirittura antitetica, come lo stupro, soprattutto lo stupro compiuto in caso di guerra, di saccheggio. Nelle guerre antiche la città conquistata veniva saccheggiata, i maschi, compresi i bambini, uccisi e le donne stuprate. Ma ancora nel secolo scorso i guardiani tedeschi delle SS hanno usato come prostitute le ragazze ebree prima di ucciderle ed i soldati russi che avanzavano su Berlino hanno stuprato centinaia di migliaia di donne tedesche che fuggivano davanti a loro.
Vi sono poi forme di sessualità non violenta totalmente separata dall’amore, come quella impersonale dell’orgia in cui ci si accoppia indifferentemente con l’uno o con l’altro. Infine abbiamo dei casi in cui il desiderio sessuale non si accorda, ma ci mette in conflitto con chi amiamo.
La sessualità, ci ricorda Bataille,1 è sfrenatezza, violazione delle regole, dei tabù, dell’ordine del dovere quotidiano. Vive nel presente. È capriccio, dissipazione, dimenticanza dei doveri, delle preoccupazioni. Per l’adulto è il massimo del gioco, anche dal punto di vista dello scatenamento del corpo. Lo sport richiede disciplina, regola. Solo la danza può essere spontanea, ma non arriva agli eccessi dell’erotismo. La sessualità, perciò, sembra più adatta a rompere i legami che a crearli. Eppure proprio il grande amore, l’amore appassionato dell’innamoramento che stabilisce legami emotivi fortissimi e nuove regole di vita, nasce spesso anch’esso dalla sessualità e ne costituisce il trionfo.
Nel libro Ti amo2 ho distinto i legami emotivi in deboli, medi e forti. Legami deboli sono quelli che abbiamo con i conoscenti, i vicini di casa, i colleghi. Ma anche quelli che abbiamo con una prostituta o che stabiliamo con una persona con cui abbiamo un rapporto sessuale occasionale. Il puro rapporto sessuale, da solo, non stabilisce legami forti. Fra i Legami medi ricordiamo quelli con gli amici. Ci confidiamo con loro, ne abbiamo fiducia, ricorriamo al loro aiuto. Ma, mentre quando il figlio si comporta male con sua madre questa continua ad amarlo, quando l’amico ci mente o ci tradisce, il rapporto si rompe. Sono medi anche i legami erotici che durano finché ci danno piacere, e svaniscono alla prima difficoltà e dissapore. Sono invece Legami forti quelli che si stabiliscono fra figli e genitori e fra genitori e figli. Infatti resistono a delusioni, a dolori ed amarezze. Sono però forti anche i legami creati dall’innamoramento perché continuiamo ad amare anche chi ci fa soffrire. Infine è un legame forte l’amore consolidato da una vita vissuta insieme per cui ciascuno è diventato indispensabile all’altro tanto che, quando uno muore, spesso l’altro lo segue.
Gli antropologi, dopo aver studiato i costumi sessuali e matrimoniali di centinaia di società e di culture, sono giunti alla conclusione che nella nostra specie c’è una forte tendenza alla monogamia, all’esclusività amorosa e sessuale. Però contemporaneamente, in tutte le società, esiste sempre anche un certo grado di infedeltà coniugale tanto nei maschi quanto nelle femmine. Esistono quindi in noi due tendenze, due desideri di base compresenti ed in conflitto. Quello che ci porta verso una persona particolare, unica, inconfondibile, con cui stabiliamo un legame amoroso duraturo e di cui siamo gelosi. L’altro è un impulso esplorativo che ci spinge tutti, maschi o femmine, a cercare incontri erotici e rapporti con persone nuove e diverse. È solo nell’innamoramento che i due impulsi coincidono perché si rivolge ad una persona nuova ma stabilisce un legame esclusivo. È per questo che l’ho studiato con tanta attenzione.3 Dopo Stendhal,4 infatti era stato trascurato. Esso sfuggiva a qualsiasi tentativo di spiegazione da parte della psicoanalisi e, per di più, la tradizione scientifica dominante, quella anglosassone, lo sottovaluta, lo ignora, lo considera un fenomeno culturale temporaneo. Al punto che non ha nemmeno un vocabolo per designarlo e lo chiama ancora “romantic love”, come se fosse sorto nell’Ottocento, quando basta leggere la Bibbia per trovarlo nel più remoto passato.
Nel campo dei rapporti fra sesso e amore, l’innamoramento esalta e fonde insieme il massimo della sessualità e il legame amoroso più forte. La sessualità conserva il suo carattere sfrenato, dirompente. Però l’innamoramento non si riduce ad un grandissimo piacere sessuale. È una rinascita, è giovinezza, eccesso, estasi. Spezza i precedenti legami, sospende la legge, instaura il proprio diritto sovrano. Trasfigura il mondo, ci mette in contatto con le sorgenti profonde dell’essere e crea un legame forte, duraturo, esigente. La donna innamorata antepone l’amato al padre, alla madre, al divo che preferisce. Il maschio vede nella sua amata la più seducente di tutte le etere, la più erotica di tutte le cortigiane.
Ma insistendo troppo sull’innamoramento si finisce per mettere in ombra, per svalutare l’importanza di altre esperienze erotiche e della sessualità in quanto tale. I due impulsi di cui ho parlato, quello che ci lega ad una persona e quello che ci porta a cercare il diverso, non scompaiono mai e se ora prevale il primo, poi può prevalere il secondo o possono manifestarsi anche tutti e due insieme.
È in base a queste considerazioni che ritengo sia venuto il momento di studiare in modo più approfondito e sistematico la grande varietà di rapporti fra sessualità e amore.
A partire dalla sessualità violenta, poi quella in cui non è nemmeno presente l’altro nella sua interezza, la sessualità impersonale. In seguito la sessualità in cui è presente l’altro come persona, ma non c’è ancora amore. Poi le relazioni sessuali con legami più o meno duraturi, fino al caso dell’innamoramento e a quello dell’amore che dura. Da ultimo il processo di de-erotizzazione del rapporto nato dall’innamoramento. Perché, dopo qualche tempo, la fusione fra amore e sessualità si indebolisce o si rompe. Le due tendenze che si erano fuse si separano e possono entrare nuovamente in conflitto. I mariti, anche quando continuano a volere bene alla moglie, si lasciano facilmente attrarre sessualmente da altre donne. Le mogli, pur continuando a voler bene al marito, si lasciano tentare da una avventura sessuale.
2. Linguaggio volgare e scientifico
Murray Davis, nel suo libro Smut,5 ha messo in evidenza che, per nominare gli organi e le attività sessuali, esistono due linguaggi completamente diversi. Da un lato il linguaggio popolare, volgare, osceno e, dall’altro, quello ufficiale, colto, perbene. Fra i due, vi è un abisso. O parli l’uno o parli l’altro, non puoi mescolarli. Ogni tanto alcune parole del linguaggio volgare passano nel linguaggio perbene e vi sono anche parole che fanno il percorso inverso. Ma, una volta avvenuto il passaggio, non puoi usare che un linguaggio o l’altro, senza mescolarli. Infatti se, parlando sul primo registro si inserisce una frase del secondo, o viceversa, si ottiene un effetto grottesco o comico.
Davis osserva che, nel Medioevo, la Chiesa aveva condannato in modo estremamente forte il sesso, però chiamava gli organi sessuali e gli atti sessuali con il nome corrente. Solo in seguito, soprattutto nel XVIII e nel XIX secolo, le espressioni popolari vengono considerate oscene, diventano impronunciabili, scompaiono dai dizionari. Questo risultato è prodotto da due processi opposti.
Il primo è compiuto da coloro che vogliono aprire uno spazio all’erotismo, fare letteratura erotica, come i libertini, che ci riescono eliminando le parole volgari per eludere la censura. Al loro posto introducono immagini, metafore che evocano l’esperienza erotica in modo nuovo. Poi nell’età vittoriana si cerca di eliminare ogni possibile riferimento al sesso in qualsiasi forma si presenti. Tutto ciò che ha attinenza col sesso viene omesso o sostituito con allusioni o metafore sempre più lontane dall’oggetto. Perfino la gravidanza diventa “stato interessante”.
Il secondo processo avviene nel XIX secolo con la medicalizzazione del sesso. L’anatomia dà un nome preciso agli organi sessuali e alle loro parti, mentre il nome volgare li indica globalmente. Si distingue il monte di Venere, la vulva con le grandi e piccole labbra, il clitoride, il secreto delle glandole del Bartolino, la vagina, il collo dell’utero ecc. Dall’altro lato, lo scroto, le gonadi, la prostata, le vescicole seminali, il pene, il glande, il frenulo, lo sperma. Sorge, nel frattempo, la sessuologia come disciplina scientifica separata e vengono descritte e nominate con accuratezza le varie attività sessuali e le “perversioni”. Sono di quell’epoca le espressioni coito, cunnilingua, fellatio, scoptofilia, coprofilia, onanismo, sadismo, masochismo, feticismo, urofilia, ipossifilia ecc. Altri contributi vengono poi forniti dall’antropologia che mette in evidenza le differenze fra i costumi sessuali e la moralità sessuale nelle popolazioni a livello etnologico.
È nato così un linguaggio scientifico internazionale asettico, che ha consentito di nominare, descrivere e analizzare i comportamenti sessuali senza mettere in moto l’emozione che viene sempre provocata dal linguaggio volgare, un’emozione che può essere di eccitamento, di disgusto o di rifiuto, ma è sempre intensa.
Perché esiste questa radicale dicotomia? Perché il linguaggio popolare, volgare suona osceno, però, contemporaneamente, produce eccitamento sessuale avvicinandosi alla pornografia, mentre quello medicale è preciso, consente di indicare ogni cosa ma non produce nessuna emozione erotica?
Nel suo noto libro Fare l’amore lo psicologo Eric Berne spiega il linguaggio volgare secondo il modello psicoanalitico classico: esso deriva dall’infanzia, dalle esperienze disgustose provate direttamente o inculcate dai genitori durante l’infanzia. “Una parola diventa oscena quando l’immagine che l’accompagna è primaria [della prima infanzia] e ripugnante.”6 E poiché ogni nuova generazione ha nella propria infanzia delle specifiche esperienze ripugnanti, “anche se gli adulti cancellassero tutto il linguaggio osceno dal loro vocabolario questo rifarebbe la comparsa con la generazione successiva”.
Rispondiamo a questa osservazione psicoanalitica di Berne ricordando che i bambini imparano il linguaggio osceno dai ragazzini più grandi e dagli adulti stessi. E lo imparano perché designa le parti del corpo e gli atti sessuali di cui, però, gli adulti poi proibiscono che si parli. Quindi essi capiscono che sono parole e cose proibite ed è per violare il tabù degli adulti, per trasgredire al loro ordine che le usano, prima di nascosto e poi in modo manifesto. La rivoluzione sessuale degli anni Sessanta-Settanta ha adottato esplicitamente questo linguaggio con scopo di rivolta offensiva. Ed ha usato nello stesso modo e con la stessa funzione la bestemmia, l’imprecazione o l’oscenità rivolta alla divinità. Ricordo che nei due anni trascorsi come rettore all’Università di Trento, un centro del movimento studentesco italiano, molti studenti (non i leader che usavano un linguaggio marxista) non riuscivano a dire tre parole senza interporre una oscenità ed una bestemmia. Il linguaggio sessuale osceno non aveva, in questo caso, nessuna funzione di evocazione erotica, ma di pura trasgressione, di offesa all’ordine costituito, alla religione, allo Stato.
A differenza di Berne, Bataille sostiene che l’oscenità fa parte integrante dell’erotismo perché questo è, nella sua essenza, trasgressione, eccesso, frantumazione dell’ordine sociale e del lavoro. Manda in pezzi l’individuo socializzato, ne dissolve la coscienza e libera la carne, la sua convulsione cieca. Chi è preso dalla frenesia erotica non è più umano, si fa, al modo delle bestie, cieca sfrenatezza. Perciò anche gli amanti onesti – egli osserva – rispettosi dei tabù, per eccitarsi, per vivere fino in fondo una sfrenata esperienza erotica, usano a loro volta parole volgari, oscene violando il proprio perbenismo. L’erotismo è quindi sempre lacerazione, frantumazione, profanazione del tabù, del costume, del linguaggio. La sua parola, la parola dell’eccitamento erotico, di conseguenza è sempre oscena, volgare.
Egli osserva, sulla base del rapporto Kinsey,7 che il minimo dell’attività sessuale viene svolto da chi svolge un lavoro regolare e il massimo, invece, dalla gente della malavita, che controlla i night club, il gioco d’azzardo, la prostituzione. Cioè da chi è lontano dal lavoro quotidiano, monotono, disciplinato e più prossimo alla violenza, all’arbitrio. È dalla malavita e dalla prostituzione che viene il linguaggio osceno, perché è il linguaggio dell’odio, della profanazione.
Non c’è il minimo dubbio che il linguaggio osceno possa incorporare in sé la violenza della trasgressione adolescenziale dell’ordine adulto, la violenza della malavita, quella rivoluzionaria dei movimenti e delle rivoluzioni. Dopo la battaglia di Carberry Hill, Mary Stuart cade prigioniera dei lord scozzesi ed il popolo che insorge contro di lei le fa ala fino ad Edimburgo con un coro di insulti osceni, di cui il più lieve è “puttana cattolica”.8 Durante la Rivoluzione francese il processo, la condanna e infine il viaggio verso la ghigliottina erano sempre accompagnati da orrendi cori di oscenità. Ma c’è anche la violenza della società perbene quando attacca chi condanna. Le religiosissime e castigatissime comari dimostrano nell’uso del linguaggio osceno una straordinaria conoscenza quando devono scrivere una lettera anonima o insultare una donna che denigrano.
Però resta altrettanto accertato che l’esperienza erotica di solito non coincide con la violenza. Avviene in Sade, in alcuni romanzi dello stesso Bataille, ma abitualmente no. Se ci fosse identità, che bisogno avremmo di usare una espressione apposita come “sadismo”? Basterebbe dire “erotismo”. Nelle rivoluzioni, nella malavita la parola oscena è odio, è insulto, è aggressività pura. Ma nella maggior parte delle relazioni erotiche il linguaggio volgare non esprime nessun odio e nessuna violenza. Viene usato come eccitante nell’intimità dagli amanti. Anche nella pornografia non c’è volontà di male. Questo linguaggio volgare è trasgressivo nel senso che ci allontana dalla vita normale, dal rigoroso controllo del corpo e dell’abbigliamento, dal perbenismo, ci porta in una sfera separata, dove non ci sono i rigori del dovere, dove sono consentiti mescolanze dei corpi, sensazioni, desideri, spasimi violenti, ansiti, grida, piaceri da tenere nascosti.
Quindi la stessa parola, la stessa espressione può essere usata in due contesti diversi. Il primo, aggressivo, dove esprime ed eccita la collera, l’odio, il desiderio di fare del male, di uccidere socialmente e moralmente l’altro. Esso produce l’espulsione del nemico dalla società, lo condanna alla “morte civile”, spesso alla morte vera e propria. Il secondo, erotico, non espelle, non uccide. Con esso ci isoliamo, ci autosegreghiamo dalla società per abbandonarci ad un gioco sfrenato. La prima è una condanna, una uccisione, un bando, una espulsione, la seconda è un isolamento, una vacanza, una licenza per essere liberi di fare ciò che ci piace. È vero che nell’erotismo siamo nudi e proviamo piacere a ritrovare la nos...