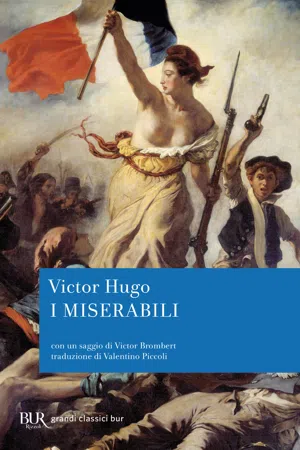Il 1831 e il 1832, i due anni che si riallacciano immediatamente alla rivoluzione di luglio, sono uno dei momenti più singolari e più impressionanti della storia. Questi due anni, tra quelli che li precedono e quelli che li seguono, sono come due montagne. Essi hanno la grandezza rivoluzionaria. Vi si scorgono dei precipizi. Le masse sociali, le assise stesse della civiltà, il gruppo solido degli interessi sovrapposti e aderenti, i profili secolari dell’antica formazione francese, vi appaiono e scompaiono a ogni istante, attraverso le nubi procellose dei sistemi, delle passioni e delle teorie. Tali apparizioni e sparizioni sono state definite resistenza e movimento. A intervalli, vi si vede brillare la verità, questa luce dell’anima umana.
Questo periodo notevole è abbastanza ben delimitato e comincia ad allontanarsi a sufficienza da noi perché si possa afferrarne fin da ora le linee principali.
È quanto tenteremo di fare.
La restaurazione è stata una di quelle fasi intermedie difficili a definirsi, in cui si trovano stanchezza, ronzìo, mormorii, torpore, tumulto, e che non sono altro che l’arrivo d’una grande nazione a una tappa. Questi periodi sono singolari e ingannano i politici che vogliono sfruttarli. Da principio, la nazione non chiede che riposo. Non ha che una sete; la pace; non ha che un’ambizione: essere piccola. In ciò si traduce il bisogno di tranquillità. Di grandi eventi, grandi casi, grandi avventure e grandi uomini, grazie a Dio, se ne sono visti abbastanza e se ne ha fin sopra i capelli! Si darebbe Cesare per Prusia1 e Napoleone per il Re d’Yvetot. «Che buon reuccio, era quello!»2 Si è marciato dallo spuntar del giorno, si è alla sera d’una lunga e aspra giornata; si è fatta la prima tappa con Mirabeau, la seconda con Robespierre e la terza con Bonaparte; si è spossati. Ciascuno chiede un letto.
Le abnegazioni stanche, gli eroismi invecchiati, le ambizioni soddisfatte cercano, reclamano, implorano, sollecitano, che cosa? Un ricovero. E l’hanno. S’impossessano della pace, della tranquillità, degli agi ed eccoli contenti. Nello stesso tempo, però, sorgono certi fatti che si fanno riconoscere e battono, a loro volta, alla porta. Questi fatti sono scaturiti dalle rivoluzioni e dalle guerre: esistono, vivono, hanno diritto d’insediarsi nella società, e vi s’insediano; e, il più delle volte, i fatti sono dei marescialli d’alloggio e dei furieri, che non fanno altro che preparare l’alloggiamento ai principi.
Ed ecco allora che cosa appare ai filosofi politici.
Nello stesso momento in cui gli uomini stanchi chiedono il riposo, il fatto compiuto vuole delle garanzie. Le garanzie per i fatti sono la stessa cosa che il riposo per gli uomini.
È ciò che chiedeva l’Inghilterra agli Stuart, dopo il Protettore;3 e ciò che chiedeva la Francia ai Borboni dopo l’impero.
Queste garanzie sono una necessità dei tempi, e bisogna pur accordarle. I prìncipi le «concedono», ma in realtà è la forza delle cose che le dà. Questa è una verità profonda e utile a sapersi, la quale sfuggì agli Stuart nel 1660, e che i Borboni non intravidero nel 1814.
La famiglia predestinata che ritornò in Francia al crollo di Napoleone ebbe la dabbenaggine fatale di credere che era stata lei a dare e che quello che aveva dato poteva riprendersi; di credere altresì che la casa di Borbone possedesse il diritto divino e la Francia non possedesse nulla; e che il diritto politico concesso con la costituzione di Luigi XVIII non fosse altro che un ramo del diritto divino, staccato dalla casa di Borbone e graziosamente donato al popolo fino al giorno in cui fosse piaciuto al re di riprenderselo. Tuttavia, dal dispiacere che il dono le arrecava, la casa dei Borboni avrebbe dovuto sentire che esso non veniva da lei.
Essa fu scontrosa col diciannovesimo secolo, e fece cattivo viso a ogni sviluppo della nazione. Per servirci d’una parola triviale, cioè popolare e verace, diremo che torse il muso; e il popolo vide questo.
Credette di essere forte perché l’impero era stato portato via, sotto i suoi occhi, come una quinta di teatro. E non si accorse di essere stata essa pure portata sulla scena allo stesso modo. Non vide che anch’essa era in potere della stessa mano che aveva tolto di mezzo Napoleone.
Credette d’aver salde radici perché era il passato. E s’ingannava: essa faceva parte del passato, ma tutto il passato era la Francia. Le radici della società francese non erano affatto nei Borboni, ma nella nazione. Queste oscure e vitali radici non costituivano punto il diritto d’una famiglia, ma la storia d’un popolo. Esse erano ovunque, fuorché sotto il trono.
La casa di Borbone era per la Francia il nodo illustre e sanguinoso della sua storia, ma non era più l’elemento principale del suo destino e la base necessaria della sua politica. Si poteva fare a meno dei Borboni, e se n’era fatto a meno per ventidue anni; v’era stata una soluzione di continuità, di cui essi non s’erano accorti. E come avrebbero fatto ad accorgersene, essi che s’immaginavano che Luigi XVII regnasse il 9 termidoro e che Luigi XVIII regnasse il giorno di Marengo? Dall’origine della storia i principi non erano stati mai così ciechi di fronte ai fatti e a quella porzione d’autorità divina che i fatti contengono e promulgano. Mai questa pretesa terrena, che si chiama il diritto dei re, aveva negato sino a tal punto il diritto divino.
Errore capitale, questo, che condusse quella famiglia a manomettere le garanzie «accordate» nel 1814; le sue concessioni, com’essa le chiamava. Che cosa triste! Ciò ch’essa chiamava le sue concessioni erano le usurpazioni inflitte a noi, erano i nostri diritti!
Quando le sembrò giunta l’ora, la restaurazione, ritenendosi vittoriosa di Bonaparte e radicata nel paese, cioè, credendosi forte e ritenendosi grande, prese bruscamente la sua decisione e tentò il colpo. Una mattina essa si rizzò di fronte alla Francia e, alzando la voce, contestò il titolo collettivo e il titolo individuale: alla nazione la sovranità, e al cittadino la libertà. In altri termini, negò alla nazione ciò che la faceva nazione, e al cittadino ciò che lo faceva cittadino.
Questa è la sostanza di quegli atti famosi che vengono chiamati le ordinanze di luglio.
La restaurazione cadde.
E cadde giustamente. E pure, bisogna dirlo, essa non era stata sistematicamente ostile a tutte le forme del progresso. Durante il suo regime sono state compiute grandi cose.
Sotto la restaurazione la nazione si era abituata alla discussione nella calma, ciò che era mancato alla repubblica, e alla grandezza nella pace, ciò che era mancato all’impero. La Francia, libera e forte, era stata uno spettacolo incoraggiante per gli altri popoli dell’Europa. La rivoluzione aveva avuto la parola sotto Robespierre: il cannone aveva avuto la parola sotto Bonaparte; fu sotto Luigi XVIII e Carlo X che, a sua volta, ebbe la parola l’intelligenza.
Il vento cessò, la fiaccola si riaccese.
Si vide fremere sulle cime serene la luce pura degli spiriti; spettacolo magnifico, utile e attraente. Si videro all’opera per quindici anni, in piena pace pubblica, in piena piazza pubblica, quei grandi princìpi, così vecchi per il pensatore, così nuovi per l’uomo di Stato: eguaglianza di fronte alla legge, libertà di coscienza, libertà di parola, libertà di stampa, accessibilità per tutte le attitudini, a tutte le funzioni. E ciò durò sino al 1830. I Borboni furono uno strumento di civiltà che si ruppe nelle mani della provvidenza.
La caduta dei Borboni fu piena di grandezza, non da parte loro, ma da parte della nazione. Essi lasciarono il trono con gravità, ma senza autorevolezza: la loro discesa nell’oscurità non fu una di quelle scomparse solenni che lasciano una cupa emozione alla storia; non fu né la calma spettrale di Carlo I, né il grido d’aquila di Napoleone. Se ne andarono, ecco tutto. Deposero la corona, e non ne conservarono l’aureola. Furono degni, ma non augusti. Vennero meno, in qualche modo, alla maestà della loro sventura. Carlo X, che, durante il viaggio di Cherbour4 faceva trasformare una tavola da rotonda in quadrata, parve molto più preoccupato dell’etichetta in pericolo che della monarchia crollante. Questa diminuzione rattristò gli uomini devoti che amavano le loro persone e gli uomini seri che stimavano la loro stirpe. Il popolo fu ammirevole. La nazione, attaccata una mattina, a mano armata, da una specie di insurrezione reale, sentì in sé tanta forza che non montò in collera. Si difese, si contenne, rimise le cose a posto, il governo nella legge, i Borboni in esilio e poi, ahimè! si fermò. Prese il vecchio re Carlo X di sotto quel baldacchino che aveva coperto Luigi XIV, e lo depose a terra dolcemente. Toccò le persone reali solo con tristezza e con precauzione. Non fu un uomo, non furono alcuni uomini: fu la Francia, tutta la Francia, la Francia vittoriosa e inebriata della sua vittoria, che sembrò ricordarsi e mise in pratica di fronte agli occhi di tutto il mondo queste gravi parole di Guglielmo del Vair5 dopo la giornata delle barricate: «È facile per coloro che son usi sfiorare i favori dei grandi e saltare, come un uccello, di ramo in ramo, da una sorte desolata a una fiorente, il mostrarsi arditi contro il loro principe nella sua avversità; ma, per me, la sorte dei miei re, e particolarmente di quelli afflitti, sarà sempre venerabile».
I Borboni portarono con sé il rispetto, ma non il rimpianto. Come abbiamo detto poc’anzi, la loro sventura fu più grande di loro, ed essi si dileguarono all’orizzonte.
La rivoluzione di luglio ebbe subito amici e nemici in tutto il mondo. Gli uni si precipitarono verso di essa con entusiasmo e con gioia, e gli altri si distolsero da essa, ciascuno secondo la propria natura. I principi d’Europa, nel primo momento, gufi di quell’alba, chiusero gli occhi, feriti e stupefatti, e li riaprirono solo per minacciare. Spavento che si capisce, collera che si scusa. Quella strana rivoluzione era stata appena una scossa; alla regalità vinta non aveva nemmeno fatto l’onore di trattarla da nemica e di versare il suo sangue. Agli occhi dei governi dispotici, sempre interessati a che la libertà si calunni da se stessa, la rivoluzione di luglio aveva il torto di essere formidabile e di restare mite. Nulla, del resto, fu tentato, né macchinato contro di essa; e i più malcontenti, i più irritati e i più frementi la salutarono. Quali che siano i nostri egoismi e i nostri rancori, un rispetto misterioso emana dagli avvenimenti nei quali si sente la collaborazione di Qualcuno che opera più in alto dell’uomo.
La rivoluzione di luglio è il trionfo del diritto che vince il fa...