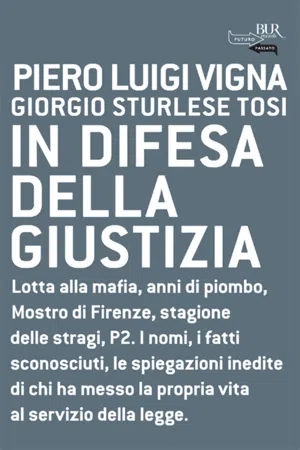![]()
PARTE PRIMA
La mafia
![]()
1.
L’attentato di via dei Georgofili
Tra le macerie
«Dottore buonasera, scusi l’ora, ma c’è stata un’esplosione agli Uffizi. La veniamo a prendere?»
«Immediatamente!»
Era il 27 maggio 1993. Era da poco passata l’una di notte quando squillò il telefono. Avevo appena chiuso un libro e stavo per prendere sonno. Mia moglie, che invece dormiva, si svegliò di soprassalto. Mi chiese cos’era successo. «Una cosa grave» le dissi.
Mi vestii in fretta, infilandomi la camicia sporca che poco prima avevo buttato su una sedia. Sentii la sirena del maresciallo che ancora mi stavo allacciando le scarpe. Uscii in giardino, aprii il cancello e montai sulla gazzella dei carabinieri.
Percorremmo a forte velocità la fine del viale dei Colli, via Maggio, il lungarno, fino al loggiato degli Uffizi, dove l’auto si fermò per farmi scendere. C’era molta gente che correva, con l’espressione incredula e spaventata.
A passo svelto percorsi il loggiato, su un tappeto di vetri rotti, sfilando davanti ai volti di fiorentini illustri, quando incrociai lo sguardo di Gabriele Chelazzi. Quella notte era lui il pubblico ministero di turno, e a lui era arrivata la prima telefonata. Nonostante abitasse a Campo di Marte, più lontano di me, era arrivato prima. Mentre mi indicava la strada, senza dire una parola ci scambiammo uno sguardo carico di speranza. La speranza che si trattasse di una fuga di gas.
Poche settimane prima, infatti, ce n’era stata un’altra, a Palazzo Pitti, che aveva provocato gravi danni. Ma non avvertivano l’odore del gas. Nessuno lo sentiva. Né io, né Gabriele e nemmeno i Vigili del fuoco che già si stavano dannando per scavare tra le macerie alla ricerca di feriti.
Scorsi, tra i soccorritori, Annamaria Petrioli Tofani, la direttrice del museo degli Uffizi. Era molto agitata, si era precipitata per stimare i danni alle opere d’arte. Proprio di fronte all’Accademia dei Georgofili c’era un gigantesco cratere. In quegli attimi concitati era già chiaro che dovevano esserci delle vittime. I pompieri stavano scavando con le pale e a mani nude: cercavano le tubature dalle quali doveva essere fuoriuscito il gas. Ma di tubi, lì sotto, non ce n’erano.
Uno dei caposquadra emerse dal cratere, mi venne incontro e mi disse: «Dottore, non è una fuga di gas».
In quell’attimo mi accorsi di un gigantesco portone di legno massiccio che fino a pochi minuti prima proteggeva l’ingresso di uno dei palazzi più antichi di Firenze e che ora giaceva dentro il suo androne, scardinato, come fosse di bambù. Feci qualche passo verso il cortile quando, nell’oscurità, vidi il motore di un’auto, sbalzato dal cofano da una potentissima carica di esplosivo. Capii. Quello che fin dalla telefonata era un tragico sospetto, una sensazione che avevo tentato di scacciare, stava prendendo corpo davanti ai miei occhi.
Tornai sui miei passi. A Gabriele e al capo dei pompieri che mi venivano incontro dissi soltanto: «È un attentato».
Gabriele e io ci obbligammo a mettere da parte le emozioni e usare la logica. L’emotività non si addice alle indagini e la razionalità, soprattutto in certi casi, è la risposta migliore.
I soccorritori continuavano a scavare in condizioni difficilissime, rischiando di essere travolti da un crollo e accecati dalla polvere. Dopo un tempo che ci sembrò lunghissimo la speranza di un miracolo si spense: dai cumuli di pietra e terra vennero estratti i corpi delle vittime.
La prima era un fagottino, una neonata di appena cinquanta giorni, Caterina. Poi la sorella Nadia, di nove anni, e il padre, Fabrizio Nencioni. Infine Dario Capolicchio e Angela Fiume.
Cinque vittime, di cui due bambini.
L’esplosivo
Gabriele e io ci ponemmo subito il problema di quale fosse la prima cosa da fare. Se di attentato si era trattato, bisognava capire il tipo di esplosivo che era stato utilizzato. Bisognava cioè repertare quintali di macerie.
Disponemmo dunque che delle ruspe venissero a prelevarle. Quindi chiedemmo al comune di metterci a disposizione un capannone dove scaricarle per farle esaminare dai consulenti. Contattammo subito la polizia scientifica di Roma e il Comsubin di La Spezia, il reparto degli Arditi incursori della marina militare, esperti di esplosivi.
Ci assicurarono che in mattinata sarebbero arrivati a Firenze. Erano ormai le cinque passate. Tornai a casa per una rapida doccia e per cambiarmi gli abiti, impregnati di polvere e fumo. Di dormire non se ne parlava. Non c’era tempo e ad ogni modo non sarei riuscito a chiudere occhio: le immagini di quello strazio continuavano a balenarmi nella mente.
Un paio di ore dopo ero in procura insieme a Chelazzi. Disposi subito che le indagini le avrei coordinate personalmente e, data la mole di lavoro da fare, a Gabriele affiancai l’altro sostituto Francesco Fleury e Giuseppe Nicolosi, siciliano ed esperto di mafia. Qualcosa mi diceva, infatti, che le indagini ci avrebbero portato in Sicilia, al cuore di Cosa Nostra.
I risultati delle analisi sull’esplosivo confermarono queste intuizioni: si trattava di una miscela di pentrite, che gli artificieri chiamano «polvere dell’inferno» (possiede una velocità di deflagrazione terrificante, più di sette chilometri al secondo, e arriva a produrre seimila gradi al momento dello scoppio), T4, tritolo e nitroglicerina. La stessa composizione impiegata per l’attentato, fallito, al giornalista Maurizio Costanzo, avvenuto in via Fauro meno di quindici giorni prima. La stessa composizione che il 23 dicembre 1984 fece esplodere il «Treno di Natale», il rapido 904, nella galleria dell’Appennino a San Benedetto Val di Sambro provocando la morte di diciassette passeggeri e oltre duecento feriti. Stesso esplosivo, stessa firma. La matrice mafiosa della strage era più di un semplice sospetto.
L’esplosione aveva pesantemente danneggiato gli edifici del centro storico: era stata completamente distrutta la Torre dei Pulci, sede dell’Accademia dei Georgofili, la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la chiesa di Santo Stefano e Cecilia al Ponte Vecchio e il museo di Storia e della Scienza erano stati gravemente lesionati.
Milioni di frammenti di vetro e lo spostamento d’aria avevano cancellato alcuni beni artistici del museo più famoso d’Italia e seriamente compromesso decine di opere d’arte, compresi capolavori di Rubens, Bernini, Bronzino, Velasquez, e un affresco, opera del Giorgione e del giovane Tiziano, raffigurante una donna seduta che impugna la spada nel gesto di usarla: la Giustizia. Era quasi una sfida.
La mattina seguente l’editoriale dell’edizione straordinaria della «Nazione» titolava: Peggio dei nazisti.
Era stata dichiarata guerra allo Stato. E l’attacco aveva colto tutti impreparati.
Quel giorno le più alte cariche del Paese sfilarono intorno al cratere. In prefettura si svolse una prima riunione interforze, a cui partecipò anche Carlo Azeglio Ciampi, l’allora presidente del Consiglio.
Ricordo nitidamente le parole che ci scambiammo in quei momenti di dolore. Ciampi mi prese in disparte e mi chiese: «Lei, procuratore, che dice?».
L’emozione di quelle ore drammatiche mi spinse ad azzardare: «Presidente, li prenderemo».
Firenze piange i suoi morti
La pista mafiosa, nonostante tutto, non convinceva alcuni politici, che insistevano, in un primo momento, nel percorrere altre ipotesi, come quella del terrorismo balcanico.
Dieci giorni prima dell’attentato, infatti, il leader serbo Ratki Mladi´c aveva minacciato una serie di attacchi terroristici anche in Italia, come rappresaglia per l’uso delle basi Nato per gli aerei che sorvolavano l’ex Jugoslavia.
Presto, però, questa pista venne abbandonata.
Intanto la città aveva reagito. Con la stessa coesione che aveva dimostrato nel 1966, quando fu colpita dall’alluvione.
Due giorni dopo l’esplosione centomila persone riempirono piazza Santa Croce per manifestare, per protestare e per applaudire il Giglio di Firenze. Con loro, contemporaneamente, altre centinaia di migliaia si riunirono a Milano, Brescia, Bologna, Palermo. Città che avevano purtroppo già dimestichezza con le stragi.
I ragazzi del Calcio storico, autonomamente, misero da parte le secolari rivalità e attivarono la loro rete di conoscenze nella Firenze popolare e nel mondo dei locali notturni per cercare qualcuno che avesse notato qualcosa di sospetto quella sera.
Un mese dopo, piazza della Signoria era gremita. All’1.04, ora dell’esplosione, suonò la Martinella, la campana della torre d’Arnolfo, sul Palazzo Vecchio. Subito dopo rintoccò il campanile del Duomo.
Potere laico e religioso celebravano insieme il ricordo delle vittime. Il silenzio era totale, durò alcuni minuti, mentre decine di migliaia di accendini illuminavano il buio. Firenze pianse i suoi morti, in un abbraccio commosso e collettivo.
La città si strinse subito attorno ai magistrati. Sentivamo questa partecipazione, per la strada ci fermavano degli sconosciuti che ci chiedevano di prendere gli assassini, che ci incoraggiavano a indagare. Ci davano pacche sulle spalle e, chiamandoci per cognome, come fossimo compagni della stessa squadra, ci spronavano alla caccia.
Percepivamo, in quei giorni, una pressione costante su di noi, ma era una pressione positiva, un sostegno vero e sentito. Si alzava, da tutta Firenze, un anelito alla verità. Un sentimento che neppure oggi, a distanza di tanti anni, soprattutto da parte delle associazioni che rappresentano le vittime della mafia, è sopito.
I primi passi dell’indagine
Mi è sempre piaciuta la definizione del pubblico ministero come di colui che, dal caos degli indizi, riesce a ricostruire il cosmo degli eventi, rintracciandone l’ordine e il senso logico. Era questo che eravamo chiamati a fare: lavorare sugli indizi, metterli in fila e arrivare agli autori.
Le nostre certezze sulla matrice mafiosa si scontrarono da subito con la complessità delle indagini. Intuivamo di dover seguire un filo sottile che, da Firenze, arrivava fino a Palermo, ma l’inchiesta non riusciva ad allontanarsi dalle sponde dell’Arno.
Scoprimmo che il Fiorino Fiat usato come autobomba era stato rubato poche ore prima dell’attentato, alle 19.50, in via della Scala, a due passi da una caserma dell’esercito e a un isolato dalla scuola per marescialli dei carabinieri.
Questo significava che il commando aveva avuto quattro ore e mezzo per nascondere il mezzo in qualche luogo, imbottirlo di esplosivo, preparare il congegno d’innesco e parcheggiarlo in via dei Georgofili tra mezzanotte e quaranta e l’una. Davvero poco tempo.
Era chiaro dunque che il gruppo di fuoco poteva contare su un luogo sicuro a Firenze o nelle sue immediate vicinanze.
Speravamo che le telecamere di quelle caserme avessero inquadrato il volto di chi aveva rubato il Fiorino, ma alcune non funzionavano e altre erano puntate solo sugli ingressi delle strutture militari. La telecamera della caserma dell’esercito, addirittura, era ancora impostata con l’ora legale e fu possibile risalire all’orario esatto del furto solo grazie alla memoria del proprietario del veicolo che ricordava di essere rincasato proprio mentre iniziava, su Rai Tre, il notiziario regionale delle 19.30.
Intanto, in procura, mancava letteralmente lo spazio per raccogliere il materiale investigativo. La sede di piazza Strozzi non era ancora stata destinata agli uffici giudiziari ed eravamo costretti a muoverci negli angusti corridoi dell’ex convento di piazza San Firenze, dove si trovava anche il tribunale.
Io mi ero ricavato due stanzette al secondo piano della questura. Nonostante la targhetta sulla porta recitasse «Ispettore», quei locali erano diventati una dépendance della procura e ci lavoravamo giorno e notte. Ancora non sapevamo, però, che quello spazio non ci sarebbe più bastato e che presto avremmo dovuto restituirlo all’ispettore.
Le altre tessere del puzzle
L’esplosione che aveva sventrato il cuore di Firenze era la prima tessera di un puzzle che si sarebbe delineato con maggiore chiarezza nei mesi successivi.
Il 27 luglio 1993, alle 23.14, in via Palestro, a Milano, davanti all’ingresso della Villa Reale, esplose un’autobomba che uccise cinque persone: Alessandro Ferrari, vigile urbano sposato e con un figlio, Carlo La Catena, pompiere, i suoi colleghi Stefano Picerno, appena tornato dal viaggio di nozze, Sergio Pasotto, che festeggiava quel giorno il suo compleanno, e un venditore ambulante di accendini, il marocchino Driss Moussafir, che dormiva su una panchina del parco Venezia.
Fu una pattuglia dei Vigili urbani a notare del fumo che usciva dal cofano di una Fiat Uno e a chiamare i pompieri. Uno di loro, aprendo il bagagliaio, vide l’esplosivo e dette l’allarme, consentendo di bloccare la strada e di allontanare una famiglia che dormiva in un camper posteggiato dall’altro lato della strada. Ma la deflagrazione sorprese il vigile urbano e i pompieri che si erano attardati vicino all’auto.
Qualche minuto più tardi, alle 23.58 e alle 00.04 del 28 luglio, due esplosioni colpirono Roma: le autobombe piazzate a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio al Velabro, per fortuna, non fecero vittime.
Quella stessa notte fu spedita una lettera al «Corriere della Sera» e al «Messaggero»:
Questo è solo il prologo. Avvertiamo la nazione che la prossima volta le bombe esploderanno di giorno e in luogo abitato e saranno alla ricerca esclusiva di vite umane.
P.S.: Vi garantiamo che saranno a centinaia.
I responsabili dei due quotidiani non informarono gli organi di polizia e la magistratura, probabilmente ritenendo che l’autore delle missive fosse un mitomane. L’Italia aveva un coltello puntato alla gola di cui, per fortuna, non si rese conto.
Nel gennaio 1994 poco mancò che quella minaccia diventasse realtà e che si dovessero contare altri morti: all’uscita dello stadio Olimpico di Roma fu piazzata un’autobomba che avrebbe dovuto uccidere decine di carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico durante una partita di calcio. La carica non esplose solo perché l’innesco fece cilecca.
Il messaggio lanciato da questi attentati era fin troppo chiaro, così come la loro matrice: sempre la stessa miscela utilizzata per l’esplosivo, sempre la stessa tecnica (ogni volta furono impiegate auto rubate poco prima dell’attentato).
C’era dunque una linea che collegava il Treno di Natale, via Fauro, via dei Georgofili, via Palestro, San Giovanni in Laterano, San Giorgio al Velabro e lo Stadio Olimpico. Quella linea portava dritto a Cosa Nostra.
L’attentato di Firenze aveva inaugurato una nuova stagione stragista, che si configurava come la più grande offensiva che la mafia avesse mai portato allo Stato. Persino più esplicita degli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Perché con il massacro dei due magistrati impegnati in prima linea nella lotta alla mafia i Corleonesi avevano colpito i loro più acerrimi nemici e lo avevano fatto nel loro territorio. Ma con le bombe del 1993 per la prima volta gli obiettivi erano civili inermi e simboli del patrimonio artistico italiano. Scelti sul continente.
Il livello di scontro si era alzato: quelle esplosioni fuori dalla Sicilia, quelle vittime innocenti disegnavano uno scenario diverso e ci mettevano di fronte a un disegno più complesso, tutto da interpretare.
La Procura di Firenze
La convinzione che dietro gli attentati di Firenze, Milano e Roma ci fosse la stessa mano fece sorgere il problema della competenza delle indagini.
Stando al codice di Procedura penale queste dovevano essere convogliate presso la procura competente per il reato più grave, cioè Firenz...