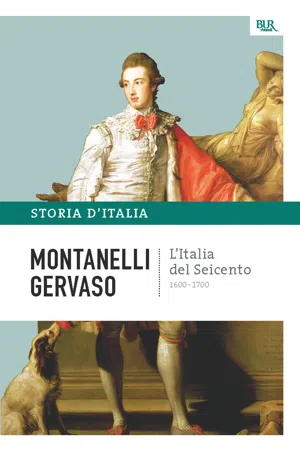AVVERTENZA
Eccoci alla quinta tappa di questa ricostruzione storica della civiltà italiana, cominciata con L’Italia dei secoli bui, L’Italia dei Comuni, L’Italia dei secoli d’oro e L’Italia della Controriforma.
Forse il lettore troverà un po’ smorto il panorama di questa Italia del Seicento, specie raffrontandolo a quello del volume precedente. Ma la colpa non è nostra. Checché ne dicano certi storici, consapevolmente o inconsapevolmente legati a concezioni autoritarie, l’Italia del Seicento è una povera Italia: povera di eventi, povera di uomini, povera di pensiero, povera di tutto. Il barocco non è che la maschera della sua miseria, lo stile di una minoranza di satrapi che ingrassano sulla fame collettiva di una società pietrificata.
Noi abbiamo cercato di ravvivare come meglio abbiamo potuto questo plumbeo quadro, dando il massimo rilievo alle figure che lo animano. Ce ne sono di grandi, come Galileo, Sarpi, Bernini, Monteverdi. Ma non è una galleria comparabile a quella del Cinquecento: le condizioni del Paese non lo consentono.
Eppure, questo secolo rappresenta una svolta decisiva non tanto per la nostra storia politica, quanto per la formazione del nostro costume su cui lascia un segno indelebile e purtroppo catastrofico. È soprattutto su questo punto che abbiamo infatti insistito. E per renderlo più chiaro, siamo ricorsi a continui raffronti con gli altri Paesi, di cui pertanto siamo stati costretti a seguire succintamente le vicende. Siamo convinti che chi si limita a studiare soltanto l’Italia, dell’Italia non capirà mai nulla.
A qualcuno le nostre tesi potranno sembrare soggettive e arbitrarie. È un’accusa a cui si espone qualsiasi storia che non voglia essere soltanto un elenco di nomi e di date. È vero: noi rievochiamo il passato tenendo sempre di vista il presente: gli chiediamo di spiegarci perché l’Italia è com’è.
In questo volume, per la prima volta, abbiamo aggiunto una bibliografia. L’abbiamo fatto non per rintuzzare le critiche di certi specialisti che ci accusano di non essere sufficientemente documentati (come se la citazione delle fonti bastasse a dimostrare ch’esse sono state realmente consultate e criticamente vagliate!), ma per liberare da questo sospetto il lettore, unico nostro destinatario e giudice. L’abbiamo però ridotta all’essenziale perché ci rifiutiamo, e seguiteremo a rifiutarci, di costellarne le pagine di note che, rompendo il ritmo della lettura, la rendono più faticosa. Chi non capisce o disprezza questi piccoli accorgimenti non sa cosa sia la divulgazione. Sappiamo benissimo che ogni dettaglio storico è oggetto di continue scoperte e revisioni. Ma noi non scriviamo questi libri per approfondire l’uno o l’altro particolare. Li scriviamo per offrire a chi non l’ha, o l’ha dimenticata, una visione generale della vita italiana nel corso dei secoli. E quando ci si propone un simile panorama non ci si può attardare in puntigliose diatribe su fatterelli secondari o comunque irrilevanti alla sua comprensione e valutazione. Questo fa parte di un altro tipo di storia, monografica, che ha la sua utilità, anzi la sua necessità, ma non rientra nei nostri interessi, né, crediamo, in quelli dei nostri lettori.
Costoro ci hanno tangibilmente dimostrato di apprezzare il nostro sforzo. E siccome questi libri sono dedicati esclusivamente a loro, è solo il loro giudizio che conta. Noi li ringraziamo della loro fedeltà.
I.M.
R.G.
Ottobre 1969
CAPITOLO PRIMO
LA GALASSIA ITALIANA
A prima vista, l’Italia che il 1° gennaio del 1600 festeggiò l’inizio del nuovo secolo offriva un incoraggiante spettacolo di ordine e di tranquillità, specie se lo si raffrontava alle inquietudini e alle guerre, politiche e religiose, che travagliavano il resto d’Europa. L’assetto che una quarantina d’anni prima la pace di Cateau-Cambrésis aveva dato al nostro Paese era rimasto sostanzialmente invariato, e i vari Stati e staterelli in cui la Penisola era frazionata avevano smesso di dilaniarsi tra loro, come per secoli avevano seguitato a fare. Non che avessero compreso l’inanità di quell’assurdo fratricidio. Ma il padrone non glielo consentiva.
Il padrone era la Spagna, destinata a rimaner tale fino al 1715, cioè per oltre un secolo e mezzo. Essa si era direttamente appropriata quattro dei nostri maggiori Stati: la Sicilia, la Sardegna, Napoli e il Ducato di Milano, oltre una testa di ponte in Maremma che si chiamava Stato dei Presidi. Li amministrava con uomini suoi, Viceré o governatori mandati da Madrid, che non tolleravano nessun controllo da parte di organi locali, anche se ne lasciavano sussistere qualcuno per figura come il «Parlamento» di Napoli, il «Senato» di Milano e lo «Stamento» di Sardegna. Del resto, non si capisce perché gli Spagnoli avrebbero dovuto rispettare le autonomie italiane, visto che le avevano soppresse anche in casa loro. Il governo degli Asburgo di Spagna, come lo aveva costituito Filippo e i suoi successori si preparavano a mantenerlo, non era meno centralistico di quello sovietico d’oggigiorno. I funzionari, quasi tutti castigliani, non facevano che eseguire gli ordini del Re, che s’impicciava anche dei minimi particolari. E ai sudditi non restava che obbedire.
Quanto agli altri Stati della Penisola, Filippo gli aveva lasciato un sembiante d’indipendenza, ma solo un sembiante, perché dalle cinque roccheforti che abbiamo menzionate egli era in grado in qualsiasi momento di ridurli alla ragione. Vediamo comunque in una rapida retrospettiva com’era stata regolata la loro sorte e di quali principali vicende erano stati teatro nella seconda metà del Cinquecento.
L’unico che avesse conservato le sue istituzioni e potesse ancora fare una sua politica era la Repubblica di Venezia, rimasta padrona di quasi tutto il Veneto, di un pezzo di Lombardia, di gran parte dell’Istria e della Dalmazia e di alcune isole greche. Venezia doveva questa situazione di privilegio un po’ al suo carattere di città lagunare difficilmente espugnabile per via di terra, un po’ alla sua agguerrita flotta tuttora fra le più potenti d’Europa, un po’ all’accortezza dei suoi uomini di Stato. Per costoro non era facile destreggiarsi fra le due potenze Asburgo: quella d’Austria e quella di Spagna. Ma ci riuscirono sempre giuocando sulla flotta, necessaria a entrambe per la lotta contro i Turchi. Lepanto era stata una vittoria soprattutto veneziana. E quasi tutto veneziano era il commercio con l’Oriente, di cui anche la Spagna aveva bisogno. Venezia insomma sapeva rendersi necessaria, e ne approfittò per accentuare sempre più la propria indipendenza anche nei confronti della Chiesa, cui la Spagna consentiva di spadroneggiare su tutto il resto della penisola.
All’altro polo dell’Italia settentrionale, il Piemonte cominciava a far parlare di sé. Esso era stato una delle grandi poste nell’interminabile conflitto tra Francia e Spagna, i cui eserciti vi si erano dati il cambio mettendolo a sacco. Quando il duca Emanuele Filiberto di Savoia, che si era messo al servizio degli Spagnoli e alla loro testa aveva sgominato i Francesi a San Quintino, vi fece ritorno dopo la pace di Cateau-Cambrésis, trovò le città ridotte a macerie e le campagne a brughiera. Fin allora la sua capitale era stata Chambéry perché i suoi possedimenti erano più di là dalle Alpi, in territorio francese, che di qua, in territorio italiano. Emanuele Filiberto la trasferì a Torino, e questo gesto implicava una scelta politica che nel corso dei secoli si sarebbe rivelata di decisiva importanza. Grazie a essa i Savoia, di origine borgognona e quindi francese, diventavano una dinastia italiana. Italiana fu la lingua che adottarono negli atti della loro amministrazione. E italiano diventò il loro campo di azione politica.
Non erano Re. Il loro titolo era ancora quello di Duca, e i loro possedimenti non inglobavano che una piccola parte del Piemonte, perché il resto era tuttora diviso fra altri due Principati: quello di Saluzzo e quello del Monferrato. Emanuele Filiberto provvide anzitutto a procurarsi uno sbocco al mare, e ci riuscì annettendosi la Contea di Tenda che gli dava accesso a Nizza e comprando dai Genovesi il porto di Oneglia. Quando morì nel 1580, suo figlio Carlo Emanuele I ne continuò la politica con molta energia, anzi forse con troppa perché i suoi cinquant’anni di governo furono tutt’un susseguirsi d’iniziative diplomatiche e militari audaci e spregiudicate, ma – come vedremo – non sempre fortunate.
Più a Sud, Genova aveva conservato anch’essa una certa autonomia, grazie agli enormi servigi che il suo «protettore» Andrea Doria e la sua flotta avevano reso alla Spagna. Ma, più che per fare politica, Genova ne approfittava per fare affari. Il suo territorio era limitato a una smilza fascia costiera che si stendeva fra Massa a Sud e Monaco a Ovest. La città non si era mai curata di darsi solidi istituti cittadini. Il più potente era una banca privata, quella di San Giorgio, in mano alle grandi dinastie finanziarie dei Doria, Grimaldi, Spinola e Centurione, che contavano più dello Stato. Tant’è vero che non era dallo Stato, ma dalla Banca, che dipendeva il più importante possedimento genovese: la Corsica. Solo in seguito a una sanguinosa rivolta degl’isolani contro l’esoso sfruttamento dei banchieri, costoro preferirono disfarsene e affidarla allo Stato.
I migliori clienti della Banca erano i Re spagnoli. Malgrado il fiume d’oro e d’argento che dalle colonie americane affluiva nelle sue casse, la Spagna era sempre a corto di quattrini: un po’ perché le sue pazze guerre glieli mangiavano tutti, un po’ perché non produceva più nulla da quando si era messa a perseguitare i moriscos, cioè i Musulmani convertiti, gli unici che non tenessero a vile il lavoro. L’agricoltura languiva perché i contadini erano rastrellati dalle coscrizioni militari, e industria non ce n’era. La Spagna doveva importare tutto. E a provvedervi erano i Genovesi con le loro navi e i loro capitali. I cantieri e la flotta mercantile spagnola erano genovesi, e in mano genovese erano tutti gli appalti di lavori pubblici, le miniere e le aziende commerciali catalane.
Di Milano abbiamo già detto. Ridimensionato nei suoi possedimenti, il vecchio Ducato dei Visconti e degli Sforza, che aveva aspirato a diventare la potenza egemone della Penisola, non era più che una colonia spagnola. Era ancora una città ricca e culturalmente viva. Ma gli agenti del fisco madrileno e i tribunali dell’Inquisizione ne stavano già massicciamente drenando le risorse economiche e l’energie intellettuali.
Fra il Po e l’Appennino, vi sopravvivevano alcuni Principati tuttora in mano alle vecchie dinastie rinascimentali. Al loro Ducato di Mantova, i Gonzaga avevano aggiunto quello del Monferrato, pomo di discordia coi Savoia. I Farnese erano rimasti Signori di Parma grazie ad Alessandro, ch’era stato insieme a Emanuele Filiberto uno dei più grandi condottieri dell’esercito spagnolo. Gli Este erano tuttora Signori di Ferrara, Reggio e Modena. Ma, avendo sempre parteggiato per la Francia, ora che questa aveva perso ogni influenza sulla Penisola, erano rimasti senza protettore. Alla fine del Cinquecento, quando la dinastia entrò in crisi per mancanza di successori diretti, papa Clemente VIII ne approfittò per annettere Ferrara agli Stati pontifici, e la Spagna lo lasciò fare. Gli Este del ramo cadetto dovettero contentarsi di Reggio e Modena.
La Toscana aveva trovato in Cosimo de’ Medici uno statista degno in tutto del suo omonimo del Quattrocento, «padre della Patria». Egli aveva tenuto il suo Ducato giudiziosamente al riparo dalle beghe franco-spagnole, badando soltanto a dargli una buona amministrazione. Meno Lucca che riuscì a salvare la sua sovranità di Repubblica indipendente, tutte le altre città toscane dovettero sottomettersi al potere centrale di Firenze, che d’altronde ne fece buon uso. Fu allora che cominciarono le bonifiche in Maremma e si dette avvìo al porto di Livorno in sostituzione di quello di Pisa, ormai tagliata dal mare dall’insabbiarsi del litorale.
Prima di morire, Cosimo riuscì a farsi promuovere dal Papa da Duca a Granduca. E fu questo il titolo che lasciò ai suoi eredi. Il primogenito Francesco fece molto rimpiangere il padre. Ma il fratello Ferdinando I, che gli successe nel 1587, riprese la politica interna di Cosimo, e in quella estera riuscì a sottrarsi alla soffocante influenza spagnola, sempre più appoggiandosi a Enrico IV, il restauratore dell’unità nazionale francese, cui dette in moglie la propria nipote Maria.
Ma nemmeno l’accortezza di questi suoi governanti poté restituire a Firenze il lustro e lo splendore dei tempi di Lorenzo il Magnifico. L’Italia non era più, come allora, il centro del mondo; e il capitalismo fiorentino, che per un paio di secoli aveva dominato l’Europa con le sue industrie e le sue banche, era stato scavalcato da quello dei ceti imprenditoriali calvinisti di Fiandra, di Francia, di Germania e d’Inghilterra.
A Sud e a Est del Granducato si stendeva lo Stato pontificio, che ora aveva assunto una fisionomia diversa da quella che lo aveva caratterizzato nel Rinascimento. L’appoggio quasi incondizionato del cattolicissimo Filippo II aveva consentito ai Papi non solo di estendere i loro domini, che ora inglobavano, da Ferrara a Terracina, tutto il Lazio, tutta l’Umbria, tutte le Marche, tutta la Romagna e parte dell’Emilia compresa Bologna; ma anche di smantellarvi le piccole turbolente Signorie che vi si erano istallate. Resisteva ancora quella dei Della Rovere a Urbino. Ma tutto il resto era stato richiamato sotto il potere centrale di Roma.
Questo era dovuto al fatto che i Papi, liquidate col Concilio di Trento le pendenze con la Riforma protestante, potevano ora tornare a dedicarsi allo Stato e ai suoi problemi. A dare avvìo a questo nuovo corso era stato il Ghislieri, salito al Soglio come Pio V nel 1566. Apparteneva a quella corrente rigorista che credeva di salvare le anime dal braciere dell’inferno mandando i corpi ad arrostire sui roghi dell’Inquisizione. Ma, a parte questa discutibile teoria, era un uomo energico e volitivo, severo con se stesso prima ancora che con gli altri, scrupoloso ed efficiente. Non volle parenti intorno a sé e combatté senza quartiere il riottoso clientelismo delle vecchie dinastie romane che seguitavano a considerare la Chiesa e i suoi Stati come un loro appannaggio.
A lui era succeduto Gregorio XIII, passato alla storia soprattutto per la riforma del calendario. Su di essa riteniamo opportuno spendere qualche parola, visto che nell’Italia della Controriforma non abbiamo avuto il destro di farlo. Fin allora si era seguito il calendario di Giulio Cesare che aveva diviso i quadrienni in tre anni di 365 giorni e uno di 366: il che, per quei tempi, rappresentava un miracolo di precisione. Ma gli astronomi e i matematici del Cinquecento avevano appurato che, secondo quel calcolo, ogni quattrocento anni il cosiddetto anno «tropico», cioè l’anno naturale, anticipava di tre giorni l’anno giuliano: per cui, per esempio, nel Cinquecento l’equinozio di primavera veniva a cadere in realtà l’11 marzo, mentre il calendario lo fissava al 21. Gregorio, per rimettere ordine in quella dissestata contabilità, ordinò nel 1582 che undici giorni fossero saltati in ottobre – dal 4 al 15 –, e che d’allora in poi gli anni centenari, cioè di chiusura di un secolo, non fossero più bisestili, come fin allora erano stati considerati, ma ordinari, meno quelli le cui due prime cifre fossero divisibili per quattro (ad esempio, il 1600). Successivi studi stabilirono che nemmeno questo computo era assolutamente esatto, poiché esso conduce a un ritardo di sessantuno diecimilionesimi di giorno ogni cento anni. Ma lo scarto è tale che solo tra quattromila anni occorrerà sopprimere un altro bisestile per riportare il conto in parità. (Ci auguriamo di aver reso intelligibili e riportato con esattezza questi complicati calcoli. Se non ci siamo riusciti o siamo caduti in qualche errore di diecimilionesimo, il lettore ce lo perdoni.)
La riforma gregoriana, immediatamente adottata da tutti i Paesi cattolici, fu dapprima osteggiata da quelli protestanti. Ma alla fine anche questi dovettero arrendersi e accettare il nuovo metro di misura. I Paesi greco-ortodossi invece rimasero ostinatamente fedeli al calendario giuliano nonostante la sua riconosciuta imprecisione, solo perché a riformarlo era stato il capo dell’odiata Chiesa cattolica: e ciò dimostra a quali estremi di faziosità conduca il litigio religioso.
Gregorio fu un gran Papa, anche a prescindere dal calendario. Come il suo predecessore, fu un modello di sobrietà e di zelo e non ebbe debolezze per i propri parenti. Rimise ordine nell’amministrazione dello Stato. E il suo fisco, se fu rapace e spietato, lo fu imparzialmente con gli umili e coi potenti. Per sfuggire alle sue esazioni, rampolli di nobili famiglie come il Piccolomini e il Malatesta si dettero alla macchia e diventati capi di bande brigantesche provocarono una tale anarchia che Gregorio dovette scendere con loro a un compromesso umiliante.
Ma il suo successore, Sisto V, riprese la lotta con piglio ancor più risoluto. Veniva da una povera famiglia marchigiana, e oltre che nel fisico tracagnotto e atticciato, portava le stigmate della sua origine contadina anche nel carattere inflessibile e paziente. Il giorno in cui ascese al Soglio, il suo discorso inaugurale fu la lettura della condanna a morte contro quattro banditi, che vennero impiccati seduta stante. Per liquidare quelli alla macchia, si rivalse sulle famiglie imprigionandole come ostaggi. Il Duca d’Urbino, in ottemperanza ai suoi ordini, caricò alcuni muli con cibi avvelenati e li avviò verso le zone infestate dai briganti. Costoro ne fecero man bassa, e in capo a poche ore rimasero stecchiti. I Romani dicevano – ma più con rispetto che con dispetto – che San Pietro tremava all’idea di dover un giorno ospitare in paradiso quel tipo che avrebbe messo sotto processo anche lui per aver rinnegato Gesù il giorno della tortura.
Eppure ci fu qualcuno ch’ebbe ragione di quest’uomo che aveva ragione di tutti: i parenti. Sisto li ebbe subito dattorno e non seppe resistere alla loro miseria forse perché egli stesso l’aveva così a lungo sofferta. Con lui rifece capolino la piaga del nepotismo, che i Papi della Controriforma avevano eliminato; ma non sulla scala e nelle forme sfacciate che aveva assunto nella Rinascenza. Quello che ricomincia con Sisto e che doveva caratterizzare quasi tutti i Pontificati successivi si chiama infatti «piccolo nepotismo», che tuttavia per certi aspetti doveva rivelarsi anche peggiore, più ipocrita e insidioso di quello grande. I familiari del Papa non diventano più Principi o Duchi preposti al governo di qualche Stato. Si contentano del sottogoverno, monopolizzandone i posti più lucrosi, grazie alla protezione del «Cardinale-nipote», cioè del nipote preferito, che viene nominato cardinale appunto perché provveda alla parentela. E così fu proprio quel Sisto che aveva perseguito con tanta energia la bonifica dello Stato a riportarvi quei veleni della corruzione che nei tre secoli successivi dovevano fare di quello pontificio il peggiore governo italiano, inetto e sopraffattore allo stesso tempo, inteso soltanto alla difesa dell’analfabetismo e dei privilegi.
Alla chiusura del secolo, sul Soglio sedeva Clemente VII...