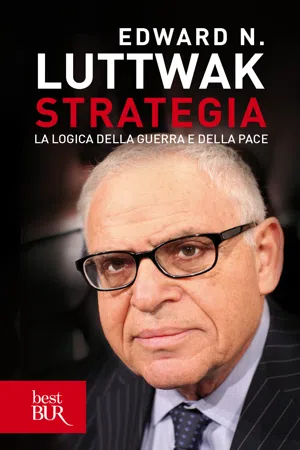Introduzione
Abbiamo visto che la strategia è costituita da una sequenza di azione, culmine, declino e capovolgimento della logica paradossale, sequenza che condiziona sia la competizione e la lotta di intere nazioni sia, esattamente allo stesso modo, la più dettagliata interazione fra armi e contromisure, perché la stessa logica si manifesta su scala vastissima e su scala minima, in tutte le forme di guerra e anche nella diplomazia fra avversari in tempo di pace.
Il contrasto dinamico fra due volontà in contrapposizione è la fonte comune di questa logica, ma i fattori che essa condiziona variano a seconda del livello dello scontro, dalla guerra alla pace fra le nazioni fino agli scontri tecnici fra sottosistemi specifici, come i radar di controllo dei missili contro i ricevitori di allarme radar, gli Rwr (Radar Warning Receiver), apparati montati sugli aerei per segnalare che sono stati inquadrati da radar avversari.
Ogni livello ha una sua realtà propria, ma è di rado indipendente da altri livelli superiori o inferiori. Così l’interazione a livello tecnico di determinate armi, controarmi e contromisure è subordinata a quello tattico di combattimento delle forze che fanno uso di queste particolari armi; la forza e la debolezza di questi reparti nel loro insieme derivano da ogni genere di fattori, alcuni materiali come le forniture, alcuni ben definiti come l’addestramento, altri misteriosamente intangibili: morale, coesione e capacità di comando.
Questi ultimi sono spesso più importanti per i risultati dello scontro di quanto non lo siano i fattori tecnici che determinano le capacità e i limiti delle armi impiegate. Il livello tattico è a sua volta subordinato a livelli superiori dominati anch’essi da altri fattori. Sono possibili azioni di combattimento del tutto indipendenti (questa, in effetti, è la definizione delle incursioni dei commandos nella terminologia militare americana), ma di solito le mosse a livello tattico di determinati reparti delle forze armate degli opposti schieramenti sono soltanto aspetti subordinati di mosse più importanti che coinvolgono molti altri reparti. Poi vi sono le interazioni a livello operativo, che determinano le conseguenze di quanto viene fatto o non fatto in campo tattico. Se un reparto resiste valorosamente a un attacco, il suo successo tattico comporterà soltanto la sua cattura o la sua distruzione nel caso in cui ripieghino altri reparti ai suoi fianchi: se un reparto non riesce a sferrare il proprio attacco, può sempre affiancarsi a un’avanzata più importante qualora gli altri reparti attaccanti abbiano successo. Così il livello operativo domina di norma quello tattico e i fattori condizionati dalla logica a livello operativo sono molto diversi: per esempio, i dettagli topografici o di disposizione sono ormai superati, e quel che conta è l’interazione generale dei rispettivi schemi d’azione. Reparti deboli sul piano tattico possono così sconfiggerne altri più forti, se guidati da uno schema generale superiore; reparti tatticamente forti possono essere sconfitti se guidati da un piano operativo di livello inferiore, ed è quanto accadde nel maggio 1940, quando le truppe francobritanniche furono sconfitte da colonne tedesche meno numerose.
Gli eventi a livello operativo possono avere dimensioni vaste, ma non sono mai autonomi; sono governati, a loro volta, dalla più ampia interazione delle forze armate nel loro complesso, nel quadro dell’intero teatro bellico, proprio come le battaglie sono soltanto una parte subordinata delle campagne. Ed è a questo livello superiore di strategia di teatro che si avvertono le conseguenze delle singole operazioni sulla condotta generale dell’offensiva e della difesa. Questi vasti propositi militari contano poco al livello operativo, nel quale i difensori possono decidere di sferrare un attacco per proteggere meglio il proprio settore, nel quale l’attaccante può restare sulla difensiva in un settore per concentrare altrove la propria azione offensiva. Nella maggior parte dei casi le operazioni della condotta della guerra a livello di teatro comprendono come norma sia le mosse offensive sia quelle difensive a livello operativo, indipendentemente dal fatto che l’obiettivo generale sia l’attacco o la difesa. E i punti chiave determinanti sono anche qui molto diversi. Nella guerra terrestre, per esempio, la topografia dettagliata, spesso decisiva in campo tattico e di scarsa importanza in quello operativo, rimane del tutto sommersa; quel che conta è invece l’intero quadro geografico della battaglia, la lunghezza delle linee del fronte, la profondità del territorio da entrambe le parti, la rete stradale e le altre infrastrutture di trasporto. E a livello di teatro, in cui c’è non soltanto maggiore spazio ma anche più tempo, la questione dei rifornimenti diventa decisiva: uno scontro tattico può essere vinto da un reparto con le sue munizioni, il suo carburante e le sue scorte di viveri anche se non sarà possibile un suo rifornimento in futuro; una battaglia a livello operativo può essere vinta nelle stesse condizioni, forse impadronendosi del carburante, dei viveri e addirittura di armi e munizioni del nemico per vincere una seconda battaglia – come fecero più volte i tedeschi in Africa settentrionale nel 1941-42 contro i britannici. Ma i rifornimenti a livello di teatro sono necessari per i molti scontri e le molte battaglie di un’intera campagna, per cui gli effettivi di combattimento dell’insieme delle forze di teatro non possono essere superiori alle loro possibilità di rifornimento, ed è questo il motivo per cui le brillanti vittorie dei tedeschi in Africa settentrionale si conclusero con una completa sconfitta. Dopo aver più volte battuto con le manovre i britannici, alla fine si trovarono nettamente in svantaggio dal punto di vista logistico, incapaci di trasportare abbastanza carburante e munizioni attraverso il Mediterraneo e poi attraverso il deserto di fronte all’interdizione aerea e navale degli inglesi.
L’intera condotta della guerra in uno o più teatri e i preparativi bellici in tempo di pace sono a loro volta espressioni subordinate di lotte nazionali che si svolgono al livello più alto, quello della grande strategia, in cui tutto ciò che è militare avviene entro il quadro molto più vasto dell’attività di governo, della diplomazia internazionale, dell’economia, e di tutto quanto da esse dipende.
Dato che i fini estremi e i mezzi di base sono presenti soltanto nella grande strategia, il risultato delle operazioni militari viene determinato solo a questo massimo livello: perfino una riuscitissima conquista è un risultato provvisorio, che può venire capovolto da un intervento diplomatico da parte di Stati più potenti; anche una grave sconfitta militare può essere riscattata dall’intervento di nuovi alleati che una condizione di debolezza può attirare nei soliti procedimenti dell’equilibrio di potenza.
Questi cinque livelli (tecnico, tattico, operativo, di strategia di teatro, di grande strategia) formano una gerarchia ben definita, ma i risultati non sono imposti a senso unico dal vertice alla base, perché i livelli interagiscono fra loro. Gli effetti tecnici contano soltanto se hanno conseguenze tattiche (buoni piloti possono abbattere aerei migliori; carri armati migliori possono venire distrutti da carristi migliori), ma è ovvio che un’azione a livello tattico dipende, a sua volta, almeno in parte dal funzionamento tecnico (anche i migliori piloti possono avere la peggio di fronte ad aerei con caratteristiche superiori), proprio come i molti episodi tattici che formano un livello operativo ne influenzano il risultato, anche se sarà questo a determinare il loro significato. Allo stesso modo, le mosse sul piano operativo hanno un loro effetto a livello della strategia di teatro, che definisce i loro scopi, mentre l’attività militare nel suo complesso influisce su quanto accade sul piano della grande strategia, anche se la portata di questa attività viene determinata proprio a quel massimo livello.
La strategia, dunque, ha due dimensioni diverse: quella verticale dei diversi livelli che interagiscono fra loro e quella orizzontale della logica dinamica dell’azione e reazione, che si svolge contemporaneamente all’interno di ciascun livello. La nostra ricerca è cominciata nella dimensione orizzontale, e i riferimenti a questo o quel livello sono stati inseriti senza una spiegazione sistematica, in modo da lasciare sgombra la scena per il primo incontro con la logica paradossale in azione e i suoi risultati talvolta sorprendenti. A questo punto potrebbe sembrare opportuna una chiara serie di definizioni dei cinque livelli, ciascuna ben esposta e presentata in forma tabellare. Ma il nostro argomento è vario come la vita umana, spesso carico di forti emozioni, limitato da abitudini e pulsioni istituzionali, oscurato da incerti particolari di tempo e luogo di ogni scontro. Per cui una rete di definizioni fatta di frasi astratte finirebbe per chiarire soltanto le forme vuote della strategia e non il suo proteiforme contenuto. Sono già state formulate moltissime definizioni della tattica e di altri livelli di strategia, ma basta osservarne una qualsiasi per rilevare subito una serie di possibili eccezioni. E se queste vengono complicate dall’ulteriore definizione di un’infinità di sottocategorie (tattica aerea, operazioni navali e via dicendo), ci occorrerebbe alla fine un glossario completo per ricordarci ciò che intendiamo dire con la nostra stessa terminologia, senza peraltro approfondire in alcun modo la nostra comprensione dell’essenza reale della strategia.
Di conseguenza sarà meglio proseguire tuffandoci nella sostanza degli scontri strategici, questa volta con l’intento di scomporli nei loro livelli di costruzione. E man mano che ci concentreremo su un livello alla volta, prima di allontanarci per esaminarli nel loro complesso dinamico, scopriremo le linee di demarcazione della stratificazione naturale dei fenomeni conflittuali. Quando ci avventureremo, infine, nelle definizioni, non costruiremo un edificio verbale di nostra invenzione, ma ci limiteremo a esprimere realtà osservate.
Con questo progetto in mente, possiamo addentrarci nel territorio di un singolo caso, la difesa dell’Europa occidentale negli ultimi anni della Guerra fredda. Dopo la guerra arabo-israeliana del 1973, nella quale i missili sia controcarro sia contraerei ebbero un ruolo importante, alcuni esperti militari sostennero che le forze della Nato (che chiameremo da qui in poi «Alleanza») avrebbero potuto resistere a un’offensiva sovietica contro l’Europa occidentale affidandosi a difese non nucleari «ad alta tecnologia», per cui l’Alleanza non avrebbe più avuto bisogno delle costose forze armate che aveva allora schierato, in gran parte divisioni corazzate e meccanizzate appoggiate da artiglieria semovente. Ma, fatto più importante, l’Alleanza non avrebbe dovuto più contare sulle armi nucleari, se non per dissuadere l’Unione Sovietica dall’impiegare le proprie. L’esame di questo caso è la linea guida di quanto segue, con l’aggiunta di esempi storici reali per illustrare gli argomenti – naturalmente anche senza mai servircene per dimostrarli o rinnegarli, visto che conosciamo ormai abbastanza la complessità della strategia per sapere che la storia non può essere utilizzata in questo modo.
5
Il livello tecnico
Le varie proposte per la difesa non nucleare dell’Europa, discusse fino al giorno in cui la Guerra fredda giunse alla sua improvvisa e pacifica conclusione, si accentravano soprattutto sulla difesa dei seicento chilometri circa del cosiddetto «fronte centrale», cioè il confine fra la Germania Federale e i suoi poco amichevoli vicini: la Germania Est e la Cecoslovacchia, oggi scomparse. Tutte quelle proposte si basavano sulla combinazione di due concetti. Uno era quello di affrontare i carri armati e le divisioni motorizzate dell’invasore sovietico con forti contingenti di fanteria dotati di missili controcarro. Secondo alcune di queste proposte, quella fanteria doveva essere composta da truppe regolari, che dovevano sostituire completamente le divisioni corazzate e motorizzate schierate, di certo più costose, e che qualcuno definiva «provocatorie» in quanto avrebbero potuto essere utilizzate anche per l’attacco, oltre che per la difesa. Secondo altre proposte, la fanteria armata di missili controcarro doveva essere composta da unità della riserva o territoriali, da aggiungere alle forze motocorazzate presenti, in modo da fornire un ulteriore elemento difensivo.
L’altro concetto, non del tutto semplice, mirava a combinare sensori su satelliti o su aerei, comunicazioni, centri di controllo ed elaborazione dati e missili a grande gittata, con testate multiple a bersaglio programmato, in sistemi integrati di «attacco in profondità». I sensori sarebbero stati capaci di identificare e localizzare veicoli motorizzati sovietici e altri bersagli in movimento a centinaia di chilometri di distanza dietro il fronte, le reti di comunicazione avrebbero ritrasmesso le informazioni a centri di controllo computerizzati, nei quali sarebbe emerso il quadro completo degli obiettivi da attaccare, sarebbero state immediatamente prese decisioni adeguate e infine i missili avrebbero attaccato in massa questi obiettivi con le loro testate. Un sistema d’attacco in profondità avrebbe, di conseguenza, potuto ostacolare, mettere a soqquadro e decimare le colonne corazzate e motorizzate sovietiche in movimento, molto prima che potessero raggiungere il fronte per contribuire con la loro massa, slancio e potenza di fuoco all’offensiva iniziale delle forze sovietiche già sulla linea del fronte. Questo era anche il compito principale dell’aviazione occidentale dopo aver conseguito la superiorità aerea, ma l’intero obiettivo dell’attacco in profondità era quello di agire su larga scala non appena cominciata la guerra, senza aspettare di avere il completo controllo dei cieli, senza arrischiare ritardi qualora le basi aeree fossero state neutralizzate o se le condizioni meteo fossero state sfavorevoli.
La Guerra fredda ormai è finita da un pezzo, ma l’attacco in profondità sopravvive ancora sotto la nuova etichetta di sistemi di «ricognizione e attacco» che costituiscono la più concreta espressione della cosiddetta Rma (Revolution in Military Affairs, rivoluzione negli affari militari), fonte di preoccupazioni per la burocrazia militare su entrambe le sponde dell’Atlantico alla fine del millennio. È interessante notare che, nonostante la suggestiva definizione di stile sovietico, molti credono che la Rma sia un concetto americano e un nuovo sottoprodotto della tecnologia dei computer, mentre in realtà lo schema nacque presso lo stato maggiore generale sovietico negli anni Settanta, quando l’industria dei computer in Urss era notoriamente arretrata.
Mentre esaminiamo questi due concetti, possiamo già cominciare a immaginare come avrebbe reagito la parte sovietica, effettuando spostamenti per contrastare il loro effetto o per avere il sopravvento con risultati sempre migliori, costringendoli così a scendere dal loro punto culminante di successo lungo la curva dell’efficienza. Ma il nostro scopo è quello di scoprire il funzionamento generico della strategia, anziché esaminare il valore definitivo di queste particolari ipotesi. Di conseguenza dobbiamo esaminare, fotogramma per fotogramma, come su una moviola, in sequenza, ciascun livello, invece di seguire il filmato delle interazioni dinamiche all’interno di un solo livello. Cominciamo con il primo: la fanteria controcarro.
La guerra delle armi
Cominciamo a esaminare il confronto delle armi, ciascuna maneggiata, per definizione, da personale competente, del quale, in questo contesto tecnico, non dobbiamo sapere altro. Da una parte vediamo i carri armati e i veicoli da combattimento della fanteria motorizzata, che costituiscono il filo della spada delle divisioni sovietiche in attacco e che cercano di sfondare il fronte della Nato. Dall’altra parte vediamo la fanteria, schierata a difesa con i suoi missili controcarro, forse disposta in terreno aperto, o forse, più saggiamente, dietro un riparo del terreno, oppure dietro il dubbio riparo di postazioni di cemento armato, anche se a questo livello strategico non terremo conto di ciò, proprio come ignoriamo in che modo si spostano i carri sovietici, se allo scoperto, in piena vista, oppure lungo percorsi riparati che sfruttano le depressioni del terreno o i margini dei boschi (le foreste tedesche, famose per il loro ordine dopo i rimboschimenti del XIX secolo, sono solcate da numerosi e ampi sentieri tagliafuoco). A questo livello è sufficiente osservare un missile controcarro e un carro armato o un trasporto truppe sovietico, al punto che potremmo benissimo vederli uno di fronte all’altro, in un poligono di tiro senza caratteristiche particolari.
Osserviamo che il missile controcarro è un’arma molto economica rispetto a un carro armato o anche a un veicolo per trasporto truppe: costa (si dice ventimila dollari) forse l’1 per cento del carro armato, o al massimo il 10 per cento del trasporto truppe; e mentre bastano soltanto due uomini per costituire una squadra lanciamissili di questo tipo, il carro armato dovrà avere un equipaggio di tre o quattro uomini e altrettanto sarà quello del veicolo trasporto truppe, senza contare i fanti che sono a bordo. Qualsiasi calcolo facciamo dell’elemento umano e della sua vita, la differenza migliora il vantaggio economico del missile controcarro.
Il missile può essere guid...