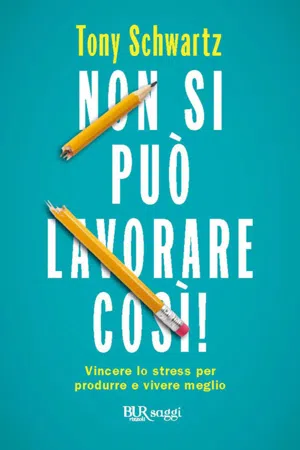Capitolo uno
Sempre di più, sempre di meno
Non si può lavorare così!
Tutto tanto e subito! Non abbiamo mai avuto così tante informazioni a disposizione, la velocità di ogni singola transazione è cresciuta a livello esponenziale e non è raro provare una sensazione di costante urgenza e continua distrazione. Aumentano i clienti da accontentare, le e-mail da scrivere, le telefonate a cui rispondere, gli incarichi da sbrigare, le riunioni a cui partecipare, i posti dove andare… e noi? Ci costringiamo a lavorare sempre di più per evitare di rimanere troppo indietro.
Le tecnologie che agevolano la comunicazione istantanea, dovunque e in qualsiasi momento, accelerano i tempi di decisione, creano efficienza e alimentano un mercato realmente globale. Ma il troppo stroppia e, se lasciate a loro stesse, queste tecnologie potrebbero finire per prendere il controllo su di noi. La sensazione di perenne necessità che caratterizza la maggior parte delle aziende limita l’inventiva, la qualità, l’impegno e la possibilità di prendere decisioni serene e di realizzare prestazioni ottimali.
Quello che produciamo – misurato in euro, volumi di vendita, beni o merci varie – non ci basta mai. Corriamo, ci affanniamo e lavoriamo più ore e non di rado fino a notte inoltrata. Siamo talmente immersi nella corsa da non renderci conto di partecipare a una gara impossibile da vincere, proprio come Sisifo.
Tutta quest’attività frenetica provoca una serie di svantaggi nascosti: la riduzione della capacità di concentrazione, del tempo a disposizione e dell’opportunità di riflettere attentamente e in prospettiva. Quando poi finalmente torniamo a casa non abbiamo più energie, né per passare del tempo con la famiglia, né per staccare la spina e rilassarci veramente. Andiamo al lavoro ogni mattina sentendoci sempre meno riposati, al di sotto delle nostre reali possibilità e incapaci di concentrarci, innescando un circolo vizioso che si alimenta da sé. Persino chi riesce ancora a sostenere performance di alto livello ne risente in termini di soddisfazione e appagamento generale. La filosofia del «tutto tanto e subito» genera un valore limitato, superficiale e a breve termine. «Sempre di più» paradossalmente si trasforma in «sempre meno».
A riconferma di quanto detto finora, pubblichiamo i risultati dell’ultima inchiesta sulla forza lavoro nel mondo realizzata dalla società di consulenza Towers Perrin nel 2007-2008, prima della recessione globale. Lo studio analizzava le condizioni di 90.000 lavoratori dipendenti di diciotto Paesi diversi: solo il 20 per cento di loro si definiva totalmente votato al lavoro – cioè in grado di muoversi autonomamente nell’ambito e oltre le proprie competenze – perché provava un sincero senso di dedizione e piacere per la propria professione, il 40 per cento si definiva «arruolato», ossia adeguato al proprio compito ma non totalmente dedito, e il 38 per cento disilluso o disimpegnato.
Emerse inoltre che le società che avevano tra le proprie fila i dipendenti più impegnati riportavano un aumento del reddito operativo del 19 per cento e una crescita dei guadagni per azione del 28 per cento. Quelle con i dipendenti meno entusiasti registravano invece un calo del 32 per cento nel reddito e dell’11 per cento nei guadagni. Inoltre, nel primo caso, il 90 per cento degli impiegati non prevedeva di abbandonare il proprio posto di lavoro, mentre nelle altre il 50 per cento dei dipendenti considerava l’ipotesi di andarsene. Più di un centinaio di studi in merito hanno dimostrato l’esistenza di legami tra impegno dei dipendenti e performance commerciali.
Pensate per qualche istante alla vostra esperienza di lavoro.
Quanto vi impegnate realmente? Cosa comporta davvero il vostro modo di lavorare? Qual è l’impatto su collaboratori e famigliari?
E quale sarà lo scotto da pagare se tra dieci anni sarete ancora fermi a questo stile lavorativo?
Non si può lavorare così! E questo vale tanto nell’ambito affettivo quanto in quello professionale. Si parte dall’idea, errata, che il modo migliore per ottenere risultati sia lavorare più a lungo, incessantemente. Ma più lavoriamo e meno ci ricarichiamo, più metteremo in atto comportamenti che riducono l’efficienza, come distrazione, impazienza, frustrazione e disimpegno, che si ritorceranno negativamente anche su chi ci sta intorno.
Il vero problema non è il numero delle ore passate dietro a una scrivania ma l’energia che destiniamo al lavoro da svolgere e il valore che siamo in grado di generare. Numerosi studi indicano che siamo più produttivi quando alterniamo momenti di grande concentrazione a fasi di riposo. Ma nonostante tutto ci ostiniamo a vivere in una sorta di zona grigia, facendo salti mortali tra le varie attività senza mai impegnarci realmente in nessuna di esse o al contrario disinteressandoci di tutte. La principale conseguenza è che ci accontentiamo di una pallida versione di ciò che in realtà potremmo ottenere.
Ma allora perché continuiamo a lavorare così?
La risposta risiede nella convinzione, profondamente radicata nel mondo delle aziende e nella nostra stessa vita, che gli esseri umani raggiungano il massimo della produttività quando funzionano come computer: continuamente, per lunghi periodi di tempo, ad alta velocità, e gestendo più programmi alla volta. Fin troppe persone si sono buttate a capofitto in questo ideale, una specie di sindrome di Stoccolma, cercando di imitare fedelmente le macchine su cui lavorano, con l’unico risultato di essere controllati da quelle.
Il limite dei computer, anche di quelli più avanzati, è che si svalutano nel tempo. Gli esseri umani hanno invece un potenziale di crescita e di sviluppo, di aumento della propria profondità, complessità e capacità, ma perché ciò sia possibile bisogna imparare a gestirsi in modo più efficiente di quanto si faccia ora.
Per l’essere umano sopravvivere significa sfruttare e rinnovare la propria energia. Il nostro corpo procede per fasi cicliche, è vigile durante il giorno, assopito di notte e impegnato per periodi di tempo limitati. Tuttavia si stanno diffondendo stili di vita sempre più «lineari»: lavoriamo senza tregua per lunghe ore, sfruttiamo troppa energia mentale ed emozionale senza riuscire a rigenerarci a sufficienza, sacrificando sia la nostra capacità di ricaricarci sia i benefici derivanti dal giusto equilibrio tra riposo e rinnovamento, come per esempio maggiori esplosioni di creatività, prospettive più ampie, possibilità di riflettere meglio e a lungo termine, tempo sufficiente per metabolizzare le esperienze. Conduciamo vite sedentarie casa-ufficio, usiamo troppo poca energia fisica, indebolendoci sempre di più: l’inattività esige un dazio fisico che si ripercuote anche sullo stato d’animo e sul nostro modo di pensare.
Prestazioni da esperti
Nel 1993 Anders Ericsson, uno tra i più importanti studiosi delle performance di eccellenza e professore alla Florida State University, condusse un’indagine sul potere che può avere un esercizio reiterato sui violinisti.1 Numerosi scrittori, incluso Malcolm Gladwell nel libro Fuoriclasse. Storia naturale del successo, hanno citato gli studi di Ericsson come testimonianza a sostegno della sopravvalutazione del talento naturale. Secondo Gladwell, «quelli ai piani alti non lavorano semplicemente molto più degli altri, ma molto, molto di più».2
Tale conclusione però non esauriva certo la complessità delle scoperte di Ericsson. Insieme a due colleghi, divise trenta violinisti della Academy of Music di Berlino in tre gruppi secondo le valutazioni che ne davano i loro professori. Il gruppo dei «migliori» era formato dai violinisti destinati a diventare un giorno solisti, i «buoni» violinisti avrebbero concorso a carriere nella cornice di un’orchestra, mentre il terzo gruppo, reclutato dalla divisione di educazione musicale dell’accademia, era quello dei futuri insegnanti di musica. Tutti avevano cominciato a suonare il violino all’età di circa otto anni.
Furono raccolte grandi quantità di dati su ognuno dei soggetti: veniva infatti chiesto loro di tenere un diario di tutte le attività svolte, ora per ora, nel corso di un’intera settimana specificando inoltre di valutare ogni azione con un punteggio da 1 a 10 in base a tre criteri. Il primo era relativo all’importanza dell’attività ai fini di migliorare l’esecuzione al violino, il secondo alla difficoltà attribuita e il terzo al piacere provato.
Emerse che i primi due gruppi, destinati a carriere da professionisti, si esercitavano in media ventiquattro ore a settimana. I futuri insegnanti di musica, al contrario, poco più di nove, un terzo circa del tempo totale degli altri due gruppi. Questa differenza è senza dubbio elevata e suggerisce quanto una buona pratica possa incidere, ma ugualmente affascinante è la relazione che Ericsson scoprì tra esercizio intenso alternato al riposo.
I trenta violinisti erano tutti d’accordo nel sostenere che «la pratica in sé» avesse l’impatto maggiore sul miglioramento delle prestazioni e molti di loro giudicavano l’esercizio l’attività più dura e meno piacevole. I primi due gruppi si allenavano in media 3,5 ore al giorno in sessioni separate da non più di 90 minuti l’una, per lo più durante la mattina, quando erano più freschi e meno distratti, e si riposavano dopo ogni sessione. Gli appartenenti al terzo gruppo si esercitavano in media solo 1,4 ore al giorno, senza osservare alcun tipo di routine, spesso nel pomeriggio, indicando che spesso temporeggiavano prima di mettersi all’opera.
Tutti gli intervistati consideravano il sonno la seconda attività più importante per migliorare le proprie qualità di violinista. In media, gli appartenenti ai primi due gruppi dormivano 8,6 ore al giorno, quasi un’ora in più del gruppo dei futuri insegnanti di musica, che dormivano una media di 7,8 ore (per inciso, gli americani dormono in media solamente 6,5 ore a notte). I primi due gruppi riuscivano anche a schiacciare un pisolino durante il giorno, per un totale di quasi tre ore a settimana, nello stesso arco di tempo i maestri si riposavano per meno di un’ora.
I grandi professionisti, come suggeriva l’indagine di Ericsson, lavorano più intensamente ma si riposano anche di più, perché l’esercizio individuale intrapreso con grande concentrazione è particolarmente sfiancante. I violinisti del primo gruppo compresero intuitivamente di poter ottenere risultati migliori lavorando intensamente e senza interruzione per non più di novanta minuti alla volta per un totale massimo di quattro ore al giorno. Riconobbero anche la necessità di prendersi del tempo per riposare e ricaricarsi. In diversi altri campi, dallo sport agli scacchi, si è scoperto infatti che quattro ore al giorno è il tempo massimo che i migliori professionisti dedicano all’esercizio. Ericsson concluse che proprio questo dato poteva rappresentare «un limite generale di allenamento sostenibile per lunghi periodi di tempo e senza pericolo di esaurimenti».3
Poiché è molto semplice misurare il numero delle ore di lavoro, le aziende cadono spesso nell’errore di valutare i dipendenti in base al tempo che trascorrono dietro la scrivania piuttosto che in base alla concentrazione o ai risultati che ottengono. Molti si lamentano per il numero troppo elevato di ore, ma in realtà è molto meno impegnativo lavorare a intensità moderata per periodi di tempo prolungati piuttosto che al massimo dell’intensità per intervalli più brevi. Se fossimo in grado di concentrarci in modo più intenso in un intervallo limitato di tempo, proprio come i violinisti dello studio, le grandi prestazioni sarebbero più ...