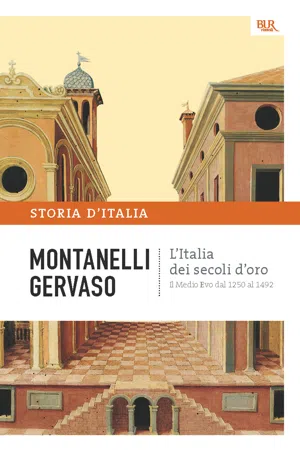AVVERTENZA
Questa Italia dei secoli d’oro segue a L’Italia dei Comuni, che a sua volta seguiva L’Italia dei secoli bui. Si tratta cioè della terza puntata di una ricostruzione della nostra civiltà che, almeno nell’intenzione degli autori, dovrebbe arrivare sino ai giorni nostri.
Il periodo che questo volume abbraccia è quello compreso fra la morte di Federico II (1250) e la scoperta dell’America (1492). È un periodo splendido, forse il più splendido del nostro passato, ma che tuttavia prepara la miseria di quelli successivi. Noi abbiamo appunto cercato di chiarire per quali motivi ciò che fece lì per lì la grandezza dell’Italia ne propiziò anche la decadenza. E perciò, invece di correre dietro alle vicende dei singoli staterelli italiani, alla loro complicata diplomazia e alle loro guerricciòle, che mai o quasi mai superarono i limiti della piccola cronaca, e spesso del pettegolezzo, abbiamo preferito seguire le grandi linee dello sviluppo civile del nostro popolo, l’evoluzione del suo costume, del suo pensiero, della sua arte: che furono le grandi palestre in cui gl’italiani sfogarono le loro energie, purtroppo dispensate dall’impegno di costruire una Nazione e uno Stato.
Non abbiamo avuto di mira nessuna tesi preconcetta. Abbiamo solo accettato e registrato le lezioni che i fatti c’impartiscono, cercando di non farci influenzare dai soliti miti e luoghi comuni. Come al solito ci diranno che abbiamo esagerato l’importanza di certi avvenimenti e personaggi a scapito di altri. E come al solito noi rispondiamo che non c’è libro di storia che non si presti a queste critiche. Ci diranno anche che il nostro modo di raccontare non rispetta abbastanza i canoni della storiografia ufficiale e accademica. E noi rispondiamo che non li rispetta affatto perché di proposito non intendiamo rispettarli. Noi ci rivolgiamo a quella grande massa di lettori che solo ora si svegliano alla coscienza della propria storia appunto perché la storiografia ufficiale e accademica li ha sempre da essa esclusi. E in che misura siamo riusciti a raggiungerli lo dimostrano le tirature di questi libri, tutti al di là delle centomila copie e qualcuno (la Storia di Roma, per esempio) delle duecentomila. Il successo, siamo d’accordo, non è l’unico metro su cui si debba misurare il valore di un’opera; ma la sua efficacia, sì.
A questo volume seguirà L’Italia della controriforma, cioè il Cinquecento. Ma non sappiamo se riusciremo ad approntarlo per il Natale dell’anno venturo. La Controriforma è l’avvenimento che decise la nostra sorte di Nazione, cioè che la fece abortire. E grazie alla nuova atmosfera introdotta dal Concilio, crediamo che sia finalmente suonata l’ora di ricostruire quel grande dramma della coscienza cristiana non più in termini di ortodossia ed eresia, ma di storia pura e semplice, un’impresa in cui siamo impegnati già da un anno, ma che forse ce ne richiederà altri due per condurla a termine.
Ringraziamo il lettore di averci accompagnato fin qui. È lui non solo il destinatario, ma anche il vero ispiratore di quest’opera. Se ci avesse abbandonato, noi avremmo già smesso di scriverla.
I.M.
R.G.
Ottobre 1967
CAPITOLO PRIMO
RINASCIMENTO E UMANESIMO
Fu il Vasari che nelle sue Vite de’ più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani diede il nome di «Rinascimento» al periodo che va dall’inizio del Tre alla fine del Cinquecento.
Su queste date fervono ancora le discussioni. C’è chi fa cominciare il Rinascimento un po’ dopo, c’è chi lo fa finire un po’ prima. Ma a noi tutto questo sembra piuttosto ozioso. Un po’ meno oziosa ci sembra la polemica sul significato da attribuire alla parola, perché vi sono coinvolti i motivi che provocarono questo straordinario fenomeno e fecero sì che avesse per patria l’Italia.
Il Vasari lo chiamò «Rinascenza» perché ai suoi occhi apparve come la pura e semplice resurrezione della cultura classica dopo mille anni di tenebre medievali. Secondo lui, si trattava dunque di una specie di vendetta che l’elemento latino si prendeva, dopo averle assimilate, sulle orde gotiche, longobarde e franche, che lo avevano soggiogato e schiavizzato.
Questa concezione è solidamente fondata. Non c’è dubbio che, fra le province dell’antico Impero romano, l’Italia fu quella che per prima assorbì gl’invasori tedeschi nonostante la loro politica di segregazione razziale, e li convertì alle civili strutture che Roma aveva dato alla società. Questo avvenne un po’ perché le invasioni furono in Italia meno alluvionali che in tutto il resto dell’Occidente; un po’ perché il nostro Paese era, per ovvi motivi geografici, il più profondamente intriso di civiltà romana, e finalmente perché Roma, anche se non era più la Capitale dell’Impero, ormai trasferitasi a Costantinopoli, era rimasta la Capitale della Chiesa. Via via che i barbari si convertivano al Cristianesimo, ne diventavano virtualmente vassalli. Per pregare Dio e parlare col Papa, i Tedeschi dovevano imparare il latino. E, una volta imparatolo, compresero la superiorità delle leggi e dell’organizzazione romane, e dovettero rivolgersi a legislatori e funzionari latini. Da quel momento essi rimasero prigionieri di una cultura cui non avevano nulla da contrapporre se non la primitiva poesia della «Saga» e la rozza legge della «Fàida».
Ma credere che il Rinascimento non sia stato che la riscoperta della civiltà classica sarebbe un diminuirlo. Questa riscoperta non ne rappresenta che un capitolo: quello che si chiama «Umanesimo», e che ebbe in Petrarca il suo maggiore protagonista. Umanisti furon detti appunto quei diligenti topi di biblioteca, quegli impavidi sommozzatori di archivi, che si dedicarono alla scoperta dei testi classici scampati alle distruzioni e alle dispersioni del Medio Evo, li disseppellirono dagli scantinati dei conventi dove i monaci, specie i benedettini, li avevano preservati e spesso trascritti. E che ciò avvenisse soprattutto in Italia è logico, perché soprattutto in Italia quei testi si trovavano.
Questa resurrezione della cultura classica fu uno degli elementi del Rinascimento, forse il primo, certamente uno dei maggiori. Cicerone diede la sintassi ai prosatori italiani di allora, Virgilio la metrica ai poeti, Vitruvio le nozioni agli architetti. Ma questi prosatori, poeti, architetti eccetera non si limitarono alla semplice imitazione dei modelli classici. Fu quello che vi aggiunsero a fare del Rinascimento la più grande esplosione del genio umano che la storia abbia registrato dopo il secolo d’oro ateniese. E a questo contribuirono anche altri fattori.
Anzitutto, l’urbanesimo. I Tedeschi, finché rimasero isolati dalle loro discriminazioni razziali, non ebbero vita urbana. Vissero in campagna e nei castelli, dove svilupparono quello che oggi si chiama un way of life, un modo di vita, ma non una «civiltà», termine derivato da quello di «città». Roma e Atene erano state civiltà perché erano città. La Macedonia era stata solo un esercito perché non era che un contado agricolo e pastorale.
Le città italiane furono le prime, in tutto l’Occidente, a ridiventare protagoniste della vita del Paese dopo la lunga parentesi rurale del Medio Evo. L’Italia non fu mai completamente feudalizzata, cioè ruralizzata. Sebbene decadenti e mezzo disabitate, le città avevano resistito. Una vita urbana quindi non dovette in Italia ricominciare da zero.
Ma, a procurare a quelle italiane una posizione di avanguardia, ci fu anche un fatto geografico. Il Mediterraneo era a quei tempi la strada maestra di tutti i commerci: e non soltanto di quelli materiali, ma anche di quelli culturali. Era in questo mare che s’incontravano l’Occidente latino-germanico, l’Oriente greco di Bisanzio, e quello dell’Islam. Questi incontri erano talvolta scontri. Ma più spesso erano scambi. L’Oriente, allora, era più avanti dell’Occidente. In tutto: sia nella produzione industriale che in quella intellettuale. Di lì venivano all’Europa le sete, i damaschi, le spezie, i segreti per la lavorazione delle stoffe e le formule chimiche per colorarle. Ma di lì venivano anche la geometria, l’algebra, la logica aristotelica: tutte cose che l’Europa aveva dimenticate da un pezzo e di cui i porti italiani diventarono i privilegiati e obbligatori punti di raccolta.
Tutto ciò significava ricchezza, che della cultura non è una condizione sufficiente; ma necessaria, sì. Durante il Medio Evo l’unica seria industria italiana era stata la Chiesa. In tutto l’Occidente cristiano gli «oboli» dei fedeli prendevano la strada di Roma, e di qui si diffondevano nella Penisola, dove un po’ di capitalismo sopravvisse sempre. In Italia la moneta si rarefece, ma non scomparve mai del tutto, com’era accaduto nei Paesi completamente ruralizzati, dove si era tornati allo scambio in natura.
Questi rivoletti o rivoloni d’oro seguitavano ad affluire. Ma a essi ora si aggiungevano ben altre fonti. Anzitutto, i noli marittimi. Genova e Venezia avevano le più belle flotte del tempo, gli ammiragli più sagaci, i più esperti equipaggi. Essi dovevano sfidare i gravi rischi delle tempeste e dei pirati, ma se li facevano ben ripagare. E le materie prime e i manufatti che viaggiavano sui loro «dromoni» e «galee» facevano tappa in Italia ad alimentarvi l’industria e il commercio. Il Rinascimento non sarebbe stato concepibile senza questo accùmulo di capitale. Fu il denaro dei tessitori, dei mercanti e dei banchieri fiorentini che permise a Giotto e Arnolfo di fare quel che fecero.
Un altro stimolo furono le ambizioni sociali della plutocrazia cittadina, cui l’industria, la banca e il commercio avevano dato l’aìre. Il mondo ereditato dal Medio Evo era di caste chiuse a struttura piramidale. Sebbene politicamente ed economicamente decaduta, la nobiltà formava il vertice di questa gerarchia ereditaria. Il nuovo ricco non aveva altro mezzo di scalata sociale che il mecenatismo. Non avendo potuto procurarsi un blasone arruolandosi in una Crociata, si guadagnava un merito finanziando la costruzione o l’abbellimento di una chiesa. Il Rinascimento deve molto allo snobismo dei borghesi. Gli deve oltre tutto la sua secolarizzazione. Fino a quel momento l’arte era stata soltanto sacra perché solo la Chiesa era stata in grado di pagare gli artisti. Ora che le «commesse» venivano dalla borghesia, architetti, pittori e scultori potevano perseguire ideali di bellezza non più ispirati solo a motivi sacri e sottoposti alla censura dei preti.
Ma a far sì che il Rinascimento assumesse la cittadinanza italiana, ci fu anche un altro e decisivo fatto: la maggiore rapidità di maturazione consentita dai circuiti più ristretti. Nel Duecento, all’avanguardia non era l’Italia, ma la Francia. Lo era nella sua lingua provenzale, già molto più perfezionata del nostro «volgare». Lo era nella poesia, dove i «trovatori» dettavano la loro legge e i loro modelli a tutto il mondo. Lo era nell’architettura, che aveva già elaborato col «gotico» i suoi più alti modelli. Lo era nella filosofia, di cui Abelardo aveva spalancato le porte all’averroismo, cioè al razionalismo aristotelico filtrato attraverso la cultura araba di Cordova e di Saragozza.
Ma la Francia non poté mantenere questo primato perché le sue energie furono subito assorbite da un altro compito: la fondazione dell’unità nazionale e la creazione di uno Stato. Era un compito immenso, specie per quei tempi, che infatti impegnò le risorse del Paese e le energie dei suoi Re fino a quasi tutto il Cinquecento. In questo periodo la palestra dell’intellighenzia francese furono l’esercito, la burocrazia e la diplomazia, non le lettere, le scienze e le arti.
L’Italia, soprattutto per via della Chiesa che per meglio dominarla la voleva divisa, non si propose nemmeno questo traguardo dello Stato unitario. Si contentò prima dei Comuni e poi dei Principati. E dentro questi ristretti organismi le nostre élites, dispensate da altri compiti, poterono più rapidamente integrarsi e maturare. Firenze, Venezia, Milano fecero come Atene: in due secoli passarono da una condizione semibarbara alla più alta civiltà del mondo perché operarono nel ristretto perimetro delle mura cittadine. Mentre Francia, Spagna, Inghilterra producevano Generali, ammiragli e funzionari, noi producevamo artisti e li esportavamo anche nel resto del mondo.
Ecco perché questo è un libro più di uomini che di vicende. Quando un popolo non ha una Nazione, non ha nemmeno una storia. E infatti il nostro Rinascimento non è che una collezione di cronache ma che hanno per protagonisti Dante, Petrarca, Boccaccio. Insomma, dei giganti.
E ora riprendiamo il filo del nostro racconto da dove lo avevamo lasciato con L’Italia dei Comuni.
CAPITOLO SECONDO
L’EREDITÀ DI FEDERICO
Correva l’anno 1250. Sul suo letto di morte, a Fiorentino, in Puglia, dove la dissenteria lo divorava, Federico il Grande forse ricapitolava mentalmente il suo fallimento. Era nato a Jesi presso Ancona cinquantasei anni prima, sotto una tenda militare drizzata sulla piazza del mercato, ma non aveva nulla d’italiano. Nelle sue vene scorrevano congiuntamente il sangue degli Hohenstaufen di Svevia e quello dei Normanni di Sicilia. Era cresciuto orfano a Palermo, e non aveva mai potuto disintossicarsi di quell’isola allora all’apice del suo splendore e centro di una civiltà cosmopolita greco-arabo-ebraico-fenicia. Varie volte era andato in Germania. Ma non era mai riuscito a restarci più di qualche mese.
La Germania era un caos di Reucci, Principi, Vescovi, Conti e Vescovi-Conti, concordi solo nell’impedire che uno di loro emergesse sugli altri e che l’Imperatore nominale diventasse effettivo. Federico aveva rinunziato a mettervi ordine non perché l’impresa fosse impossibile, come aveva sempre detto agli altri e a se stesso, ma perché non gli piaceva vivere che in Italia. A quei suoi compatrioti rozzi e rissosi, le rare volte che tornava tra loro, chiedeva soltanto tregua, la comprava con l’oro, e ridiscendeva a precipizio le Alpi. L’Italia, non vedeva e non palpitava che per l’Italia. Era questo il Paese di cui aveva voluto fare una Nazione, tutta la vita aveva perso dietro a questo sogno.
Per realizzarlo, aveva affidato la corona di Germania a suo figlio Corrado, e con gli altri due figli, Enzo e Manfredi, percorreva la penisola battendo un esercito dopo l’altro.
Ma era come vuotare il mare. I nemici gli si arrendevano solo per tradirlo alla prima occasione. Il Papa, dopo averlo scomunicato, seguitava a lanciare anatemi contro di lui e subornava i principi tedeschi che montavano una ribellione dopo l’altra. Gli ultimi cinque anni erano stati di guerra senza quartiere. Chiunque fosse amico dell’Imperatore veniva scomunicato dal Papa e destinato d’ufficio all’inferno. Ma chiunque fosse amico del Papa veniva torturato, accecato e mutilato dall’Imperatore.
E ora era finita. Enzo, caduto prigioniero, languiva in una torre di Bologna, da cui non sarebbe uscito mai più. Manfredi, alla testa di un manipolo di veterani per lo più saraceni, seguitava a vincere battaglie. Ma era costretto ad accamparsi fuori dalle mura delle città che, sebbene sconfitte, non gli aprivano le porte.
Il morente doveva chiedersi in cosa aveva sbagliato. Era l’unico Signore che del suo «Regno» italiano (un Regno che si chiamava di Sicilia, ma che comprendeva tutto il Sud-Italia, Napoli inclusa) aveva fatto uno Stato con le sue leggi, coi suoi tribunali laici, con la sua ordinata amministrazione, con la sua moneta, con le sue strade, con una polizia efficiente, con un solido esercito. Alla sua corte era nata la lingua italiana. Era stato un gran diplomatico e un gran Generale. Aveva vinto tutte le battaglie. Eppure aveva perso la guerra.
Chissà se in quegli ultimi momenti Federico ne comprese il perché, che pure era abbastanza semplice. Aveva perso la guerra perché aveva scelto male il Paese in cui combatterla. L’amore dell’Italia lo aveva tradito. Essa non poteva diventare una Nazione perché aveva in corpo il Papa. La Chiesa non poteva dividere Roma con nessun potere laico. E per tenerli tutti lontani, li aveva regolarmente giuocati l’uno contro l’altro, appoggiando i bizantini contro i Goti, i Longobardi contro i Bizantini, i Franchi contro i Longobardi, e negli ultimi tre secoli i liberi Comuni indigeni contro l’Impero. Quando Federico aveva cinto la corona, era ormai tardi per avviare quel processo di unificazione che avrebbe fatto di Francia, Spagna e Inghilterra delle nazioni moderne e le future protagoniste della storia europea. I Comuni erano troppo forti. Alcuni di essi, come Venezia, Genova, Milano e Firenze, erano addirittura delle potenze mondiali. Si era sviluppato uno spirito municipale troppo vivo, si erano costituiti troppi e troppo solidi interessi particolari perché accettassero di dissolversi in un organismo nazionale.
Anche se non li formulò chiaramente, Federico dovett’essere sfiorato da questi pensieri, perché già prima di ammalarsi aveva rinunziato alla lotta. In quel momento, essa sembrava volgere a suo favore. Suo figlio Manfredi e suo genero Ezzelino stavano riportando notevoli successi in Emilia e Lombardia, e il re di Francia Luigi IX, caduto prigioniero dei Musulmani in una ennesima Crociata, aveva supplicato papa Innocenzo IV di riconciliarsi con l’Imperatore in modo che costui potesse venire in suo soccorso. Ma Federico, invece di convocare ambasciatori e Generali, convocò il confessore e gli chiese l’assoluzione dai suoi peccati. Fu il pentimento o la ragion di Stato a ispirargli quel gesto? Non si sa. Comunque, fu quello di un guerriero vinto che in punto di morte affidava l’anima al suo vincitore.
Tuttavia si lasciava dietro un’eredità importante: un sistema di governo, destinato a estendersi in tutta Italia. Per affermare il potere centrale, nel suo Regno, egli aveva distrutto i privilegi dei signori feudali e le autonomie dei Comuni. Tutto era stato livellato da uno Stato che s’incarnava nella sua persona. Sindaci, funzionari e magistrati erano nominati da lui e solo a lui rispondevano senza intermediazione di altri poteri. Aveva inventato il catasto con cui controllava le proprietà e i redditi, e li tassava. Aveva «pianificato» l’economia regolando d’autorità prodotti, consumi e prezzi. Aveva creato una nuova aristocrazia di burocrati, selezionati in base alle loro qualità individuali, e non più al titolo ereditario. La sua Corte, formata solo da uomini di legge, di scienza, di cultura, fu di esempio a quelle dei Signori del Rinascimento. Essi copi...