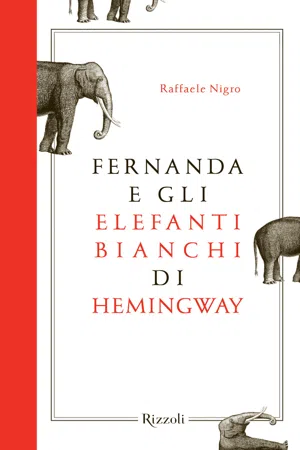![]()
1
Me la ricordo come fosse ora, mentre cercava riparo dal vento in un poncho di lana cobalto, la mia amica Nanda Pivano. Con gli occhi gonfi, forse per l’ira.
In preda allo sconforto, rientrò in albergo stringendo due rametti di timo colti nella siepe che circondava l’edificio, li gettò nella sua borsa di tela e, con voce rauca, biascicò qualcosa contro il messo del Comune che ci aveva recapitato le lettere di dismissioni: “L’amministrazione comunale la ringrazia per l’apporto dato finora come giurato del premio Piero Chiara e interrompe il rapporto con lei.
Firmato il sindaco”.
Ma intendeva: “Egregio signore, lei è indesiderato per ragioni che non le stiamo a spiegare”.
Nanda si accostò al banco del bar e chiese alla giovane barista intenta a sciacquare tazzine un caffè ristretto. Sbuffava, scuoteva i capelli a casco e non stava ferma, morsa dalla tarantola. Non si calmò neppure quando mi accostai e le battei una mano sulla spalla invitandola a tranquillizzarsi, «che in Italia per un premio che lasci cento ne trovi».
In realtà invitavo per primo me stesso alla calma.
Nanda disse che il problema non era il premio in sé, ma il fatto che a settant’anni, dopo aver girato il mondo vezzeggiata, amata e riverita, una roba così non l’aveva mai vista: «Ma siamo impazziti? Di questo passo dove finiremo? Dritti in bocca a una dittatura, ecco dove».
In effetti, poi, forse in Cile l’aveva vista. Cioè che una giunta comunale cacciasse degli scrittori perché erano di opposta fede politica o di un’area geografica non gradita. Tuttavia Nanda non chiese di parlare al sindaco di quel paese steso sotto le Alpi, ci suggerì soltanto di non restare un attimo in più e continuava a soffiare tra sé: «È una vergogna, una vergogna», strofinando nervosamente i grani le collane che nascondevano le rughe del collo e agitando i capelli a casco mesciati.
«Bisogna partire all’istante» ripeteva.
Gli indesiderati eravamo io, che venivo dalla Lucania, Michele Prisco, lo scrittore napoletano, Tano Citeroni, un fotografo abruzzese che viveva a Roma e Gino Montesanto.
Capisco i primi tre, nati tutti sotto il Tevere, ma Montesanto, scrittore originario di Venezia, dunque un padano del Sud, perché cacciarlo? Forse perché veniva da una regione rossa per tradizione?
Saremmo stati sostituiti da altri giurati etnicamente e politicamente corretti e solo a lei, Fernanda Pivano, in quanto discendente di Alberto da Giussano, era concesso di restare. Invece lei infilò l’ascensore diretta in camera a raccattare le sue cose e gridò: «Dica al suo sindaco che Fernanda Pivano è offesa a morte e per il trattamento riservato ai suoi colleghi non accetterà di restare in nessuna giuria di questo posto bastardo!».
Il messo calò il capo e si strinse nelle spalle.
![]()
2
La sera dell’11 o 12 novembre 1992, una sera in cui ci cacciarono da una città del Nord schiaffeggiata dalla tramontana e un taxi ci raccolse davanti a un hotel della periferia e partì verso l’aeroporto di Linate mentre la città cadeva in coma e tra noi scendeva un silenzio di piombo, pensai che era proprio un sopruso. Al quale per giunta non sapevamo come reagire. Perché, fino a quel momento, le reazioni al secessionismo minacciato dalla Lega Nord erano venute al massimo da gruppi neoborbonici del Sud, attraverso quotidiani a tiratura regionale, mai dal governo, né dalle destre che pure dichiaravano in tempi elettorali di voler difendere l’unità del Paese.
Accidenti se lo era, un sopruso. Il Nord decideva quando conquistare e unire l’Italia e poi quando frantumarla. Sicuramente per difendere la propria economia e i propri interessi.
Tuttavia, mentre l’amarezza mi schiacciava contro il sedile come un rullo compressore, un pensiero che si faceva piano piano moto d’orgoglio affiorava dallo stomaco. «Non sei nato nei luoghi di Zenone Parmenide Pitagora Orazio Ennio?» mi chiedevo.
Ero nato proprio laggiù, accidenti a me, tra templi greci e sepolture sannite, appule e lucane. Nato tra cattedrali e castelli medievali risplendenti come ossa di elefanti. Monumenti e storie che in pochi conoscevano.
Per un istante il Meridione, dal quale volevo fuggire, mi parve un luogo che si potesse amare. Pensai ai popoli che avevano arginato i Romani, alla civiltà magnogreca, a Italo e alle tavole di Banzi, al grande Federico II di Svevia e ai giovani trucidati nella Rivoluzione Napoletana e a mille cronache così. Pensai alla letteratura siciliana. Grandissima. Alla pittura napoletana e alle tavole degli iconografi medievali. A quante cose pensai in un istante! Prodotte dal genio di una terra che non aveva saputo mai farsi pubblicità sui giornali.
Per qualche istante, la storia dalla quale il mio mondo emergeva come dalla bocca di un cratere incandescente mi confortò. Riempì il baratro creato dall’infelicità dei ritardi sociali, dell’economia e della delinquenza attuali.
Ma non solo la storia del Sud mi aiutò. Tutto ciò che eruttava dalle crepe della penisola, le mille vicende che avevano colorato di sangue, di passioni e di pensiero la “terra dei limoni”.
Mi appartenevano le cronache di Teodorico e di Giulio Cesare, la via dei Longobardi e dei Franchi o la corona ferrea, i valichi alpini da dove erano dilagati i barbari, i mari solcati dai barbareschi e dagli spagnoli e poi i monumenti dell’Alta Italia, per esempio il Duomo di Milano, l’Arena di Verona o il Ponte di Rialto; per non dire della lingua, questo idioma multicolore che aveva prodotto la più bella letteratura esistente al mondo. Patrimoni che mio nonno Raffaele aveva difeso sul Carso, giberne e moschetto. Si era preso due pallottole all’attaccatura della coscia per lasciarmeli in eredità.
L’aria sapeva di veleno, il Grand’albergo con la sua atmosfera decadente e in abbandono ci appariva ostile. Ostili le querce che reggevano la calotta di buio, le siepi di bosso, le luci smorte del ristorante e della hall.
Fuggimmo.
Senza troppe riflessioni e chiacchiere. Fuggimmo. Qualcuno di noi pensò e disse: «Come ladri». Ma non era vero, stavamo fuggendo da un luogo che ci pareva appestato dal razzismo.
Farfugliai al tassista, appena ingolfato il bagagliaio di valigie, che volevo scendere in macchina a Roma, gli domandai se fosse disposto ad accompagnarmi, qualunque fosse stata la somma. Lui si sollevò il berretto e si grattò la testa: «Una bella scarpinata!» rifletté ad alta voce. «Arriveremo all’alba.»
«Arriveremo quando arriveremo» risposi.
Disse di sì. E Citeroni aggiunse che mi avrebbe fatto compagnia.
Mi accucciai nell’abitacolo della Mercedes come in una cella, sul sedile posteriore, con i miei amici che, avendo aerei in partenza da Linate, avevano chiesto di essere accompagnati in aeroporto.
Michele Prisco si sedette affianco all’autista in un silenzio trasognato. Non lasciava mai trasparire il suo disappunto. Poggiò i capelli bianchi sulla spalliera e si addormentò. Montesanto si perse con lo sguardo nel buio del finestrino e non disse una parola fino a Linate, dove scendemmo per salutarci. Fu allora che Nanda decise di proseguire per Roma insieme a me e a Citeroni, il quale passò davanti, accanto all’autista. Decise con un colpo di testa improvviso. Lei aveva un pied-à-terre laggiù, credo in Trastevere, e vi si rifugiava ogni volta che a Milano le venivano le paturnie.
Disse: «Voglio fare un bagno romano», aggiustandosi le collane di ambra e di corniola; toccava le pietre, le strofinava, come per ricavarne un effetto benefico.
Il tassista si tolse nuovamente il berretto, si grattò la testa e scambiò con noi appena due parole, giusto per domandarci se ci andava bene un certo tragitto. Aveva un accento siculo-milanese.
«Faccia lei» rispose Nanda, «ma per favore non corra che soffro la macchina, non abbiamo fretta. Almeno io.»
«Va bene anche per me» dissi.
Citeroni alzò le mani. Ricordo che aveva delle mani pelose dai pollici larghi e mi chiesi come facesse a scattare foto perfette con quei pollici che parevano martelli. Aveva realizzato molti libri fotografici e qualche romanzo di vena realista.
Mentre il taxi infilava le complanari, ci sembrava che ogni parola fosse superflua e che la disgregazione improvvisa del nostro piccolo gruppo di amici fosse una metafora di quella in atto in Italia e non solo. Le manie della Lega, la deriva a destra del Paese e forse dell’intera Europa, il desiderio diffuso di arginare l’immigrazione dal Mediterraneo, la frantumazione delle regioni della Jugoslavia che aveva fatto dell’Adriatico un inferno, la letteratura che per ragioni di mercato si rifugiava in storie rassicuranti di commissari, di santi Graal e codici ritrovati oppure cercava geni della superficialità, dimenticando i grandi appena seppelliti e bollando per fuori moda e noiosa la tragicommedia degli individui e delle collettività…
Si poteva parlare di tutto e di nulla. Preferimmo il nulla.
Fernanda Pivano affondò la nuca nel poggiatesta e provò ad appisolarsi. Il suo profilo si perdeva nel buio, riemergeva alla luce delle stazioni di servizio o nei fari delle auto incrociate. Era il profilo di una donna ancora affascinante, che aveva travasato il Novecento americano in Italia e che aveva fatto innamorare pattuglie di scrittori di poeti di lettori. Il viso squadrato e un naso piccolo e carnoso, i capelli morbidi e un leggero rantolo che denunciava un lieve disturbo polmonare.
C’era traffico, le auto filavano nonostante fosse calata una leggera nebbiolina e ogni tanto il tassista malediva qualche sciacallo che lo sorpassava addirittura a destra.
«Figghi di cani bastardi» gridava, lasciando in gola la parte lombarda acquisita.
Eravamo allibiti dalla temerarietà di quei guidatori che parevano avvinazzati.
«Vedete? Poi dicono che la polizia ci stanga» gridava il tassista. «Mazziare li deve, a quisti farabutti.»
Riuscì a strapparci una risata e Tano, che moriva dalla voglia di interloquire, gli chiese se non fosse catanese e da quanto tempo era emigrato.
«Vossia sentisti che sono catanese?» domandò il tassista.
«Eh, se l’ho sentito!» ammise Tano, e aprì la conversazione.
Il tassista spiegò che era al Nord da dodici anni, che aveva fatto fatica a ottenere una licenza, che da quando si era verificata l’invasione degli extracomunitari non si campava più e che se la Lega faceva proseliti era per questo, per le tasse e per il desiderio di autonomia da Roma. Disse che lui non votava per la Lega ma ne condivideva le prospettive.
Nanda lo bacchettò, un po’ divertita e un po’ piccata. Gli fece presente che il progresso non passava per quella via e lui attaccò una manfrina politica contro i partiti della prima e della seconda Repubblica che non lo si sopportava più. Fortuna che Citeroni finse di addormentarsi. Il tassista lo osservò sorpreso, provò a rivolgersi a noi che eravamo sprofondati nei sedili posteriori, non gli demmo corda e di colpo si acquietò. Così che l’auto riguadagnò il silenzio.
Quando arrivammo alla periferia di Bologna e la biforcazione dell’autostrada ci indicò a sinistra Taranto e a destra Firenze provai a rompere il gelo: «A volte la storia, quella del tuo Paese, diciamo quella a cui senti di appartenere, riesce a consolarti» mormorai.
«Be’, sì» rispose Nanda, «può farti sentire un gigante. Può essere pericolosa nel senso che ti addormenta nel lustro di cose fatte da altri o, appunto, può farti sentire un gigante e spronarti. Ma può anche scivolare per conto proprio e lasciarti indifferente.»
Tornammo un po’ a tacere, poi lei disse: «Ma perché pensi alla storia adesso?».
«Così. A volte mi consola pensare alla storia, oppure mi dà l’impulso di cui ho bisogno. Il popolo che si arma, che emigra, che vince la miseria il sonno l’analfabetismo, i nobili che costruiscono edifici e poi gli artisti, i filosofi. Accidenti quanto li amo! Le loro vite, le disperazioni che nascono prima e dopo aver realizzato un capolavoro, cose che nessuno conoscerà mai. Che avrò da dividere con un filosofo magnogreco? Che ne so? È un parente lontano. Un bisbisbisqualcuno. Penso a cose così.»
«Insomma roba che non c’è più.»
Tacque per un po’, quindi aggiunse: «Quando non hai altri rifugi ti rintani lì?».
«Mi pare di prendere forza. E di riuscire a possedere tutto il tempo trascorso, mentre il presente mi scappa via dalle mani.»
«Se basta questo, è un vantaggio.»
«Da casa mia poi è passato di tutto» feci notare.
«Questo è vero» commentò Citeroni, «con tutto quel mare che avete attorno… Oh se è vero. Ce ne sono state di mazurche e quadriglie da quelle parti!»
Ora la mente si era abbandonata a una serie di viaggi. Spezzoni di film storici si sovrapponevano a sequenze di documentari televisivi. Pensai che la storia e il passato remoto erano legati ormai nella nostra fantasia alla documentazione cinematografica. Che avevamo perduto l’autonomia dell’invenzione, la libertà di immaginarci i costumi le armi le creature i fantasmi. Tutt’al più qualche frammento di reperto archeologico, ma noioso nella sua staticità e subito divorato da immagini in movimento.
Una frenata brusca causata dall’infittirsi della nebbia mi risvegliò. La strada cominciava a salire verso l’Appennino.
«Si sale» disse il tassista, «e monta questa porcheria di nebbia.»
Guardai verso Fernanda, si era per un momento sporta in avanti e ora tornava a poggiarsi sullo schienale. La fissai intensamente e quando si voltò le chiesi: «Tu sei mai stata dalle mie parti?».
«Una volta» disse lei sollevando appena la testa. «Ma che c’entra questo, adesso?»
«I miei paesi sono fungaie, piove e nascono le storie, nevica e nascono le storie. Escono storie dalla terra come nuvole di mosche.»
«Ho già sentito queste parole» disse lei.
«Da me?»
«No, no. Le ho sentite da una ragazza. Proprio nella tua terra. Sì, da una ragazza di cui ho perso traccia.»
«Quando è avvenuto?»
«Nel ’54 o ’55. O forse nel ’56.»
Non avevo molta voglia di chiacchierare e forse neppure di ascoltare. Lei lo intuì e mi chie...