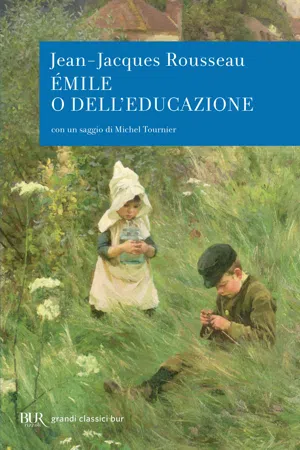
- 611 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Émile o dell'educazione
Informazioni su questo libro
"Al liceo rimasi folgorato dalla lettura dell'Émile. Diventato padre, mi sono guardato bene dall'applicare sui miei figli, alla lettera, le teorie di questo libro multiforme. Mi sembra piuttosto che quanto suggerisce Rousseau sull'arte di formare uomini possa essere applicato da ognuno - elasticamente - a se stesso, se si desidera vivere bene. Come se Émile fosse un doppio di Rousseau e di ogni persona che legge il libro." - Enzo Fileno Carabba (Firenze, 1966) ha vinto il Premio Calvino con il romanzo Jakob Pesciolini (1990). Tra gli ultimi romanzi che ha pubblicato ricordiamo Pessimi segnali (2004).
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Émile o dell'educazione di Jean-Jacques Rousseau in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788817023306eBook ISBN
9788858656525LIBRO QUARTO
Come passiamo rapidamente su questa terra! Il primo quarto della vita è già trascorso prima che se ne conosca l’uso; l’ultimo quarto continua a trascorrere dopo che uno ha smesso di goderselo. Prima non si sa vivere, poi non si può più, e nell’intervallo che separa questi due inutili estremi, i tre quarti del tempo che ci resta son consumati dal sonno, dal lavoro, dal dolore, dalla costrizione, da fatiche di ogni tipo. La vita è breve non tanto perché dura poco, ma in quanto noi quasi non abbiamo tempo per gustarla. Il momento della morte può anche essere lontano da quello della nascita, ma la vita resta sempre troppo breve se quest’arco di tempo è mal riempito.
Noi nasciamo per così dire due volte, una volta per esistere, l’altra per vivere, una volta per la specie, l’altra per il sesso. Sbaglia certo chi considera la donna un uomo imperfetto, ma ha dalla sua l’analogia esteriore. Fino all’età da marito, i figli dei due sessi apparentemente non hanno nulla che li distingua: stesso viso, stessa figura, stesso colorito, stessa voce, tutto è uguale tra loro. Le femmine sono bambini, i maschi sono bambini. Per esseri tanto simili basta lo stesso nome. I maschi ai quali viene impedito l’ulteriore sviluppo del sesso conservano questa forma per tutta la loro vita. Continuano a essere dei bambini grandi. E le femmine che non perdono questa stessa forma, per molti aspetti, sembrano non essere mai altra cosa.
Ma l’uomo, in generale, non è fatto per rimanere sempre nell’infanzia. Ne esce all’epoca stabilita dalla natura: un momento di crisi che, sebbene assai breve, ha un’influenza duratura.
Come il muggito del mare precede la tempesta da lontano, questa burrascosa rivoluzione si annuncia col mormorio delle passioni nascenti: un sordo fermento avverte dell’approssimarsi del pericolo. Un cambiamento d’umore, frequenti accessi di collera, una continua agitazione dello spirito rendono quasi indisciplinabile il bambino, che diventa sordo alla voce che lo faceva diventare docile. È un leone preso dalla febbre; non riconosce la sua guida, non vuole più essere governato.
Ai segni morali di un umore che cambia si uniscono sensibili cambiamenti d’aspetto. La sua fisionomia si sviluppa assumendo l’impronta di un carattere: la tenera e rada lanugine che ricopriva le guance diventa più scura e prende consistenza. La sua voce cambia, anzi la perde: non essendo più un bambino e non essendo ancora un uomo, egli non riesce a prendere il tono di nessuno dei due. Gli occhi, questi organi dell’animo che finora non hanno mai parlato, trovano un linguaggio e un’espressione; un fuoco nascente li anima, i loro sguardi più vivi conservano ancora una pia innocenza, ma non hanno più l’ingenuità primitiva. Egli sente già che possono dire fin troppo, comincia a saperli abbassare e ad arrossire, diventa sensibile prima ancora di sapere cosa sente, è inquieto senza alcuna ragione di esserlo. Tutto ciò può avvenire lentamente e lasciarvi ancora del tempo; se però la vivacità si fa troppo impaziente, se il suo impeto si trasforma in furore, se si irrita e un attimo dopo si intenerisce, se versa lacrime senza motivo, se accanto a oggetti che cominciano a essere pericolosi per lui il cuore gli batte più forte e il suo sguardo prende fuoco, se la mano di una donna che si posa sulla sua lo fa fremere, e vicino a lei egli è turbato o intimidito, allora, Ulisse, saggio Ulisse, sta attento a te: gli otri che avevi chiuso tanto accuratamente si sono aperti, i venti si sono già scatenati. Non lasciare più il timone un solo istante o tutto è perduto.
È a questo punto che avviene la seconda nascita di cui ho parlato: adesso l’uomo nasce davvero alla vita e nulla di umano gli è estraneo. Fin qui le nostre cure sono state dei giochi da bambini, solo ora assumono davvero importanza. Quest’età in cui finisce l’educazione comune è proprio quella in cui deve cominciare la nostra. Ma per esporre bene questo nuovo progetto, risaliamo allo stato di cose che lo riguardano.
Le passioni sono i principali strumenti della nostra conservazione. Volerle distruggere è dunque impresa tanto vana, quanto ridicola, perché equivale a controllare la natura, a riformare l’opera di Dio. Se Dio dicesse all’uomo di annientare le passioni che egli stesso gli ha dato, Dio vorrebbe e non vorrebbe, contraddirebbe se stesso. Mai ha dato ordine tanto insensato; nulla di simile è scritto nel cuore umano, e ciò che Dio vuole che faccia un uomo non glielo fa dire da un altro, glielo dice egli stesso, glielo scrive in fondo al cuore.
Chi volesse impedire alle passioni di nascere, per me sarebbe folle quasi quanto chi volesse annientarle e, sicuramente, chi credesse che tale sinora è stato il mio progetto mi avrebbe completamente frainteso.
Ma se dall’idea secondo la quale avere delle passioni è proprio nella natura dell’uomo, si arrivasse a concludere che ogni passione che proviamo in noi e vediamo negli altri è naturale, si ragionerebbe forse meglio? La fonte delle passioni è naturale, è vero; ma viene ingrossata da mille rivoli estranei; è un gran fiume che aumenta senza posa e in cui si riuscirebbe a malapena a trovare qualche goccia delle acque originarie. Le nostre passioni naturali sono assai limitate: sono gli strumenti della nostra libertà, tendono a conservarci. Tutte quelle che ci soggiogano e ci distruggono ci vengono da altrove: non è la natura che ce le dà, noi, anzi, ce ne impossessiamo a suo danno.
La fonte delle nostre passioni, l’origine e il principio di tutte le altre, la sola passione che nasce insieme all’uomo e finché vive non l’abbandona mai, è l’amore di sé: passione innata, primitiva, anteriore a tutte le altre che in un certo senso sono solo delle sue modificazioni, e perciò, se vogliamo, sono tutte naturali. La maggior parte di tali modificazioni però ha cause esterne, senza le quali esse non sarebbero mai venute alla luce, e queste stesse modificazioni, lungi dall’essere vantaggiose, per noi sono dannose, perché cambiano l’oggetto primitivo e vanno contro il loro principio. L’uomo a quel punto si trova fuori dalla natura ed entra in contraddizione con se stesso.
L’amore di sé è sempre buono, e sempre conforme all’ordine naturale. Dal momento che ciascuno di noi è specialmente responsabile della propria conservazione, la sua prima e più importante occupazione deve essere quella di vegliarvi senza sosta. E come potrebbe vegliarvi se essa non lo interessasse al massimo grado?
Quindi per conservarsi bisogna amarsi, bisogna amarsi più di ogni altra cosa; e, per una conseguenza immediata dello stesso sentimento, noi amiamo ciò che permette di conservarci. Tutti i bambini sono attaccati alla loro nutrice. Romolo aveva finito per attaccarsi alla lupa che l’aveva allattato. All’inizio è un attaccamento meccanico. Un individuo è attratto da ciò che favorisce il suo benessere, ed è respinto da ciò che lo danneggia. È un puro istinto. Ciò che trasforma quest’istinto in sentimento e cambia l’attaccamento in amore, l’avversione in odio, è l’intenzione manifesta di nuocerci o di esserci utili. Gli esseri insensibili che seguono soltanto l’impulso ricevuto non ci appassionano, mentre le persone dalle quali, per la loro disposizione interiore o per la loro volontà, ci aspettiamo del bene o del male, quelle persone che noi vediamo agire liberamente pro o contro, ci ispirano sentimenti simili a quelli che mostrano verso di noi. Cerchiamo ciò che ci serve, ma ciò che ci vuole servire lo amiamo; evitiamo ciò che ci nuoce, ma ciò che ci vuole nuocere lo odiamo.
Il primo sentimento di un bambino è amare se stesso, e il secondo, che nasce dal primo, è amare chi gli sta vicino, perché nello stato di debolezza in cui si trova riconosce le persone soltanto per l’assistenza e la cura che da loro riceve. All’inizio, l’attaccamento che prova per la nutrice o per la governante è solo abitudine. Le va a cercare perché ha bisogno di loro ed è contento di averle. È più conoscenza, che benevolenza. Gli ci vuole molto tempo per capire che esse non solo gli sono utili, ma vogliono anche esserlo, ed è a quel punto che comincia ad amarle.
Un bambino, quindi, è naturalmente incline alla benevolenza, perché vede che tutte le persone che gli si avvicinano sono portate ad assisterlo, e da quest’osservazione deriva l’abitudine di un sentimento favorevole alla specie umana. Man mano che allarga le sue relazioni, i suoi bisogni, le sue dipendenze attive o passive, nasce il sentimento dei suoi rapporti con gli altri e suscita quello dei doveri e delle preferenze. A quel punto il bambino diventa imperioso, geloso, ingannatore, vendicativo. Se lo si piega all’obbedienza, siccome non capisce l’utilità di ciò che gli si ordina, l’attribuisce al capriccio, all’intenzione di tormentarlo e si ribella. Se è a lui che si obbedisce, appena qualcosa gli resiste egli vi vede una rivolta, o un’intenzione di opporgli resistenza e finisce per battere la sedia o il tavolo che gli hanno disobbedito. L’amore di sé, che guarda soltanto a noi, è soddisfatto quando i nostri bisogni reali sono soddisfatti, invece l’amor proprio, che fa paragoni, non è mai soddisfatto, né potrebbe esserlo, perché è un sentimento che preferendoci agli altri pretende anche che gli altri ci preferiscano a loro stessi, il che è impossibile. È per questo che le passioni tenere e affettuose nascono dall’amore di sé, e quelle odiose e irascibili nascono dall’amor proprio. Sicché, ciò che rende l’uomo sostanzialmente buono è aver pochi bisogni e paragonarsi poco agli altri, mentre ciò che lo rende sostanzialmente cattivo è averne molti e tenere molto all’opinione. In base a questo principio è facile vedere come tutte le passioni dei bambini e degli uomini possono venire dirette verso il bene o il male. È vero che, non potendo vivere sempre da soli, difficilmente vivranno sempre da uomini buoni; è una difficoltà destinata ad aumentare proprio con le loro relazioni ed è in questo soprattutto che i pericoli della società rendono per noi più indispensabili l’abilità e le cure necessarie per prevenire nel cuore umano la depravazione che nasce dai suoi nuovi bisogni.
Lo studio adatto all’uomo è quello dei rapporti umani. Fino a quando egli si riconosce solo come essere fisico, si deve studiare attraverso i suoi rapporti con le cose, ed è l’occupazione dell’infanzia. Quando comincia a sentire il suo essere morale, si deve studiare attraverso i suoi rapporti con gli uomini, ed è l’occupazione di tutta la vita, a cominciare dal punto in cui siamo arrivati.
Appena l’uomo sente il bisogno di una compagna non è più un essere isolato; il suo cuore non è più solo. Tutte le sue relazioni con la specie umana, tutte le affezioni dell’animo nascono insieme a questo sentimento. Ben presto la sua prima passione fa fermentare tutte le altre.
L’inclinazione dell’istinto è indeterminata. Un sesso è attratto dall’altro: ecco il movimento della natura. La scelta, le preferenze, l’attaccamento personale sono opera dei lumi, dei pregiudizi, dell’abitudine. Ci vuole tempo ed esperienza per renderci capaci di amore: si ama solo dopo aver giudicato; si preferisce solo dopo aver paragonato. Sono giudizi che si danno senza rendersene conto, eppure sono giudizi reali. Il vero amore, checché se ne dica, verrà sempre venerato dagli uomini: in effetti, benché sconvolti dai suoi furori, benché l’amore non escluda qualità odiose nel cuore che lo prova, anzi addirittura ne produca, esso comunque ne presuppone sempre altre degne di stima, senza le quali nessuno sarebbe in grado di provarlo. Questa scelta che si mette in opposizione con la ragione proviene proprio dalla ragione: abbiamo descritto l’amore come cieco perché ha occhi migliori dei nostri, e vede rapporti che noi non possiamo percepire. Per chi non avesse idea del merito o della bellezza, una donna varrebbe l’altra e la prima venuta sarebbe sempre la più amabile. Lungi dal derivare dalla natura l’amore è la regola e il freno alle sue inclinazioni: è grazie a esso, infatti, che al di fuori dell’oggetto amato un sesso non è più nulla per l’altro.
La preferenza che si accorda la si vuole anche ottenere: l’amore deve essere reciproco. Per essere amati bisogna rendersi amabili. Per essere preferiti bisogna rendersi più amabili di un altro, di chiunque altro, almeno agli occhi dell’oggetto amato. Da qui, i primi sguardi sui propri simili; da qui, i primi paragoni con loro; da qui, l’emulazione, la rivalità, la gelosia. Un cuore pieno di sentimento traboccante ama aprirsi: dal bisogno di un’amante nasce subito quello di un amico. Chi sente quanto è dolce essere amato vorrebbe esserlo da tutti, e nessuno riuscirebbe a preferire qualcuno a un altro senza scontentarne molti. Con l’amore e l’amicizia nascono i dissensi, l’inimicizia, l’odio. In seno a tante diverse passioni vedo l’opinione innalzarsi su un trono incrollabile e gli sciocchi mortali, asserviti al suo dominio, fondare la loro esistenza soltanto sui giudizi degli altri.
Estendete queste idee e capirete da dove viene la forma del nostro amor proprio che crediamo naturale; e capirete come l’amore di sé, cessando di essere un sentimento assoluto, diventi orgoglio negli animi grandi e vanità in quelli meschini, e in tutti gli animi si nutra di continuo a spese del prossimo. Nel cuore dei bambini non vi è il germe di questa specie di passioni, e perciò non vi può nascere da sola. Siamo noi che la piantiamo, ed è solo per colpa nostra che essa vi mette radice. Ma nel cuore del giovane non è più la stessa cosa: qualunque cosa facciamo, queste passioni vi nasceranno nostro malgrado. È tempo dunque di cambiare metodo.
Cominciamo con qualche importante riflessione sulla situazione critica di cui adesso ci occupiamo. Il passaggio dall’infanzia alla pubertà non è così determinato dalla natura da non variare negli individui a seconda del temperamento, e nei popoli a seconda del clima. Tutti conoscono le distinzioni rilevate su questo punto tra i paesi caldi e i paesi freddi, e ognuno sa che i temperamenti focosi si formano prima degli altri. Ma ci si può sbagliare sulle cause e attribuire spesso al fisico ciò che invece va imputato al morale. È questo uno degli errori più frequenti della filosofia del nostro secolo. Le istruzioni della natura sono lente e tardive, quelle degli uomini sono quasi sempre premature. Nel primo caso i sensi risvegliano l’immaginazione; nel secondo l’immaginazione risveglia i sensi, dando loro un’attività precoce che finisce per snervare e indebolire dapprima gli individui, e alla lunga la stessa specie. Un’osservazione più generale e sicura di quanto non sia quella sull’influenza dei climi, è che la pubertà e la potenza sessuale son sempre più precoci tra i popoli istruiti e civilizzati che tra quelli barbari e ignoranti.* I bambini possiedono una singolare sagacia per individuare attraverso tutti i vezzi della decenza le cattive abitudini che essa nasconde. Il linguaggio epurato che viene loro dettato, le lezioni di onestà che vengono loro impartite, il velo di mistero che si finge di stendere davanti ai loro sguardi sono altrettanti pungoli alla loro curiosità. Dal modo in cui ci si dà da fare, appare chiaro che si finge di nascondere qualcosa soltanto per insegnargliela, e di tutte le istruzioni che ricevono è certo quella su di loro agisce di più.
Consultate l’esperienza, capirete sino a che punto questo metodo insensato acceleri l’opera della natura e rovini il carattere. È questa una delle cause principali della degenerazione delle razze nelle città. I giovani, esauriti sin da piccoli, restano gracili, deboli, mal sviluppati, invece di crescere invecchiano, come la vigna che langue e muore prima dell’autunno, perché ha dovuto portare tutti i frutti in primavera.
Bisogna aver vissuto in mezzo a popoli semplici e rozzi, per sapere fino a quale età l’innocenza dei bambini può prolungarsi in una felice ignoranza. È uno spettacolo commovente e che fa sorridere e al tempo stesso vedere i due sessi che si abbandonano alla certezza dei loro cuori e prolungano nel fiore degli anni e della bellezza gli ingenui giochi infantili, mostrando con la loro stessa familiarità la purezza dei loro divertimenti. Alla fine, quando quest’amabile giovinezza arriva al matrimonio, i due sposi, dandosi reciprocamente la primizia delle loro persone, finiscono per essere più cari l’uno all’altra. Molti bei bambini sani e robusti diventano il pegno di un’unione che nulla può alterare e il frutto della saggezza dei loro verdi anni.
Se l’età in cui l’uomo prende coscienza del suo sesso cambia sia per effetto dell’educazione che per opera della natura, vuol dire che essa può venir accelerata o ritardata, a seconda del modo in cui si allevano i bambini; e se il corpo prende oppure perde consistenza, a seconda che si ritardi o che si acceleri questo sviluppo, vuol dire che più ci si dà da fare per ritardarlo, maggiore sarà la forza e il vigore che un giovane prenderà. Parlo ancora soltanto degli effetti puramente fisici: presto vedremo che non si limitano a questo.
Da queste riflessioni traggo la soluzione della questione tanto spesso discussa, se cioè convenga dare spiegazioni ai bambini sin da quando sono piccoli sugli oggetti della loro curiosità, oppure se è meglio imbrogliarli con errori modesti. Io ritengo che non si debba fare né l’una, né l’altra cosa. Innanzitutto questa curiosità non nasce mai senza essere stata indotta. Perciò bisogna per prima cosa fare in modo che ciò non avvenga. In secondo luogo, le domande cui nessuno è obbligato a rispondere, non implicano affatto che chi le pone venga imbrogliato. Piuttosto che risponder loro mentendo, è meglio imporre il silenzio. Non saranno molto sorpresi da questa legge, se si avrà avuto cura di fargliela rispettare in cose senza importanza. Alla fine, se si decide di rispondere, lo si faccia con la maggiore semplicità, senza misteri, senza imbarazzo, senza sorrisetti. Si rischia molto meno a soddisfare la curiosità di un bambino che a eccitarla.
Le vostre risposte siano sempre serie, brevi, decise, senza esitazioni. Non ho bisogno d’aggiungere che devono essere anche vere. Non si può insegnare ai bambini il pericolo di mentire agli adulti, se gli adulti non avvertono il pericolo, ben maggiore, di mentire ai bambini. Una sola menzogna del maestro scoperta dall’allievo rovinerebbe per sempre tutti i frutti dell’educazione.
Su certe materie, un’ignoranza assoluta forse è preferibile per i bambini: ma imparino sin da piccoli ciò che non si può tenere loro sempre nascosto. La loro curiosità o non deve essere eccitata in alcun modo, oppure bisogna che venga soddisfatta prima dell’età in cui diventa pericolosa. Il vostro comportamento verso il vostro allievo in questo dipende molto dalla sua situazione particolare, dalla compagnia che lo circonda, dalle circostanze in cui si prevede che possa trovarsi, etc. Quello che conta di più è di non lasciare nulla al caso. Se non siete sicuri di fargli ignorare sino ai sedici anni la differenza tra i sessi, abbiate cura che l’apprenda prima dei dieci.
Non amo affatto che si finga davanti ai bambini un linguaggio troppo epurato o si facciano lunghe circonlocuzioni, di cui essi si rendono perfettamente conto, per evitare di dare alle cose il loro vero nome. Le buone abitudini in questo campo sono sempre molto semplici; ma immaginazioni macchiate dal vizio rendono l’orecchio delicato e spingono continuamente ad affinare le espressioni. I termini rozzi sono senza conseguenze; sono le idee lascive che vanno tenute lontano.
Benché il pudore sia naturale nella specie umana, i bambini naturalmente non ne hanno affatto. Il pudore infatti nasce solo con la conoscenza del male, conoscenza che i bambini non hanno e non devono avere. Allora come potrebbero avere il sentimento che ne è l’effetto? Dare ai bambini lezioni di pudore e onestà significa insegnare che ci sono cose vergognose e disoneste, e trasmettere un segreto desiderio di conoscerle. Presto o tardi riusciranno e la prima scintilla che tocca l’immaginazione accelera d’improvviso l’avvampare dei sensi. Chi arrossisce è già colpevole. La vera innocenza non si vergogna di nulla.
I bambini non hanno gli stessi desideri degli uomini, ma come loro soggetti alla sconcezza che ferisce i sensi, possono ricevere per questo semplice fatto le stesse lezioni di decenza. Seguite lo spirito della natura che, mettendo nello stesso posto gli organi dei piaceri segreti e quelli dei bisogni disgustosi, ci ispira, in età diverse, la stessa attenzione con un’idea o con un’altra: con la modestia, all’uomo, e con la pulizia, al bambino.
Vedo solo un buon modo per conservare l’innocenza dei bambini, è farla rispettare e amare da tutti coloro che li circondano. Altrimenti, ogni ritegno che si cerca di usare verso di loro prima o poi verrà smentito: un sorriso, una strizzatina d’occhio, un gesto di sfuggita, dicono tutto ciò che si è cercato di tacere. Per capirlo, ai bambini basta vedere che glielo si è voluto nascondere. La delicatezza di tono e d’espressione che le persone educate adoperano tra di loro, immaginando che i bambini abbiano un’intelligenza che non devono avere affatto, con loro è del tutto fuori luogo. Ma se davvero si venera la loro semplicità, parlando con loro si usa facilmente quella semplicità di termini che è adatta ai bambini. C’è una certa ingenuità di linguaggio che si addice e piace all’innocenza. È questo il vero tono che distoglie un bambino da una pericolosa curiosità. Parlandogli in modo semplice di ogni cosa, non gli si fa immaginare che restano ancora altre cose da sapere. Associando alle parole volgari le idee spiacevoli a esse appropriate, si spegne il primo fuoco dell’immaginazione: non gli si proibisce di pronunciare queste parole o di ...
Indice dei contenuti
- ÉMILE O DELL’EDUCAZIONE
- Copyright
- Émile, Gavroche, Tarzan di Michel Tournier
- Cronologia della vita e delle opere
- Bibliografia essenziale
- ÉMILE O DELL’EDUCAZIONE
- Prefazione
- Libro Primo
- Libro Secondo
- Libro Terzo
- Libro Quarto
- Libro Quinto
- Sommario