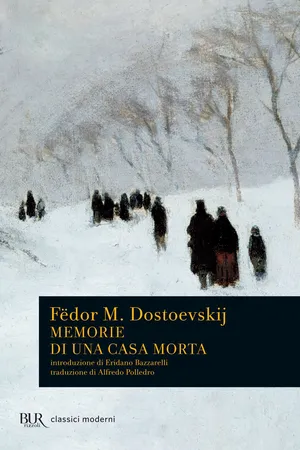![]()
PARTE SECONDA
dp n="274" folio="232" ? dp n="275" folio="233" ? ![]()
I
L’INFERMERIA
Poco dopo le feste io mi ammalai e andai alla nostra infermeria militare. Essa si trovava isolata, a mezza versta dalla fortezza. Era un lungo edificio a un piano solo, dipinto di giallo. D’estate, quando avvenivano i lavori di restauro, ci voleva per essa una straordinaria quantità di ocra. Nell’immenso cortile dell’infermeria avevano trovato posto i servizi, le case della direzione sanitaria e altre costruzioni attinenti. Nel corpo principale invece erano disposte solo corsie. Le corsie erano molte, ma quelle dei detenuti due sole, sempre affollatissime, specialmente d’estate, tanto che occorreva spesso accostare i letti. Le nostre corsie si riempivano di ogni sorta di «gente disgraziata». Ci andavano i nostri, ci andavano dei giudicabili militari di vario genere, tenuti in diversi corpi di guardia, condannati, non condannati e deportati a tappe; ci andavano anche dalla compagnia di disciplina: una strana istituzione, dove si spedivano i giovani soldati colpevoli di mancanze e poco fidati, per correggerne la condotta, e di dove, dopo un paio d’anni o più, essi uscivano di solito tali furfanti come di rado se ne incontrano. Da noi i detenuti che cadevano malati denunciavano il loro male, abitualmente al mattino, al sottufficiale. Venivano subito iscritti in un registro e con questo registro inviati sotto la scorta di un soldato al lazzaretto del battaglione. Là un dottore visitava preventivamente tutti i malati dei vari comandi militari distribuiti nella fortezza e mandava all’infermeria quelli che trovava realmente malati. Mi si annotò nel registro e dopo l’una, quando già tutti i nostri si erano avviati dal reclusorio al lavoro pomeridiano, io andai all’infermeria. Il detenuto malato di solito prendeva con sé quanto più poteva di denaro e di pane, perché per quel giorno all’infermeria non poteva aspettarsi alcuna razione, e inoltre la minuscola pipa con la borsa del tabacco, la pietra focaia e l’esca. Questi ultimi oggetti li nascondeva con cura negli stivali. Io entrai nel recinto dell’infermeria non senza una certa curiosità per questa nuova, e a me ancora ignota, variazione del nostro trantran carcerario.
La giornata era tiepida, nuvolosa e triste: una di quelle giornate in cui i luoghi come l’infermeria assumono un aspetto particolarmente indaffarato, uggioso e arcigno. Io e il soldato di scorta entrammo nella sala di visita, dove c’erano due vasche di rame e dove già attendevano due malati, di quelli sotto processo, anch’essi con la scorta. Entrò l’aiuto medico, che ci squadrò pigramente e con aria d’autorità e poi ancora più pigramente andò a riferire al medico di turno. Questi comparve ben presto; ci visitò, ci trattò molto affabilmente e ci consegnò le «cartelle di osservazione», in cui erano stati segnati i nostri nomi. Una più precisa annotazione della malattia, la prescrizione delle medicine, della dieta eccetera, erano riservate a quello degli ordinari che sovrintendeva alle corsie dei detenuti. Già prima avevo sentito che i detenuti non si stancavano di lodare i loro medici. «Non c’è bisogno di padre!»,1 avevano risposto alle mie domande, quando mi avviavo all’infermeria. Intanto ci cambiammo. Il vestito e la biancheria con cui eravamo venuti ci furono tolti e ci si fece indossare la biancheria dell’infermeria, e inoltre ci diedero delle calze lunghe, delle pantofole, delle berrette da notte e delle gabbanelle di panno spesso, di color bruno, foderate non so se di tela o di una specie di taffetà. In una parola, la gabbanella era sudicia all’estremo, ma io l’apprezzai pienamente solo sul posto. Poi ci condussero nelle corsie dei detenuti, che erano disposte in fondo a un lunghissimo corridoio alto e pulito. La pulizia esteriore era dappertutto soddisfacentissima; tutto ciò che alla prima balzava agli occhi luccicava addirittura. Del resto poteva parermi che fosse così dopo la vita nel nostro reclusorio. I due giudicabili andarono in una corsia a sinistra, io a destra. Presso la porta, chiusa con un chiavistello di ferro, stava una sentinella col fucile, accanto a lui il suo supplente. Il sottufficiale più giovane (del picchetto dell’infermeria) ordinò di farmi passare e io mi trovai in una stanza lunga e stretta, contro le cui due pareti longitudinali stavano i lettucci, in numero di forse ventidue, dei quali tre o quattro non ancora occupati. I letti erano di legno, dipinti di verde, anche troppo noti a tutti quanti nella nostra Russia: quei medesimi letti che, per non so qual predestinazione, non possono assolutamente essere immuni da cimici. Io presi posto in un angolo, dalla parte delle finestre.
Come ho già detto, qui c’erano anche i nostri detenuti del reclusorio. Alcuni di loro già mi conoscevano o, almeno, mi avevano veduto in precedenza. Molti di più erano i giudicabili e quelli della compagnia di disciplina. Di malati gravi, che cioè non si alzassero dal letto, non ce n’erano tanti. Gli altri, malati leggieri o convalescenti, erano seduti sulle brande o camminavano avanti e indietro per la stanza, dove, tra le due file di letti, rimaneva ancora uno spazio sufficiente per passeggiarci. Nella corsia c’era un odore oltremodo soffocante di ospedale. L’aria era viziata da varie sgradevoli esalazioni e dall’odore delle medicine, nonostante che per quasi tutto il giorno fosse accesa, in un angolo, la stufa. Sulla mia branda era distesa una sopraccoperta a righe. Io la tolsi via. Sotto di essa trovai una coperta di panno, foderata di tela, e della biancheria pesante di più che dubbia pulitezza. Accanto alla branda stava un tavolino su cui c’erano un tazzone e una ciotola di stagno. Tutto ciò si copriva, per la bella figura, con un piccolo asciugamano che mi era stato consegnato. Nella parte inferiore del tavolino c’era un altro palchetto: là quelli che bevevano il tè tenevano la teiera, il bricco del kvas ecc.; ma che bevessero il tè anche fra i malati ce n’eran pochissimi. Le pipe poi e le borse del tabacco, che quasi tutti avevano, non esclusi nemmeno i tisici, si nascondevano sotto le brande. Il dottore e gli altri superiori non le ispezionavano quasi mai, e anche se sorprendevano qualcuno con la pipa, facevano finta di non accorgersene. Del resto anche i malati erano quasi sempre guardinghi e andavano a fumare vicino alla stufa. Forse soltanto di notte fumavano in letto; ma di notte nessuno girava per le corsie, salvo qualche volta l’ufficiale comandante il picchetto dell’infermeria.
Fino a quel giorno non ero mai stato ricoverato in un ospedale; perciò quanto mi circondava era per me assolutamente nuovo. Notai che suscitavo una certa curiosità. Di me avevano già sentito parlare e mi squadravano senza alcuna cerimonia, anzi con una certa sfumatura di superiorità, come nelle scuole si squadra il novellino o nei pubblici uffici il postulante. Alla mia destra giaceva uno scrivano sotto giudizio, figlio illegittimo di un capitano a riposo. Era processato come falso monetario ed era lì già da un anno, non malato affatto, a quanto pareva, ma assicurava ai dottori di avere un aneurisma. Ed egli ottenne lo scopo: i lavori forzati e la punizione corporale lo risparmiarono ed egli, ancora un anno dipoi, fu trasferito a T-k, per esservi tenuto non so dove, addetto a un ospedale. Era un giovanotto robusto e tarchiato sui ventott’anni, un gran briccone, pratico delle leggi, niente affatto sciocco, oltremodo disinvolto e presuntuoso, pieno di un amor proprio morboso, che con la massima serietà voleva persuadere se stesso di essere l’uomo più onesto e più giusto del mondo, e perfino di non avere alcuna colpa, e che con questa persuasione rimase poi sempre. Per primo egli attaccò discorso con me, si mise a interrogarmi con curiosità e mi informò abbastanza minutamente del regolamento dell’infermeria. Prima di tutto, s’intende, mi dichiarò che era figlio di un capitano. Aveva una voglia straordinaria di passare per nobile o, almeno, «di buona famiglia». Subito dopo di lui mi si avvicinò un malato della compagnia di disciplina e cominciò ad assicurarmi che aveva conosciuto molti dei nobili deportati in precedenza designandoli con nome e patronimico. Era questo un soldato già grigio; sul viso gli stava scritto che s’inventava tutto ciò. Si chiamava Čekunov. Evidentemente cercava di entrarmi in grazia, sospettandomi, credo, danaroso. Avendo notato che avevo un cartoccio di tè e di zucchero, subito mi offerse i suoi servigi: procurarmi una teiera e farmi il tè. La teiera aveva promesso di mandarmela per il giorno dopo M-tski, dal reclusorio, con qualcuno dei detenuti che venivano all’infermeria a lavorare. Ma Čekunov sbrigò ogni cosa. Trovò una specie di pentolino, perfino una tazza, fece bollir l’acqua, preparò il tè, insomma mi servì con uno zelo straordinario, provocando subito con ciò da parte di uno dei malati alcune velenose canzonature a suo riguardo. Questo malato era un tisico che giaceva di fronte a me, di cognome Ustjancev, un soldato sotto giudizio, quello stesso che, spaventatosi del castigo, aveva vuotato una mezzetta di acquavite, dopo averci messo in infusione molto tabacco, e con ciò si era buscato la tisi; di lui ho già fatto qualche cenno più sopra. Fino ad ora era rimasto coricato in silenzio, respirando a fatica, osservandomi fissamente con aria seria e seguendo con indignazione le mosse di Čekunov. La straordinaria, biliosa serietà conferiva alla sua indignazione una certa quale sfumatura particolarmente comica. Infine egli non resse più:
– Ve’, il servo! S’è trovato un padrone! – proferì staccando le sillabe e con voce ansimante per la debolezza. Egli era già agli ultimi giorni della sua vita.
Čekunov si voltò verso di lui sdegnato:
– Chi è il servo? – pronunciò guardando sprezzantemente Ustjancev.
– Sei tu il servo! – rispose l’altro con un tono di tanta sicurezza come se avesse pieno diritto di redarguire Čekunov, anzi gli fosse stato messo al fianco a tale scopo.
– Io servo?
– Proprio tu. Sentite, brava gente, non ci crede! Si meraviglia!
– Ma a te che importa! Ve’, il signore è solo, è come senza mani. Non è avvezzo a far senza aiuti, si sa. Perché non servirlo, diavolo di un grugno peloso che sei!
– Chi è un grugno peloso?
– Tu sei un grugno peloso.
– Io un grugno peloso!
– Proprio tu!
– E tu sei bello? Hai una faccia che sembra un uovo di cornacchia... se io sono un grugno peloso.
– Proprio un grugno peloso! Una volta che Dio ti ha colpito, dovresti startene lì a morire! No, vuol ficcare il suo naso! Su via, perché ficchi il tuo naso?
– Perché? Proprio no, piuttosto m’inchinerò a uno stivale, ma non a uno scarpone. Mio padre non ci s’inchinava e anche a me lo proibiva. Io... io...
Voleva già continuare, ma si mise a tossire terribilmente per alcuni minuti sputando sangue. Ben presto il sudor freddo dell’estenuazione spuntò sulla sua fronte stretta. La tosse gliel’impediva, se no avrebbe parlato sempre; dai suoi occhi si vedeva che aveva voglia di ingiuriare ancora; ma, impotente, agitava soltanto la mano... Cosicché Čekunov alla fine si dimenticò di lui.
Io avevo sentito che la rabbia del tisico era diretta piuttosto contro di me che contro Čekunov. Per il desiderio di Čekunov di farmi dei servigi, e di procacciarsi con ciò una copeca, nessuno se la sarebbe presa con lui o lo avrebbe guardato con particolare disprezzo. Ognuno capiva che egli così faceva semplicemente per interesse. A questo proposito il popolino non è affatto così schizzinoso e sa distinguere con finezza di che si tratti. A Ustjancev non ero andato a genio io personalmente, non gli era andato a genio il mio tè e che io, anche incatenato, mi comportassi come un signore, come se non potessi far a meno di un servitore, pur non avendone chiamato né desiderato alcuno. In realtà, io ho sempre voluto far tutto da me, anzi ho sempre avuto il vivo desiderio di nemmeno aver l’aria di essere uno scansafatiche, un delicatino, e di voler fare il signore. In questo consisteva perfino in parte il mio amor proprio, poiché la cosa è venuta in discorso. Ma ecco – e io non capisco proprio come sia sempre accaduto così – non ho mai potuto rinunciare a una quantità di persone compiacenti e servizievoli che da sé mi si appiccicavano e finivano coll’impossessarsi totalmente di me, tanto che esse erano poi veramente i miei padroni e io il loro servo; ma in apparenza ne veniva, in certo qual modo di per sé, che io ero un vero signore, facevo il signore e non potevo far senza servitori. Questo naturalmente mi seccava assai. Ma Ustjancev era un tisico, una persona irritabile. Gli altri malati invece conservavano un aspetto indifferente, perfino con una sfumatura di alterigia. Mi ricordo che tutti si interessavano di una speciale circostanza: dai discorsi dei detenuti avevo appreso che quella sera stessa avrebbero condotto da noi un giudicabile che in quel momento si stava punendo con le verghe. I detenuti attendevano il novizio con una certa curiosità. Dicevano del resto che la punizione sarebbe stata leggiera: solo cinquecento colpi in tutto.
A poco a poco io mi guardai intorno. Per quanto potei notare, c’eran lì soprattutto dei malati di scorbuto e di oftalmia: malattie locali di quella regione. Di questi ce n’erano nella corsia parecchi. Fra gli altri, realmente malati, si trovavano dei ricoverati per febbri, varie specie di piaghe, mali di petto. Lì non era come nelle altre corsie, lì erano riunite in un mucchio tutte le malattie, perfino veneree. Ho detto «realmente» malati, perché ce n’erano anche parecchi venuti così, senza malattia alcuna, a «riposare». I dottori ammettevano costoro volentieri per compassione, specialmente quando c’erano molti letti liberi. La detenzione nei corpi di guardia e nel reclusorio pareva così dura, in confronto di quella all’infermeria, che molti detenuti venivano con piacere a mettersi in un letto, nonostante l’aria viziata e la chiusura a catenaccio della corsia. C’eran perfino di quelli a cui piaceva in modo speciale lo star coricati e, in generale, il trantran dell’infermeria; soprattutto, del resto, individui della compagnia di disciplina. Io osservavo con curiosità i miei nuovi compagni, ma ricordo che una particolare curiosità destò allora in me uno del nostro reclusorio, che già era moribondo, anche lui tisico e anche lui ai suoi ultimi giorni, che giaceva nel secondo letto dopo Ustjancev e che quindi era pure quasi di fronte a me. Si chiamava Michajlov; ancora due settimane prima lo avevo veduto nel carcere. Era malato già da un pezzo e da un pezzo avrebbe dovuto andare a farsi curare; ma egli, con una sorta di caparbia e affatto inutile sopportazione, si dominava, si faceva forza e soltanto durante le feste era venuto all’infermeria, per morirci, in tre settimane di una forma spaventosa di tisi: come arso dal fuoco. Mi fece ora impressione il suo viso terribilmente mutato, un viso che avevo notato tra i primi dopo il mio ingresso nel reclusorio; mi era allora come balzato agli occhi. Accanto a lui giaceva un soldato della compagnia di disciplina, un uomo già vecchio, un tremendo e ripugnante sudicione... Ma del resto non posso enumerare tutti i malati... Mi sono ricordato ora anche di questo vecchiotto unicamente perché egli pure mi aveva fatto allora una certa impressione e in un momento mi aveva dato un’idea abbastanza completa di talune particolarità della corsia dei detenuti. Questo vecchierello aveva allora, mi ricordo, un fortissimo raffreddore. Non faceva che starnutire e per una intera settimana poi starnutì anche nel sonno, come a salve, a cinque o sei starnuti per volta, soggiungendo ogni volta regolarmente: «O Signore, che castigo m’è toccato!». In quel momento era seduto sul letto e con avidità si riempiva il naso di tabacco che prendeva da un cartoccio, per poter starnutire con più forza e più regolarità. Starnutiva in un fazzoletto di cotone, di sua proprietà, a quadretti, lavato cento volte e scolorito all’estremo, nel far che il suo piccolo naso pareva raggrinzirsi in modo speciale, formando minute, innumerevoli grinze, mentre si mettevano in mostra i frammenti dei vecchi denti anneriti, insieme con le rosse e bavose gengive. Finito di starnutire, subito svolgeva il fazzoletto, esaminava attentamente il muco che vi si era copiosamente raccolto e senz’altro se lo passava sulla scura gabbanella governativa, cosicché tutto il muco rimaneva su questa, e il fazzoletto restava appena umidiccio. Così egli fece per tutta una settimana. Questa meticolosa, avara cura del proprio fazzoletto a danno della gabbanella governativa non provocava alcuna protesta da parte dei malati, anche se a qualcuno di loro doveva poi toccare d’infilare quella stessa gabbanella. Ma il nostro popolino non è schizzinoso né schifiltoso, e ciò fino alla stranezza. Io invece mi sentii in quel momento addirittura sconvolto e cominciai subito involontariamente a esaminare con disgusto e curiosità la gabbanella che avevo poco prima indossato. A questo punto notai che essa già da un bel poco aveva destato la mia attenzione per il suo greve odore; già aveva avuto il tempo di riscaldarmisi addosso e mandava un puzzo sempre più forte di medicine, di impiastri e, come mi pareva, di non so qual putridume, il che non faceva meraviglia, dato che da tempo immemorabile non abbandonava le spalle dei malati. Forse la sua fodera di tela sul dorso era stata qualche volta lavata, ma di sicuro non lo so. In cambio questa fodera era presentemente imbevuta di ogni possibile sgradito umore, di fomente, di acqua scolata dai vescicanti incisi, e via dicendo. Inoltre nelle corsie dei detenuti ne comparivano molto spesso di quelli puniti con le verghe, col dorso tutto piagato; venivano curati con fomente, e perciò la gabbanella, ...