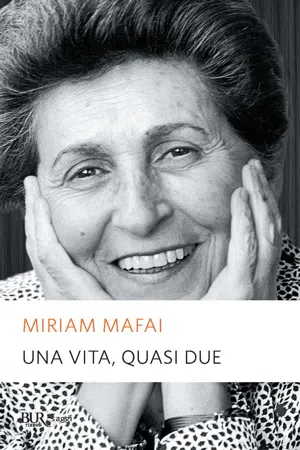![]()
1
La Parigi dei miei genitori
«Deve venire a Parigi chi vuole essere chiamato pittore… i francesi sono bravissimi a inglobare nella loro storia tutti quanti scelgono la città e vi risiedono…» Così Maurizio Fagiolo dell’Arco nella presentazione della mostra Les Italiens de Paris, la riscoperta di un gruppo di pittori assai più compatto e riconosciuto di quanto fino ad allora si pensasse.
Luogo di pellegrinaggio, Parigi fu in quegli anni, nel primo dopoguerra e lungo gli anni Venti e Trenta, ciò che poi divenne New York, non solo un crocevia di esperienze e di incontri, ma anche il possibile e forse necessario fonte battesimale del successo.
Mario Mafai e Antonietta Raphaël, quando vi giunsero, all’inizio del 1930, non ebbero questa fortuna. Di Parigi, che mia madre già conosceva per averci vissuto, sia pure per un breve periodo, prima di arrivare in Italia, e che mio padre conosceva e amava soltanto (ma non era poca cosa) attraverso la sua storia, la sua letteratura, la sua pittura, essi soffrivano soprattutto la durezza, che è uno dei contrassegni della metropoli.
Nel gennaio del 1930 mia madre aveva messo al mondo la terza delle sue figlie, Giulia. Dopo poche settimane, affidata la piccola alla balia e alla nonna, i due lasciarono Roma per Parigi.
«Ormai avevo deciso di partire,» scrive in alcuni suoi appunti mio padre «cedetti la casa, vendetti per pochi soldi ciò che avevo di mobilio, e prendemmo il treno Roma-Torino-Modane-Parigi. Non ero molto giovane, avevo ventotto anni. Parigi è distesa, avvolta in un’atmosfera brillante, chiara, vibrata di luce rosata, come di colore disciolto. Soltanto qui poteva nascere l’impressionismo…» L’avventura cominciava, ma non fu un’avventura felice.
I due si sistemarono prima in un alberghetto del centro, poi furono costretti a cercare qualcosa di più economico alla periferia di Montparnasse.
Non so se Mafai e la Raphaël abbiano tentato allora di entrare in contatto con gli artisti italiani che a Parigi avevano ottenuto già riconoscimenti e successi, come Giorgio De Chirico o Gino Severini. Negli appunti di mio padre non ne trovo traccia. E non ce n’era traccia nelle parole di mia madre quando ricordava quell’epoca con noi.
Nella loro memoria dunque Parigi resta come una città immersa nella luce del Nord e, in primavera, nel pulviscolo biancastro degli ippocastani, una città bellissima ma amara fino alla crudeltà.
Mio padre era disoccupato, mia madre guadagnava qualcosa disegnando ricami in un piccolo laboratorio di sartoria a Saint-Denis. Lui l’aspettava all’uscita, poi si avviavano a piedi risparmiando anche sul metrò, verso la Senna e Saint-Michel, risalendo Boulevard Raspail per raggiungere l’alberghetto dove il termosifone era quasi spento.
«Le strade, le strade lunghe, diritte, che vanno verso la Senna di sera diventano tristi, nude. I marciapiedi di Boulevard de Sébastopol sono sudici, qualcuno mangia ciò che ha raccolto per terra attorno alle Halles…»
È una vita da studenti poveri, al margine della disperazione. Mio padre, spulciando con attenzione i piccoli annunci sui giornali, troverà qualche lavoro, lo perderà, ne ritroverà un altro. Poi mia madre si ammala.
«Il cancello dell’ospedale si apriva alle 2.30. C’era una piccola folla che nell’attesa comperava banane. L’ospedale si aprì, io stringevo in mano le mie paste e correvo per entrare primo. Avevo paura di trovarla morta… Un giorno vorrei darle felicità. Adesso cominciavo a guadagnare e lei avrebbe potuto studiare e riposare un po’…»
Ma anche quel modesto lavoro su cui mio padre sperava evidentemente viene meno, o viene meno la speranza. E alla fine i due, stremati, tornano a Roma, dove ritrovano gli amici.
«Un gruppo di giovani letterati che non vivevano che per Rimbaud, Laforgue, Mallarmé, Valéry… Scipione se ne nutriva. Ma i miei quadri delusero. La mia pittura si era come diluita nell’atmosfera di Parigi, il museo si era depositato e agli impasti grassi e tenebrosi erano subentrati interessi di luce, una disposizione più impressionista…»
Alcuni di questi quadri «parigini» vennero esposti in quell’autunno assieme alle ultime tele di Scipione alla galleria di Roma.
«A un certo punto, non so come, sentii nostalgia dell’isolamento di Parigi e così ripassai la frontiera la seconda volta.»
Poco dopo la Raphaël proseguirà per Londra e Mafai rientra definitivamente a Roma.
Nel nostro lessico familiare, nella nostra memoria infantile, Parigi si sedimentò come una favola nella quale tutto si intreccia: la miseria e la bellezza, la sporcizia e la gloria, i clochards e i pittori, la disperazione e la felicità, la luce del Nord e lo scorrere della Senna. Mio padre e mia madre, che lì avevano conosciuto la miseria e la malattia, e che lì non trovarono gallerie e critici disponibili, ci trasmisero tuttavia la nostalgia e il desiderio di quella città, l’amore per la sua lingua, la sua storia, i suoi poeti.
Forse per questo ho deciso, moltissimi anni dopo, di scegliere Parigi come mia città di elezione. E sono andata ad abitare tra Saint-Denis e Boulevard de Sébastopol, dove una volta mio padre, infreddolito, aspettava la sera mia madre che lasciava il lavoro per avviarsi insieme verso il loro alberghetto miserabile.
![]()
2
Mio padre aveva un atlante
La guerra ha bussato molto presto alla mia porta. Era un giorno di maggio del 1936 e non sembrava una guerra, sembrava una festa. E in effetti era anche, forse, una festa. La radio, in classe, ci annunciava che il generale Badoglio, alla testa delle nostre truppe, era entrato a Addis Abeba. L’Abissinia era nostra. Era stato, ci raccontò emozionata la nostra insegnante, un ingresso trionfale, e un trionfo della civiltà sulla barbarie della schiavitù e dell’ignoranza. La lezione venne interrotta: la professoressa e le allieve si abbracciavano felici. Io restavo da una parte, isolata e avvilita. Mio padre mi aveva spiegato che quella guerra era ingiusta. E io credevo a mio padre più che alla mia insegnante. Così provai, per la prima volta, il senso doloroso della esclusione da un grande evento collettivo.
Il giorno dopo i romani, per festeggiare la nostra vittoria, si rovesciarono per le strade, riempirono le piazze di canzoni e di bandiere, orgogliosi e commossi. L’Italia aveva finalmente il suo impero, come l’Inghilterra, la Francia, i grandi Paesi europei. E con l’impero ci sarebbe stata buona terra, tanta terra da coltivare, per tutti, tante strade e tante case da costruire. Gli italiani non sarebbero stati più costretti a emigrare, ad attraversare, affamati e disperati, l’oceano per andare in America o in Argentina, come avevano fatto i loro padri e i loro nonni per trovare un lavoro. E in Abissinia non ci sarebbero stati più schiavi, come sotto il Negus. Gli italiani ne avrebbero fatto uomini liberi.
Furono giorni di emozione, di orgoglio, di festa, di speranza. La nostra insegnante era felice, le compagne di classe erano felici, tutti i romani erano felici. A noi, chiuse in casa, arrivava l’eco delle canzoni, degli entusiasmi, di un’allegria e di un orgoglio che non ci appartenevano.
La guerra d’Abissinia era cominciata il 2 ottobre del 1935. Dunque era durata pochi mesi, e aveva fatto pochi morti, almeno per quanto sapevamo. Migliaia e migliaia di italiani erano partiti per il fronte, cantando, come avevamo visto tutti sulla «Domenica del Corriere» o nei cinegiornali. E milioni di donne avevano offerto la loro fede perché l’Italia avesse l’oro necessario per combattere. La offrì anche la regina, la offrirono le vedove di guerra, la offrirono centinaia di madri prolifiche sfiancate dalle ripetute gravidanze. Milioni di donne, milioni di anelli d’oro regalati alla patria in cambio di un modesto simbolico anello d’acciaio. Ma tutte sembravano orgogliose di offrire il loro povero oro alla patria.
Mio padre e mia madre no. Mia madre fino alla fine portò al dito la bella fede che mio padre le aveva regalato il giorno del loro matrimonio (matrimonio che le era costato, come l’aveva messa in guardia il console, il suo prezioso passaporto inglese). E la fede di mio padre, morto nel 1965, è da allora al dito di mia sorella Giulia. I miei genitori, insomma, non diedero il loro anello alla patria.
Ma i miei genitori erano persone un po’ speciali.
Intanto facevano lavori speciali: lui dipingeva e lei dipingeva e scolpiva. (Era piuttosto imbarazzante dirlo, a scuola, quando l’insegnante facendo l’appello chiedeva a tutte le bambine cosa facessero il padre e la madre.)
Mia madre era un’ebrea lituana, fuggita da Kowno, l’attuale Kaunas, ai primi del secolo, anni funestati dai pogrom e dalla morte del padre rabbino. Con la madre e un paio dei suoi molti fratelli si trasferì prima in Bessarabia, poi da lì raggiunsero il resto della famiglia da tempo emigrata a Londra. Lì visse la guerra, studiò al Conservatorio, fece un po’ di teatro, frequentò i giovani intellettuali dell’epoca, conobbe Jacob Epstein, diventò cittadina inglese. Dopo la morte della madre colpita dalla epidemia di «spagnola», lasciò Londra, portando con sé il violino, la menorah, il vecchio mantello della madre, una rara edizione settecentesca delle Metamorfosi di Ovidio. Fece sosta a Parigi e a Nizza. Arrivò in Italia alla fine del 1924. Era bionda, con la carnagione rosata.
Mio padre era piccolo, bruno, con intensi occhi a mandorla e un colorito olivastro. Era nato a Roma, dove sua madre, di origine abruzzese, gestiva un piccolo albergo a piazza Indipendenza. Era stato uno studente distratto, poi si era scoperto un amore per la pittura e si era iscritto all’Accademia di Nudo di via Ripetta. Lì conobbe mia madre. Lui aveva ventidue anni. Lei era vicina ai trenta.
Avevano storie, culture, abitudini, religioni diverse. Lei aveva già attraversato mezza Europa, lui non era mai uscito da Roma. Lei parlava (male) una mezza dozzina di lingue e ci leggeva la Bibbia. Lui ci recitava in romanesco i sonetti del Belli. Nessuno dei due era osservante, nessuna di noi tre venne battezzata. La religione non aveva per loro (come non ebbe in seguito per noi sorelle) alcuna importanza.
Io sono nata a Firenze e per qualche tempo ho portato il cognome di mia madre che non era ancora sposata. Le mie due sorelle, più giovani di me, sono nate a Roma, dove abbiamo vissuto gran parte della nostra infanzia.
Vivevamo allora in piazza Indipendenza, una piazza tranquilla, circondata da una fila di oleandri bianchi e rosa, dove i bambini del quartiere nel pomeriggio andavano a giocare, sotto l’occhio delle mamme, delle balie o delle cameriere. A noi però non era consentito uscire. Per i giochi avevamo a disposizione il «nostro» giardino che separava la nostra villetta dall’albergo gestito dalla nonna. Il giardino, ricco di piante di camelia bianche e rosa, aveva al centro una fontana rotonda fasciata di muschio e, in fondo, un antico deposito di carrozze che serviva da studio a mia madre scultrice. (Mio padre ha sempre avuto uno studio fuori di casa.)
La villetta nella quale abitavamo, che mia madre era riuscita a strappare a mia nonna dopo anni di discussioni, di proteste e di fatica, aveva al primo piano le stanze da letto e al piano terra un grande spazio che, occupato dal pianoforte a coda, era insieme sala da musica per mia madre e sala da pranzo per tutti noi. Il pianoforte era il pezzo più importante di quell’ambiente e di quella casa. Sempre ingombro di quaderni, di album da disegno, di libri, tra cui alcuni volumi inglesi per bambini, di cui ricordo le bellissime copertine rigide e le illustrazioni delicate. (Mia madre e mio padre, la domenica mattina, andavano regolarmente a Campo de’ Fiori dove, allora, si svolgeva il mercato dell’usato. E da lì tornavano felici con qualche antica cornice, qualche libro per noi, qualche vecchio tutù di una ignota ballerina.)
Ma uno dei libri che più ci piaceva e stimolava la nostra fantasia era l’atlante di mio padre, che risaliva, probabilmente, agli anni della sua prima giovinezza. Anni lontanissimi, dunque, quando esisteva ancora l’Impero austro-ungarico e a Mosca regnava lo Zar. Ma a noi questo non interessava. Ci sembravano affascinanti, invece, quelle pagine colorate dove apparivano, in fila, tutte le bandiere dei vari Paesi del mondo che ci divertivamo a riconoscere. L’atlante veniva lasciato sul pianoforte, tra i libri di musica di mia madre. E noi potevamo prenderlo quando volevamo e sfogliarlo. Me lo misi in cartella, quando entrai in prima ginnasio, per farlo vedere all’insegnante. Lei lo aprì con diffidenza, ne osservò alcune pagine e me lo restituì, dicendo che avrei dovuto comperarne, presto, uno nuovo. «I confini non sono più quelli del tuo atlante» mi spiegò con indulgenza. E si raccomandò: «Dillo a tuo padre». Ma lui ignorò la richiesta e strizzandomi l’occhio con aria furba e complice avvertì: «Non serve un atlante nuovo. I confini cambieranno ancora». Aveva ragione. I confini stavano già cambiando e ancor più sarebbero cambiati in seguito (ma io purtroppo nel corso degli anni ho perso il mio amato, vecchio atlante…).
Con quell’atlante mio padre tentava di insegnare a me e alle mie sorelle un po’ di geografia. A suo modo, naturalmente. Ci insegnava a riconoscere, prima di tutto, l’Italia e ci sfidava a indicare col dito le capitali d’Europa. Ecco Parigi, la città che aveva amato, che aveva raggiunto qualche anno prima, ma che lo aveva respinto e che, sconfitto, aveva dovuto abbandonare; ecco Londra, la città in cui mia madre con la sua famiglia si era rifugiata dopo i pogrom che all’inizio del secolo avevano devastato la sua terra d’origine; ecco Kowno, la città tra la Polonia e la Russia dove mia madre era nata, ecco Madrid, la città contesa tra i «rossi» e i generali. (Avrebbero vinto i «rossi», diceva sicuro mio padre. E invece vinsero gli altri.) L’atlante era un gioco, l’occasione di una precoce educazione politica. E apriva le porte della fantasia ai nostri sogni. Ci aspettavano, e noi li sognavamo, altre città, lunghi viaggi, nuovi Paesi da scoprire.
Roma era allora per noi un villaggio che potevamo attraversare a piedi, dai prati brulli di Castro Pretorio, dove non era raro veder brucare le pecore e si andava costruendo la nuova università, fino a via Montebello dov’era la nostra scuola elementare intitolata a Enrico Pestalozzi e, lì all’angolo, una cartoleria ricca di colori Giotto e di quaderni a righe e a quadretti. Sempre accompagnate, potevamo arrivare fino a via Volturno per comperare, all’edicola, il «Corrierino dei Piccoli», e fare una breve passeggiata davanti alla stazione, luogo misterioso e affascinante, sul cui frontone spiccava un gigantesco orologio. Alle volte, con mio padre, arrivavamo fino alla piazza dove le Naiadi oscenamente abbracciate ai cigni lanciavano in alto spruzzi d’acqua, poi ci inoltravamo lungo via Nazionale, con un paio di grandi alberghi, bar eleganti e belle vetrine di tappeti, vestiti, profumi. All’altezza del Traforo, subito dopo l’imponente Palazzo delle Esposizioni, la nostra passeggiata finiva.
Da lì mio padre proseguiva da solo per raggiungere, a Palazzo Venezia, un suo vecchio amico, Nino Santangelo, che, lo sguardo affettuoso dietro i grandi occhiali da miope, gli metteva a disposizione i volumi e le riviste della Biblioteca di Storia dell’Arte che dirigeva.
«Chi di noi allora sapeva di Goya, Bruegel e Piero se non attraverso qualche riproduzione?» annotava mio padre. «E poi la pittura moderna: un vero giardino di delizie. È qui che trovammo Chagall e Kokoschka, è qui che entrammo in contatto con la pittura di Parigi…»
Ma noi non eravamo autorizzate ad arrivare fin là, tanto meno a entrare in biblioteca. All’altezza del Traforo noi sorelle tornavamo indietro seguendo svogliate la cameriera di nonna che ci aveva accompagnate.
Ma io, che ero la più grande, ebbi il privilegio di essere portata alla inaugurazione della Cometa, la galleria d’arte voluta da Mimì Pecci Blunt, la contessa amica dei migliori intellettuali italiani e francesi, nella cui casa si potevano incontrare Salvador Dalí e Goffredo Petrassi, Margherita Sarfatti e Sibilla Aleramo. La galleria, diretta da Libero De Libero, vecchio amico di mio padre, era stata ricavata da un locale del palazzo della contessa in piazza Aracoeli, e intitolata «la Cometa» a ricordo dell’insegna araldica di papa Leone XIII, che era il prozio della stessa nobildonna.
Con il passare degli anni quello che mi sembrava un villaggio si allargò. Ma nel mio ricordo è sempre il Tevere che ne segnava il confine. Un giorno mi venne proposto di accompagnare mio padre che andava a dipingere al Gianicolo. Attraversammo il fiume sul ponte sospeso, di ferro, «il ponte del soldino», che univa le due sponde. Mio padre pagò e affrontammo insieme la salita; lui portava il cavalletto, io la scatola dei colori. Dal piazzale, sotto il monumento di Garibaldi a cavallo, mentre mio padre dipingeva, io, per la prima volta, nella luce rosata del mezzogiorno, vidi Roma. Un mare disteso di tetti, di cupole, di guglie, di ponti, campanili, palazzi e chiese. E mi resi conto che non era un villaggio.
In quel lontano 1935 avevo le trecce e, da privatista, avevo dato e superato l’esame di ammissione per la prima ginnasio. Da qualche mese l’Italia era in guerra. Contro l’Abissinia, così lontana che facevo fatica a trovarla sull’atlante di mio padre. L’Africa mi appariva immensa e ignota. Non avevo mai visto un nero, allora, salvo, forse, che sulle pagine della Capanna dello zio Tom. E il Negus, Hailè Selassiè, appariva, nelle illustrazioni dei nostri giornali, come un nano grottesco.
La guerra ci portò nuove canzoni e nuove emozioni. «Faccetta nera, bell’abbissina…» era un motivo facile, allegro. La radio di mia nonna la trasmetteva spesso, e la cantava la sua cameriera. (Allora, tutte le cameriere cantavano, mentre lavavano per terra, rifacevano i letti, sbucciavano le patate.) «Faccetta nera, bell’abbissin...