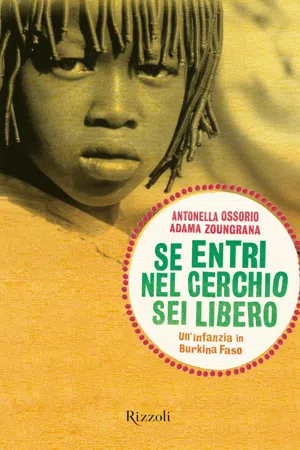![]()
Parte prima
La memoria
![]()
Uno
Mi chiamo Adama, sono nato a Léo, Burkina Faso, Africa. Alcuni ricordi della mia infanzia li ho chiari, altri confusi, ma di una cosa sono sicuro: ero felice. Senza nessun motivo particolare, solo per quelle cose che fanno contenti tutti i bambini. Cose del tipo: qualcuno che ti accarezza quando hai voglia di sentirti piccolo, e qualcuno che dalla strada ti chiama e tu corri fuori a giocare quando hai voglia di sentirti grande. Qualcuno che ti racconta le storie e qualcuno che cucina apposta per te quello che ti piace. Io tutto questo ce l’avevo e a darmelo erano: mia madre, le carezze; i miei amici, le voci dalla strada; mio nonno, i racconti; mia nonna, le cose buone da mangiare.
La mia era una famiglia come tante. Come tante del Burkina, voglio dire, perché con me, la mamma, la nonna e mio fratello Bucary abitavano anche un’altra moglie di mio padre e suo figlio, il mio fratellastro Seydu. E, ma solo per modo di dire, mio padre, che però andava e veniva in continuazione da altri paesi e da altre case dove aveva altre mogli, altri figli, altre famiglie. Altre spese, altri guai, altre preoccupazioni, diceva lui. Ora, il fatto che in Burkina esista la poligamia non vuol dire che devi per forza avere un sacco di mogli e di figli, ma solo che, se vuoi, puoi farlo. Io, per esempio, non credo che vorrei, perché mi pare troppo faticoso. Ma se uno sceglie di farlo, poi non dovrebbe lamentarsi. A mio padre lamentarsi piaceva parecchio, delle famiglie ma anche del lavoro che, invece, gli andava piuttosto bene. Di lavori, prima, ne aveva fatti tanti. Tutti, sosteneva lui. Ma questa era sicuramente un’esagerazione delle sue, perché quando gli si chiedeva quali fossero, lui rispondeva: meccanico, autista, falegname, muratore… poi guardava di lato, in alto, in basso e all’improvviso si metteva a parlare d’altro. Comunque, qualsiasi cosa avesse fatto prima, a un certo punto aveva aperto un ristorante ed era diventato ricco. Ma anche questo pareva quasi che gli dispiacesse, e quelle poche volte che stava a casa rendeva a tutti le giornate pesanti, soprattutto a mia madre e all’altra moglie, che a ogni suo rimprovero facevano un’aria mogia da cani bastonati.
Mia nonna Ziana, invece, che era sua madre, appena lui arrivava rifioriva tutta e scacciava le due mogli dalla cucina, perché il primo pasto, quando mio padre tornava, doveva prepararglielo lei. Il pasto del ritorno era sempre lo stufato di ignami, che è il piatto preferito di mio padre. A essere sincero era anche il mio preferito, ma di questo, se c’era mio padre a casa, mia nonna se ne dimenticava completamente.
Lo stufato di ignami più o meno si fa così: tanto per cominciare, ci vogliono due ignami belli grossi. Sempre ammesso che riusciate a procurarveli. Se vi trovate in Africa, nessun problema. Se invece siete da un’altra parte, la faccenda si complica. In questo caso o lasciate perdere e vi cucinate una frittata, o sostituite gli ignami con due patate. Ora, facendo conto che vi siate procurati gli ignami, sbucciateli, tagliateli a cubetti e metteteli da parte. A questo punto vi serve mezzo litro d’olio. Da noi di solito si usa quello di arachidi, voi fate un po’ come vi pare, l’importante è che lo mettiate a scaldare dentro una casseruola. Quando l’olio è ben caldo, fateci saltare dentro due cipolle. Aggiungete cinque pomodori freschi schiacciati e una cucchiaiata di pomodoro concentrato. Lasciate cuocere per… diciamo più o meno per il tempo che ci metteva mia nonna a sfinire mio padre con domande del tipo: “Hai mangiato abbastanza, mentre eri via? E che cosa hai mangiato? E chi te l’ha cucinato? Ah, lei… e quanto sei stato male, dopo aver mangiato quella robaccia?”
Bene. Adesso versate nella casseruola un po’ d’acqua, mescolate, aggiungete gli ignami, sale e pepe quanto basta, spezie a piacere. Lasciate stufare per… grossomodo per il tempo che ci metteva mio padre a convincere mia nonna di quanto gli fossero mancati i suoi manicaretti. A questo punto lo stufato dovrebbe essere pronto. Servitelo insieme a del riso bollito. O a un piatto di pesce o di carne se c’è da festeggiare qualcosa d’importante; come il fatto che vostro figlio, almeno per il momento, non sarà ucciso dalla cattiva cucina di un’estranea perfida e fannullona.
A me quel miscuglio di roba, che se cucinato a dovere poi diventava uno stufato, pareva un miracolo, una magia. Mi faceva impazzire, ma solo quando lo preparava mia nonna. Quello cucinato da altri sapeva sempre troppo di qualcosa e troppo poco di qualcos’altro. Secondo mia nonna era una questione di etnia. Lo stufato di ignami, sosteneva lei ma su questo ho i miei dubbi, è un piatto che riesce bene solo ai Mossi, e se a cucinarlo è mettiamo caso un Gourounsi, il risultato non è garantito. Anche su questo ho i miei dubbi. Mi sa che il punto è se sei bravo a cucinare oppure no, piuttosto che l’etnia alla quale appartieni.
Di etnie, in Burkina, ce ne sono così tante che nemmeno me le ricordo tutte: Mossi, Gourounsi, Yarse, Bobo, Lobi, Samo, Marka. E, ancora, Dyula, Hausa, Peul, Tuareg… ciascuna con le proprie tradizioni, la propria cultura, la propria lingua. Poi ci sono quelli mischiati come me: io sono metà Mossi come mio padre e metà Gourounsi come mia madre. Perciò è normale che uno in famiglia parli due lingue e che, senza nemmeno accorgersene, finisca per imparare anche quelle degli amici e dei vicini di casa.
«Sì, ma una cosa sono le lingue, un’altra la cucina» diceva mia nonna. «E se non ci credi nemmeno dopo aver assaggiato uno stufato di ignami preparato da un Gourounsi, allora peggio per te.»
Però non credo che fosse solo perché la nonna era brava a cucinare se mio padre, mentre mangiava lo stufato preparato da lei, diceva: «Buono! Buono!» e le sorrideva e faceva gli occhi da bambino, mentre quando mangiava la roba cucinata da mia madre o dall’altra moglie se ne stava tutto ingrugnito e non diceva niente. Avevano un legame molto forte, mio padre e la nonna, perché lui era figlio unico e aveva perso il padre quand’era piccolo.
*
Mio nonno, invece, il padre di mia madre, non abitava con noi. Era l’imam del paese. Per questo, e per il suo carattere forte, tutti lo rispettavano. Riusciva a rendere straordinaria qualsiasi cosa facesse, anche la più normale, come farti segno di sedere accanto a lui, guardarti negli occhi, porgerti un bicchiere d’acqua. Insomma, aveva quello che si definisce carisma. Si chiamava Z’Nda, ma nessuno lo chiamava mai per nome. Per tutti lui era l’imam. Per me era soltanto il nonno.
Tornando a quel potere misterioso che è il carisma, non so come lo chiamasse mio nonno, ma di sicuro sapeva di avercelo. E ne approfittava. Nel senso che quando si metteva in testa una cosa la faceva e basta, senza mai dare spiegazioni a nessuno. Come quella volta che, non mi ricordo per quale motivo, andò in un altro paese. E mentre stava là, un suo nipote cadde in un pozzo e morì annegato. Morire annegato in un posto dove l’acqua è più rara dell’oro è veramente una beffa del destino. Ma fu proprio così che andarono le cose. Ora, dovete sapere che per la religione musulmana il corpo va sepolto nel giorno stesso della morte. Anche per quel mio parente così fu fatto.
Passano tre giorni, mio nonno ritorna a Léo e gli danno la notizia. Allora lui dice: «Aprite la tomba!» E non è che lo chiede: lo ordina, lo pretende. Aprire una tomba non è legale e nemmeno logico. Ma siccome l’ha chiesto l’imam, e con lui non si discute, nessuno si permette di fiatare e la tomba viene aperta. Mio nonno ci guarda dentro, la sua faccia sembra scolpita nella pietra. Non muove un muscolo né dice una parola. Soltanto rimane là per un’eternità a guardare il morto. A un certo punto fa segno con la mano di richiudere. Poi si volta e se ne va. Il perché di tutto questo nessuno ha mai avuto il coraggio di chiederglielo. Però, secondo me, i motivi sono due. Uno: perché così aveva potuto vedere suo nipote per l’ultima volta. Due: perché finché non lo vedeva con i suoi occhi, si rifiutava di credere che fosse morto. Che ci volete fare, così era fatto mio nonno.
Io stavo sempre con lui, mi raccontava le storie e, appena ne finiva una, gli dicevo: «Ancora, nonno.» Lui rispondeva sempre: «Va bene, ancora una.» E ricominciava.
Un giorno, però, mi risponde: «Te la racconto più tardi, ora sono stanco.» Anch’io sono stanco, infatti mi addormento. E sogno le Maschere. Mi trovo nella piazza e loro stanno là, al centro della solita folla che si accalca durante una festa. “La terra chiede pioggia e pioggia cadrà” dice una voce. Le Maschere ballano al suono dei tamburi e dei flauti, saltano, fanno capriole spettacolari. Rappresentano animali, ma sono più simili a demoni, a mostri. Ma a me non fanno nessun effetto perché il nonno mi ha spiegato che sotto le facce finte ci sono i volti di uomini qualsiasi, e tanti di loro, come quello che lavora da Hamed il barbiere, perfino li conosco. Però siccome è una specie di segreto, devo far finta di non saperlo. Gli altri bambini invece hanno paura, ce n’è uno che grida e si nasconde dietro le gambe della mamma. Allora lei lo prende in braccio, gli asciuga le lacrime, gli dà un bacio. Poi lo consegna alla Maschera più terrificante, quella con le corna da antilope e il corpo coperto di piume. La Maschera lo prende, lo solleva in alto, e insieme girano, girano, girano. La Maschera stringe al petto il bambino che sparisce in mezzo a tutte quelle piume. Sono diventati una cosa sola, Maschera e bambino. La mamma guarda, seria. Quello che sta succedendo non le piace, ma va fatto per il bene di suo figlio, per aiutarlo a superare lo spavento. Perché solo quando la paura diventa insopportabile trovi dentro di te la forza per combatterla. Tutti i bambini prima o poi vanno a finire tra le braccia della Maschera, tutti tranne me, perché non ce n’è stato bisogno. È un’altra la cosa che a me fa paura, cioè la mia ombra, che è molto peggio di una Maschera. Mi sta sempre attaccata. E anche se ha braccia non potrà mai prendermi, né sollevarmi, né farmi girare in tondo.
Adesso però la mia ombra non si vede e io mi godo la festa. Sento che intorno tutto batte allo stesso ritmo: i tamburi, le mani della folla, il mio cuore… poi qualcuno mi sveglia. La casa del nonno è piena di gente, c’è anche mia madre e sta piangendo.
«Il nonno è morto» mi dice e io allora penso che non ci saranno più storie per me, o forse ne avrò ancora, ma non da lui. Penso che l’ultima che mi ha raccontato è stata davvero l’ultima. La storia dei Nomi.
I Nomi
Vivevano a Koudougou due fratelli che una volta diventati uomini decisero di cambiare il loro nome. Il maggiore dei due disse: «Da oggi in poi il mio nome non sarà più Pocò, ma: Colui che sa senza Nulla ricordare.» E il minore, che alla nascita era stato chiamato Kangò, disse: «Il mio nome invece sarà: Colui che sa ricordando Tutto.» Poi andarono dal padre che, ricevuta la notizia, non fece commenti né chiese spiegazioni. Soltanto disse al figlio maggiore: «Per te è arrivato il momento di cercarti una donna e costruire una famiglia. Poiché sei il primogenito, poiché ormai hai l’età per sposarti, poiché soprattutto hai preso coscienza del tuo nuovo nome, dovrai farlo il prima possibile.»
Il figlio si mise subito in cerca della donna giusta. La trovò in un villaggio vicino, e poco tempo dopo il matrimonio fu celebrato. Durante la festa di nozze, il padre chiamò da parte il figlio minore e gli disse: «Adesso tocca a te. Trova una donna adatta e sposati.» Il figlio, che aveva già messo gli occhi su una cugina di sua cognata che viveva in un altro villaggio, rispose: «Quella donna forse io l’ho già trovata.» Non si sbagliava. Poco dopo anche lui si sposò e insieme a sua moglie, come già aveva fatto il fratello maggiore, si stabilì a Koudougou non lontano dalla casa del padre.
Passò del tempo. Un giorno il padre chiamò i suoi figli e disse: «Poiché siete ormai dei capifamiglia, e soprattutto uomini consapevoli del nome che portate, per voi è arrivato il momento di rispettare la tradizione e andare a far visita ai parenti delle vostre mogli.»
Il giorno dopo i due fratelli si misero in cammino. Disse il maggiore: «Siccome io sono il primogenito, per prima cosa andremo a trovare la famiglia di mia moglie.» Così fecero. Al loro arrivo furono accolti con grandi festeggiamenti. Vennero ammazzate una capra e una gallina, le donne ne cucinarono la carne e il banchetto fu ricco e pieno di allegria. Disse il fratello maggiore: «Ecco quello che hanno fatto per noi i parenti di mia moglie. Vediamo adesso cosa faranno quelli della tua.»
I due fratelli s’incamminarono verso il villaggio vicino. Al loro arrivo la famiglia della sposa del fratello minore li accolse con affetto. Poi le donne si allontanarono per preparare una cena di benvenuto per gli ospiti.
Verso sera, un bambino venne ad avvisare gli uomini riuniti nella sala degli incontri che il cibo, to di miglio con sugo di carne, era pronto. Infatti, appena fuori dalla capanna, era stato preparato un tavolo con sopra due recipienti di forma sferica. Nessuna traccia, però, delle donne.
I due fratelli, che erano stati i primi a uscire, vedendo che gli altri uomini non li avevano seguiti, tornarono indietro a chiamarli. Ma la sala degli incontri era deserta. Anche per strada non c’era più nessuno. I fratelli, che erano affamati, si avvicinarono al tavolo e guardarono il recipiente più grande, dentro il quale doveva esserci il to. Ma quando fecero per scoperchiarlo si accorsero che non aveva nessuna apertura. Anche l’altro recipiente, che doveva contenere il sugo e la carne, era come il primo: una sfera liscia, calda del cibo che conteneva, e del tutto impossibile da aprire. Allora il fratello maggiore disse: «Una cena che non si può mangiare. Ecco quello che hanno preparato per noi i parenti di tua moglie. E adesso che cosa facciamo?» E il fratello minore: «Una soluzione la troveremo.»
«Io l’ho già trovata. Se vogliamo saziarci, non ci rimane che spaccare i recipienti.»
«Questa non è una soluzione. Se spacchiamo i recipienti, le schegge di creta si mescoleranno al cibo, che diventerà immangiabile.»
«È vero, l’avevo dimenticato… allora torniamo al villaggio vicino e chiediamo ai miei cognati di aiutarci ad aprire le pentole.»
«Questa non è una soluzione. Chiedere ai tuoi cognati di intervenire mentre siamo ospiti dei miei, sarebbe una vergogna per me e per la famiglia della mia sposa.»
«È vero, l’avevo dimenticato… e allora?» Il fratello minore non rispose. Rimase per un po’ a pensare, poi raccolse da terra un pezzetto di carbone col quale tracciò un segno sulla pentola che conteneva il to. La stessa cosa fece sulla ciotola che conteneva il sugo. Subito i due recipienti si aprirono, mostrando il cibo fumante e profumato. Il fratello maggiore ci si buttò sopra e incominciò a mangiare. Soltanto quando la sua pancia fu piena, finalmente disse: «Come hai fatto? Ma guarda che strano, fino a un attimo fa avevo dimenticato di chiedertelo.»
«Non ho fatto niente di speciale, ho solo ricordato quello che una volta ci disse nostro padre.»
«E che cosa disse? Non ricordo…»
«Disse che a volte è necessario rendere le cose visibili.»
«Che cosa significa? Quello che esiste è sempre visibile, quello che non è visibile è inesistente.»
«Ti sbagli. Ci sono cose nascoste ma non per questo meno reali. I recipienti un’apertura ce l’avevano. Eravamo noi che, senza l’aiuto di un talismano, non riuscivamo a vederla.»
«Quale talismano? Io nelle tue mani ho visto solo un pezzo di carbone…»
«Nostro padre una volta ci ha detto che qualunque cosa può essere un talismano. Anche un pezzo di carbone. Anche il nome che portiamo.»
Il fratello maggiore all’improvviso si vergognò. Di se stesso, del suo aver rinunciato alla memoria. Si vergognò del nome che si era scelto, che era un nome non soltanto cattivo ma soprattutto stupido.
«Stupido, come?»
«Stupido e basta.»
«E poi?»
«E poi, niente.»
«Va bene, nonno, ma cosa fece il fratello maggiore? Cambiò il nome cattivo con uno buono? E quale scelse? E perché tutta la gente del villaggio era scomparsa? E perché le aperture dei recipienti erano nascoste? E poi…»
«E poi niente, Basjna. La storia finisce così.»
![]()
Due
Dopo la morte di mio nonno, mi legai ancora di più a mia madre. Mio padre, che continuava a girare da un paese all’altro, da una casa all’altra, da una famiglia all’altra, lo vedevo pochissimo. Le andavo sempre dietro, a mia madre. Stavo buono e zitto, quasi mi rendevo invisibile, perché sapevo che lei aveva tante cose di cui occuparsi. Soprattutto di Seydu, visto che la sua mamma, stufa dei maltrattamenti di mio padre, un giorno se n’era andata via. Prima di partire, aveva detto a mia madre: «Ami, ti lascio Seydu. Con lui sei più brava di me: è te che guarda quando ha bisogno di qualcosa.»
«Stai tranquilla, a Seydu ci penso io» aveva ribattuto ...