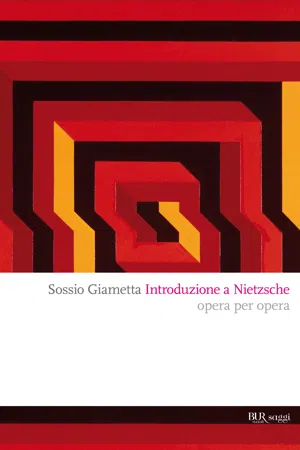![]()
La nascita della tragedia
La nascita della tragedia dallo spirito della musica (1871) è l’esplosione del genio di Nietzsche, del suo genio e della sua sregolatezza. Ma anche se per alcuni questa esplosione di genio non è stata mai più, nell’opera di Nietzsche, superata, La nascita della tragedia si presenta soprattutto come sregolatezza, arbitrarietà e dismisura, che bisogna prima vincere per arrivare, caso mai, al genio. Bisogna in particolare risalire, dalle cose di cui si parla – la tragedia attica – a colui che ne parla. Perché sono soprattutto l’Autore, la sua natura e il suo stato d’animo, che danno senso e valore all’opera. Per questo «terribile» intreccio e miscuglio, il giudizio su questa prima «grande» opera di Nietzsche fu subito diviso, e resta ancora oggi aperto. In questo senso, La nascita della tragedia rimane il libro più problematico di Nietzsche. E che tale esso sia – perché, come afferma l’Autore, si rifà ad una profonda esperienza personale – lo dice e lo ripete Nietzsche stesso, nel «Tentativo di autocritica» premesso all’opera nel 1886, «come prefazione (o epilogo)». È interessante notare che Nietzsche dirà la stessa cosa di Così parlò Zarathustra. Questo libro, secondo lui, è «incomprensibile per questo, che si rifà ad esperienze tutte che io non ho in comune con nessuno».1 E in effetti «il visionario dello Zarathustra»2 non è diverso dal visionario della Nascita della tragedia dallo spirito della musica, perché Zarathustra, ancora una volta, «è il concetto di Dioniso».3
Questa problematicità di Nietzsche, dovuta alla sua tendenza poetico-misticheggiante di discepolo di Dioniso, quale egli ha sempre voluto essere in opposizione al cristianesimo (è testimoniato anche da uno dei cosiddetti biglietti della follia, Wahnsinnszettel), si distingue tuttavia dalla problematicità che alcuni interpreti fanno valere genericamente a suo riguardo. Questa è dovuta infatti, a nostro parere, soprattutto alla loro incapacità di sciogliere il nodo, certo aggrovigliato, dei talenti e delle valenze di Nietzsche. Per esempio Rüdiger Safranski dice:
Di Nietzsche non si può venire a capo. Neanche lui è venuto a capo di se stesso.4
Anche per Jaspers «Nietzsche è inesauribile. Egli non rappresenta un problema che possa essere risolto nella sua interezza», e per Gottfried Benn, che tale giudizio riporta nell’Introduzione ai Ditirambi di Dioniso,5 questa è una «frase assai significativa! Con criteri europei moderni in realtà Nietzsche non può essere risolto, appartiene alle “Parole primordiali” [Urworte]».6 Il grande biografo di Nietzsche, Curt Paul Janz, spiega più chiaramente che Nietzsche ha
lasciato un’opera che ci starà sempre davanti come uno stimolo, che nella sua molteplicità offre bensì varie possibilità di accesso e di interpretazione, ma non potrà mai essere abbracciata nella sua totalità da un singolo osservatore, misurata da un singolo rielaboratore. Collocare Nietzsche nella sua epoca e nel fluire dei secoli, nel contesto del suo ambiente e in quello delle correnti spirituali che risalgono fino ai primordi dell’antichità classica, è impresa che fuoriesce dai canoni interpretativi normali.7
Insomma, secondo costoro, Nietzsche non si può capire. Ma può la critica arrendersi, vanificarsi, solo perché un’interpretazione si presenta a prima vista e magari anche a seconda vista come «impossibile», ossia come più difficile di altre? E si può, d’altra parte, sostenere di un qualsiasi autore ciò che Safranski, Jaspers, Janz e anche altri sostengono di Nietzsche: che sfugge all’analisi, «échappe à l’analyse», come un critico francese disse, dopo un concerto, di Beethoven, quasi che Nietzsche o Beethoven fossero fuori o al di sopra del genere umano? Nel genere umano anche il genio più grande è inscritto con una sua chiara funzionalità. Il genio è infatti l’estrema risorsa dell’umanità nelle sue crisi più difficili.8 Dunque la difficoltà di capirlo corrisponde alla difficoltà di capire la crisi stessa. Perciò non resta che affrontare questo problema e cercare di risolverlo con i mezzi a nostra disposizione.
A tal fine sarà utile, per quanto riguarda La nascita della tragedia, passare in rassegna, come prima cosa, le varie reazioni provocate dalla pubblicazione del libro, senza trascurare quelle dello stesso Nietzsche. Questi tuttavia si esprimerà in seguito, a due riprese, in modi affatto diversi: prima nel suddetto «Tentativo di autocritica», poi in Ecce homo, nel capitolo dedicato appunto a La nascita della tragedia. I giudizi che egli dà sulla propria opera in questi due scritti costituiranno la base principale del tentativo che faremo alla fine di pervenire a un giudizio conclusivo. Per ora fermiamoci alle sue ed altrui reazioni di quel tempo.
Tra queste ultime vanno in primo luogo segnalate quelle dei filologi. La nascita della tragedia promanava da un professore ordinario di filologia classica e si proponeva un assunto tutto filologico: indagare l’origine della tragedia greca dallo spirito della musica. Non c’è quindi da meravigliarsi che essa, che è invece soprattutto opera filosofica, venisse accolta dai filologi come un tradimento dei loro metodi e delle loro aspettative. I più reagirono con un silenzio ostile, che era una condanna senza appello. Qualcuno parlò. «Si tratta di assurdità belle e buone, che non servono a nulla: uno che ha scritto roba del genere è morto per la scienza». Ciò avrebbe detto ai suoi studenti a Bonn, come riferisce Nietzsche stesso, il filologo Hermann Usener, da lui stimato, anche se non proprio come un’aquila, e con cui aveva progettato in passato un’impresa comune nel campo della storia della filosofia.9 Il giudizio di Usener si può considerare il giudizio che diede, sulla Nascita della tragedia, l’intera corporazione dei filologi.
Lo stesso maestro di Nietzsche, il famoso filologo Friedrich Ritchl, che aveva fatto ottenere senza esami e senza dottorato al suo pupillo la cattedra di filologia a Basilea, fu dal libro sconcertato e deluso. Il 31 dicembre 1871 annotò nel diario: «Libro di Nietzsche Nascita della tragedia (stravaganza geniale)». E, poiché Nietzsche gliel’aveva fatto mandare dall’editore senza una propria dedica, non si ritenne in obbligo di scriverne al suo exallievo. Questi però, che si era aspettato molto da chi già gli aveva dato molto, ci rimase male. E non se lo tenne per sé. Il 30 gennaio 1872 prese penna e carta e scrisse al maestro:
Veneratissimo Signor Consigliere,
non se la prenderà con me se mi stupisco di non aver ricevuto nemmeno una parolina da Lei sul mio libro uscito di recente, e nemmeno, spero, per la schiettezza con la quale Le esprimo questo stupore. Infatti questo libro è una specie di manifesto, e meno che a qualsiasi altra cosa invita al silenzio. Forse si meraviglierà se Le dico quale effetto pensavo che il mio libro avrebbe fatto su di Lei, venerato Maestro: speravo che, semmai Le si fosse presentato qualcosa di promettente in vita Sua, questo avrebbe potuto essere il mio libro, promettente per il nostro studio dell’antichità, per lo spirito tedesco, anche se per un certo numero di persone avrebbe segnato la rovina. […] Ora mi turba un poco il Suo silenzio. Non che io abbia dubitato per un solo momento della Sua partecipazione nei miei riguardi; di essa son convinto una volta per tutte – ma proprio per via di questa partecipazione mi potrei immaginare che Lei si preoccupi in un certo senso per me personalmente. Le scrivo appunto per dissipare queste preoccupazioni…10
Ritchl rispose il 14 febbraio 1872, dopo aver annotato nel diario, il 2 febbraio 1972: «Fantastica lettera di Nietzsche (= megalomania)»:
Secondo la mia intera natura – e questa è la cosa principale – io appartengo in modo così risoluto alla corrente storica e alla considerazione storica delle cose umane che non mi è mai sembrato si potesse trovare la redenzione del mondo in questo o quel sistema filosofico; consideri inoltre che neppure mi potrò mai indurre a definire «suicidio»11 il naturale appassirsi di un’epoca o di un fenomeno; che non sono in grado di vedere un regresso nella individualizzazione, né di credere che le forme e le potenze della vita spirituale di un popolo, in un certo senso privilegiato e raramente dotato per natura e grazie allo sviluppo storico, siano da considerare come una norma assoluta per tutti i popoli e le epoche – allo stesso modo che una religione non basta per le varie individualità nazionali, non è mai bastata, né mai basterà. – Lei non può pretendere da un «alessandrino», da uno «scienziato» di condannare la conoscenza e di scorgere solo nell’arte la forza riplasmatrice, redentrice e liberatrice del mondo.12
Il giorno dopo aggiunse nel diario: «A Nietzsche sulla sua Nascita della tragedia; secondo uno schema di mamma» [della moglie Sophie].
La posizione storica di Ritchl, come si vede, era nettamente contraria a quella metafisica espressa da Nietzsche nella Nascita della tragedia. Gli argomenti di Ritchl sembrano tuttavia non aver lasciato indifferente Nietzsche, dato che nelle opere aforistiche, a partire da Umano, troppo umano, egli sembra impegnatissimo a darvi attuazione. Essi potrebbero addirittura essere stati, come occasione scatenante, all’origine di un’evoluzione naturale, della svolta costituita appunto da Umano, troppo umano. Questa ipotesi appare particolarmente plausibile se si considera che, per la ricchezza di aperçus storici che costellano tutta l’opera nietzschiana, non si può non riconoscere a Nietzsche, in aggiunta agli altri suoi talenti, un geniale senso storico. Questo è stato rilevato tra gli altri da Giorgio Colli,13 dal biografo Charles Andler14 e prima ancora da Lou Salomé, che vedeva in Nietzsche, appunto, un grande storico mancato.15 Ma poiché, come ella stessa aveva notato, «in Nietzsche vivevano l’uno accanto all’altro, in continua discordia e tiranneggiandosi a vicenda, un musicista di grande talento, un libero pensatore, un genio religioso e un poeta nato»,16 a cui vanno aggiunti secondo noi il moralista, il critico della cultura, della società e della civiltà, lo psicologo, il visionario, il diagnostico, il profeta e il sostenitore di un radicalismo aristocratico; non c’è da meravigliarsi che il talento storico non si svolgesse in lui autonomamente, ma conservasse una funzione sussidiaria.
Alla pubblicazione, d’altro lato, non mancarono neanche le reazioni positive. Esse provennero anzitutto dalla coppia allora idolatrata da Nietzsche, Richard e Cosima Wagner. Questi erano i meglio disposti verso di lui non solo per amicizia, ma anche per il fatto che La nascita della tragedia era diretta e dedicata a Richard Wagner ed era in sostanza un continuo colloquio con lui, come, secondo il biografo Curt Paul Janz, saranno anche tutte le altre opere di Nietzsche. Inoltre in essa si faceva grande posto alla musica wagneriana e, pur esssendo stata l’opera concepita autonomamente, nell’ambito di un vasto lavoro sui filosofi presocratici (il cosiddetto Philosophenbuch, non portato a termine), essa era stata poi rimaneggiata in base alle osservazioni e ai consigli elargiti da Wagner a Nietzsche, nel soggiorno che questi fece a Tribschen dal 3 all’8 aprile del 1871. Anzi, secondo Manfred Eger, il tema, il titolo e le idee fondamentali dell’opera sarebbero addirittura di Wagner.17 Ma nella lettera del 4 febbraio 1872 all’amico Erwin Rohde, Nietzsche confessa che gli era costato un grande sforzo tenersi indipendente da Wagner, indipendente fino a turbarlo insieme con Cosima.18 L’influsso di Wagner è tuttavia sicuro, per sua stessa ammissione. E da parte sua Janz lo conferma. Nel notare, infatti, che Nietzsche condusse il suo dialogo con l’antichità in base alla nuova possibilità di intenderla apertagli dalla filosofia di Schopenhauer, e nel puntualizzare che l’influsso di Wagner non va sopravvalutato, così conclude: «Ma le idee e l’opera ricevettero la loro forma finale dalla personalità di Richard Wagner».19 Nel suddetto «Tentativo di autocritica», 2, del 1886, Nietzsche insiste comunque sull’indipendenza dell’opera dicendola «un’opera giovanile piena di coraggio giovanile e melanconia giovanile, indipendente, caparbia e autonoma anche là dove sembra inchinarsi a un’autorità e a una parti...