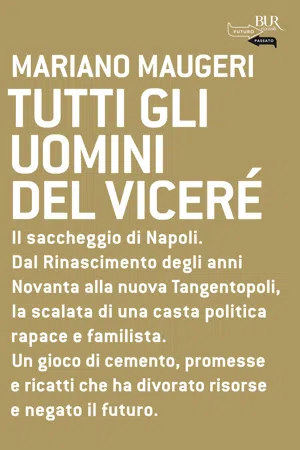![]()
1. Palazzo San Giacomo
Palazzo San Giacomo, uno dei più imponenti d’Europa, 17 finestre in stile neoclassico nella facciata centrale di fronte al Maschio Angioino, fu costruito dai Borboni in sei anni, dal 1819 al 1825, per volontà di Ferdinando I: lì si sarebbe concentrato il quartier generale del Regno, con la sede di tutti i ministeri. Una chiesa cinquecentesca, San Giacomo agli Spagnoli, incorporata al suo interno, 846 stanze, un labirinto di corridoi, metafora perfetta dell’anarchia che impera nella città più ingovernabile d’Occidente.
Il palazzo, sede del Comune, è di proprietà del Banco di Napoli che lo rileva dal demanio dello Stato negli anni Trenta. Il lato su via Toledo ospita infatti il quartier generale della banca partenopea, con una facciata di stile razionalista eretta durante il Ventennio: il potere da una parte e i denari dall’altra.
Dai tempi immemori dei Borboni, Palazzo San Giacomo è una zona franca: chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Qui vale la legge del più forte, il ricatto è la moneta di scambio, e i segreti – che tutti, assessori, dirigenti e uscieri custodiscono nella loro memoria – ne raccontano la storia più autentica.
Chi è l’uomo al quale un milione di napoletani prima e sei milioni di campani poi hanno consegnato il loro destino? Antonio Bassolino si iscrive al Pci all’età di diciassette anni. Nel 1970, appena ventitreenne, è eletto consigliere regionale della Campania. Un anno dopo diventa segretario provinciale del Pci di Avellino, dove rimarrà fino al 1975. Nel 1976 lo ritroviamo giovanissimo segretario regionale del Partito comunista, un incarico che ricoprirà fino al 1983. Facile far di conto: sono 34 anni che Totonno influisce in modo determinante sugli assetti politici della seconda regione italiana. La Campania, infatti, con 5,7 milioni di abitanti, 5 capoluoghi di provincia e 551 comuni, è la più popolosa d’Italia dopo la Lombardia.
La carriera politica di Bassolino nel partito corre parallela a quella campana. Nel 1972 fa il suo ingresso nel comitato centrale del Pci, nel 1980 diventa responsabile della commissione per il Mezzogiorno. Nel 1987 arriva a Montecitorio. Componente della commissione lavoro e tre anni dopo presidente della commissione mass media. La grande occasione della sua vita politica arriva all’età di quarantacinque anni. È il gennaio del 1993, e il partito lo invia a Napoli, la sua città, con il ruolo di commissario della Federazione napoletana coinvolta negli scandali di Tangentopoli. Nel dicembre dello stesso anno viene eletto sindaco al primo turno con il 55,6 per cento dei voti. È rieletto nel 1997 con il 72,9 per cento dei consensi. L’anno seguente viene nominato ministro del Lavoro del governo D’Alema, ruolo che lascerà un anno dopo. Dal 2000 è presidente della Regione Campania, incarico confermato nel 2005.
Sotto la guida di Antonio Bassolino Napoli diventa una sorta di icona mediatica. Capitale culturale, laboratorio nel quale si sperimentano le trasformazioni che modernizzeranno il Sud e le sue metropoli: la sfida della mobilità su ferro, la bonifica e la rivalutazione di vaste aree della città, un nuovo piano regolatore che ha tentato di incardinare in un progetto di razionalizzazione urbana la grande questione dell’area Ovest (Bagnoli) e la rinascita di Napoli Est.
Questioni ponderose che Bassolino, nella prima sindacatura, affronta in modo innovativo scegliendo assessori tecnici di chiaro orientamento politico ma con una forte caratura professionale. L’urbanista Vezio De Lucia, il manager Roberto Barbieri, Ada Becchi Collidà, economista con delega alla Mobilità che a un anno dall’insediamento della giunta abbandona Palazzo San Giacomo per motivi famigliari e professionali. Il G7 dell’estate del 1994 e la valorizzazione dei musei della Fondazione Napoli 99 guidata da Mirella Barracco riportano la città sui giornali di tutto il mondo. I media firmano una cambiale in bianco a Bassolino e alla sua squadra di governo. Le auto sgomberate da piazza del Plebiscito diventano il simbolo di una Napoli con ambizioni finalmente europee, la capitale di un Sud che vuole riprendersi il ruolo assegnatole dalla storia. L’immagine di Bill Clinton che, felice come un bambino, addenta una pizza in via dei Tribunali fa il giro del mondo. Gli italiani si accorgono che Napoli non è solo monnezza e malaffare. I milanesi prenotano di mese in mese i weekend partenopei, la borghesia apre i suoi palazzi alle legioni di ospiti che arrivano dal Nord e dal resto d’Europa, i giornalisti di mezzo mondo raccontano la metamorfosi di una grande città con un sindaco comunista e operaista pronto a rivoltarla come un guanto. Tutti i cronisti e gli inviati narrano l’orgoglio ritrovato e la bellezza di un centro storico tra i più straordinari del pianeta. Nessuno che si spinga qualche chilometro più in là, nei quartieri ghetto di Scampia, Ponticelli, Sanità, Secondigliano, quartieri rimossi, dimenticati, nascosti agli occhi e alle telecamere dei giornalisti-turisti.
Le innegabili meraviglie di Napoli incitano a enfatizzare, romanzare, esaltare una sequela di bei progetti e parole roboanti che in grandissima parte, purtroppo, rimarranno tali. È un rinascimento immateriale, mediatico, un finto risarcimento per gli anni miseri del colera, del terremoto, delle tangenti e della camorra.
Totonno party
Dietro il glamour della prima giunta bassoliniana, insediata nel gennaio del 1993 e da molti magnificata, si nasconde in realtà una strana combinazione di cultura veterocomunista e modernità.
Allo stile manageriale pragmatico dell’assessore alle Risorse strategiche Roberto Barbieri, che introdurrà la finanza creativa al Comune di Napoli, fa da contraltare la perentorietà dell’assessore all’Urbanistica Vezio De Lucia.
De Lucia, direttore dell’ufficio tecnico del commissariato per la ricostruzione post terremoto di Napoli dal 1981 al 1983 e direttore generale del ministero dei Lavori pubblici dal 1986 al 1990, vara un piano regolatore che, per non correre il rischio di essere in qualche modo paragonato al sacco di Napoli laurino,1 ha scelto di mummificare la città: non si abbatte, non si costruisce e non si ricostruisce. «Si poteva benissimo demolire e ricostruire» ripete l’autorevole e poco ascoltato (in patria) urbanista Aldo Loris Rossi. De Lucia non gli dà retta. Una decisione i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti: un mercato immobiliare paralizzato dove l’offerta non esiste mentre la domanda, complice l’altissima densità umana e la percentuale elevata di giovani, aumenta a dismisura. Una politica urbanistica che, oltre ad aver bandito le demolizioni (escluse quelle mediatiche di una parte delle Vele di Scampia, nel 1997), sancisce il trionfo della rendita fondiaria, il nemico storico numero uno del Mezzogiorno, dei comunisti e di Antonio Gramsci: chi vende se la casa nella quale vive aumenta di valore ogni settimana? Per non parlare di Posillipo, dove si sono aquartierati Bassolino e la sua corte: le quotazioni medie sono simili a quelle del quadrilatero della moda a Milano o di Manhattan. Con conseguenze inimmaginabili sulla composizione sociale: esodo delle nuove famiglie, la linfa stessa di una città, deportate a Giugliano e Casalnuovo, dove i lestissimi impresari legati al clan Moccia alzano in pochi mesi settanta palazzi abusivi senza licenza edilizia con la complicità del sindaco e del consiglio comunale.
«Napoli sarà come Parigi: una città tutto» diceva trionfante De Lucia nel 1995. L’idea di fondo, fin troppo evocativa, immaginava la saldatura tra la corona collinare e la linea del mare attraverso quattro grandi aree verdi. Un cerchio fatto per metà d’acqua e per l’altra metà di parchi, che avrebbe unito, ai suoi estremi, due aree di sviluppo urbano, Bagnoli e Napoli Est. Per queste aree vennero redatte le Varianti della zona occidentale e orientale da parte dei «ragazzi del Piano», i tecnici e gli ingegneri di cui si arricchirono in quegli anni gli uffici del Comune. Il messaggio politico era chiaro e in qualche modo dirompente: fuori i consulenti esterni, spesso sottomessi al potere delle lobby, dentro i professionisti selezionati.
Il piano di De Lucia, avanguardistico e insieme popolare, nascondeva in realtà un’idea elitaria che ignorava i drammatici problemi della città, di cui si ersero a paladini architetti e urbanisti della facoltà di Architettura, e che faceva coincidere il suo intervento con il perimetro del Comune di Napoli, infischiandosene dei due milioni di persone che vivevano uno sull’altro nella provincia, la più affollata d’Occidente e tra le più densamente popolate del globo.
Poco tempo prima, nel 1992, in occasione delle Olimpiadi, Barcellona aveva inaugurato una nuova e feconda stagione, ispirata a una visione innovativa dell’urbanistica che assegna al pubblico la responsabilità delle scelte e ai privati il ruolo di agitatori di idee, progetti, assetti. Tale visione prende corpo nei cosiddetti Piani strategici condivisi, progetti nei quali l’intera comunità fa sentire la sua voce e si mobilita per definire le linee di sviluppo – urbanistiche, economiche, sociali, culturali – che, a rigor di logica, sono interdipendenti. Tutte tessere di un mosaico che concorrono a disegnare un modello di città partecipata. A Napoli non si scelse questa strada.
Il pregiudizio nei confronti degli uomini di Pomicino, che al tempo di Gava avevano messo a punto il monumentale piano urbanistico Neonapoli, era ancora vivo nella memoria dei napoletani che l’avevano osteggiato poiché lo avevano percepito come una operazione affaristica calata dall’alto. Napoli, insomma, era preda delle ostilità del passato, degli steccati politici, della visione manichea tra i puri di Bassolino e i corrotti, cioè tutti gli altri, compreso chiunque fosse portatore di un pensiero diverso. Bassolino si fece carico di sostenere un modello di pianificazione urbanistica datato: «L’amministrazione si assume le sue responsabilità. Solo dopo la stesura del Piano regolatore generale la città e il consiglio comunale potranno contestarne i singoli passaggi».
Un metodo di lavoro – antitetico al piano strategico condiviso – che impone dall’alto l’idea di città. Gli esperti della facoltà di Architettura contestano polemicamente questa impostazione e invocano gesti di discontinuità. Simbolo della protesta è l’abbattimento di Palazzo Ottieri in piazza Mercato, un alveare con 240 famiglie, un ecomostro che da solo fotografa le mille contraddizioni urbanistiche di Napoli.
Il dibattito e le contrapposizioni si trascineranno fino al 2003, anno in cui il piano regolatore concepito da De Lucia sarà approvato dal consiglio comunale guidato da Rosa Russo Iervolino. Nel 2001, intanto, Rocco Papa, l’urbanista bassoliniano che succede a De Lucia all’assessorato all’Urbanistica, difende le scelte del suo predecessore: «Mi accusano di non abbattere i mostri come Palazzo Ottieri di piazza Mercato? In quello stabile vivono 240 famiglie. Spianarlo e ricostruirlo costerebbe almeno 120 miliardi. Certo, se avessi i quattrini seguirei il suggerimento di Renzo Piano, che da anni ci incita a raderlo al suolo. Ma a quel palazzo-monnezza si aggrappano centinaia di cittadini».
La contraddizione è evidente: gli uomini di De Lucia contestano alla radice la perequazione – vale a dire lo scambio di aree tra pubblico e privato – che sta alla base del piano strategico condiviso, per fare invece leva sul vecchio e costoso istituto dell’espropriazione, ossia il risarcimento con denaro pubblico delle aree rilevate forzosamente dai privati. Tranne poi ammettere che mancano i soldi per espropriare. Il piano urbanistico di Napoli è vittima di questo malinteso. Si teorizza la supremazia del pubblico ma poi si scopre che manca il carburante delle risorse finanziarie che dovrebbe alimentarlo.
Napoli città aperta
Il fulcro dell’ambiziosa operazione di trasformazione urbana, cui Bassolino intende legare il suo nome, è la Variante per la zona occidentale Bagnoli-Coroglio redatta dai «ragazzi del Piano». Al posto della più grande acciaieria del Sud Italia, l’Italsider, il simbolo fordista che ha segnato la storia industriale di Napoli per almeno un secolo, sorgeranno palazzi dei congressi, grandi alberghi, parchi e residenze, studios cinematografici, un polo di ricerca in materie ambientali, l’acquario, un porto turistico, una spiaggia attrezzata restituita ai napoletani. Ancora un’occasione sprecata: si potevano coinvolgere esperti stranieri, creare un board internazionale che ne immaginasse le funzioni e poi si mettesse in moto per reperire il capitale in giro per il mondo, e invece, dopo anni di tentennamenti, si sceglierà la soluzione localista, una società comunale, Bagnolifutura, l’espropriazione dei suoli con i soldi dello Stato, manager e consiglieri di amministrazione selezionati in base al manuale Cencelli della politica napoletana: uno a te, un altro a me. Una visione piccola piccola, angusta, di nessun respiro, concentrata sulla difesa degli interessi particolari. Paradossale se si pensa che Bagnoli avrebbe dovuto rilanciare l’immagine di Napoli nel mondo.
Eppure il ruolo della business community globale non sfugge affatto a Bassolino e ai suoi uomini. Nel giugno del 1996, dal trentatreesimo piano della Merril Lynch a New York, scortato dalla mente finanziaria della sua giunta Roberto Barbieri, il sindaco annuncia con soddisfazione che la città di Napoli ha incassato 300 miliardi di vecchie lire dal collocamento sui mercati internazionali dei buoni ordinari comunali: «Napoli e il Sud hanno vissuto a lungo di troppo Stato, hanno rischiato di morire per il troppo Stato. Quest’operazione segna una svolta: Napoli diventa una città aperta».
Sull’onda dell’entusiasmo per la finanza internazionale Barbieri vara nel 1997 la privatizzazione della gestione dell’aeroporto di Capodichino (ceduta agli inglesi della British Airport Authority), una scelta allora ripetutamente citata, a ragione, come esempio di governo al passo con i tempi. Ma la spinta innovativa si esaurisce man mano che il primo mandato si avvicina alla conclusione. Successivamente le torsioni del tempo faranno emergere alcuni degli errori strategici compiuti in quegli anni.
Sul finire della prima sindacatura i giornalisti facevano anticamera al primo piano di Palazzo San Giacomo aspettando che l’uomo del popolo e della provvidenza, l’uomo del riscatto di un Sud divorato dalle «bande dei quattro», parlasse di Bagnoli, della rinascita, di una grande opera che dopo decenni di umiliazioni democristiane non facesse vergognare i napoletani di essere nati a sud di un’idea di civiltà, educazione, solidarietà.
A molti rimase impressa la parola francese che il sindaco ripeteva ossessivamente: loisir. Bagnoli diventerà un luogo di loisir. I napoletani si riprenderanno la loro bellissima spiaggia, la loro storia, un pezzo della loro identità, 330 ettari affacciati sul golfo di Pozzuoli tra le colline di Posillipo e l’isola di Nisida.
Dal 1995 al 2002 per la prima bonifica e lo smantellamento della vecchia fabbrica siderurgica di Stato sono stati spesi 340 miliardi di lire. Nel 2002 nasce Bagnolifutura Spa, la Società di trasformazione urbana (Stu) proprietà del Comune, che nel frattempo ha rilevato i suoli, cui spetta il compito di completare la bonifica e realizzare il piano urbanistico per l’area Ovest, Bagnoli-Coroglio. Molti degli obiettivi orgogliosamente annunciati abortiranno in corso d’opera: il porto sarà cassato dalla Soprintendenza perché interrompe la linea di costa, i lavori per gli alberghi e le residenze stenteranno a partire. Si discuterà inutilmente su dove e come spostare altrove la colmata di Bagnoli, la grande piattaforma a mare di cemento armato costruita dall’Italsider. Costa troppo trasferirla a Piombino, come sostiene la vulgata più accreditata per anni, e la colmata rimane dov’è.
Bassolino prima e la Iervolino poi sembrano non curarsi dell’esasperante lentezza con cui si procede, il loro interesse è concentrato sulla spartizione dei posti nel Cda di Bagnolifutura. La gestione di questa opera fondamentale viene affidata a Mario Hubler, ingegnere senza alcuna competenza in opere così titaniche di dismissione e riqualificazione. Alla presidenza del Cda siedono prima il vicesindaco in pectore Tino Santangelo, di stretta osservanza bassoliniana2 poi, a stretto giro di poltrona, Rocco Papa.3 L’operazione è troppo sofisticata e complessa per un Consiglio di amministrazione che pare improntato soltanto a criteri di spartizione politica. L’unico manager di esperienza collaudata è Carlo Borgomeo, l’ex presidente del comitato della legge 44 del 1986, altrimenti nota come legge De Vito, per la diffusione dell’imprenditoria giovanile nel Sud. Borgomeo transita alla neonata Sviluppo Italia, l’Agenzia pubblica per l’attrazione degli investimenti nel Sud, prima di diventare, nel 2002, amministratore delegato di Bagnolifutura. Nel 2007, cinque anni dopo il suo insediamento, se ne va sbattendo la porta. Ufficialmente lascia per «motivi professionali». Ma con chi lo conosce si abbandona a uno sfogo: «In questa città è tutto inutile: c’è un forte dissenso con il comune sulla missione della società».
L’antiviceré diventa viceré
Bassolino interpreta al meglio il ruolo di sindaco decisionista, ma già al secondo mandato, che scatta nel novembre del 1997, forte di un consenso plebiscitario, scarica uno a uno i tecnici e gli intellettuali che hanno tentato di trasfondere spessore ai suoi annunci sempre più vaghi e ai comunicati stampa sempre più ripetitivi. Alla fine degli anni Novanta, esaurita la bufera di Tangentopoli e la stagione dei sindaci, i partiti riprendono il sopravvento. Quando nel 1998 Bassolino riceve l’incarico di ministro del Lavoro a mezzo servizio con quello di sindaco di Napoli si sente padrone della città e così non rinuncia al ruolo di prestigio a fianco del presidente del Consiglio Massimo D’Alema, nel 1993 alle sue spalle nella gerarchia del Pds e solo cinque anni più tardi segretario degli ex comunisti. La spola tra Roma e Napoli e tra due incarichi così delicati è logorante. L’omicidio, nel 1999, del giuslavorista Massimo D’Antona, suo consigliere fidato, chiude tragicamente la sua esperienza ministeriale e sancisce la fine delle aspirazioni alla leadership nazionale.
A Napoli, nel frattempo, sotto la gestione di Riccardo Marone, numero due a Palazzo San Giacomo per sette anni e poi reggente al tempo di Bassolino-ministro, i problemi si accumulano. Una volta lasciato il ministero, il sindaco reag...