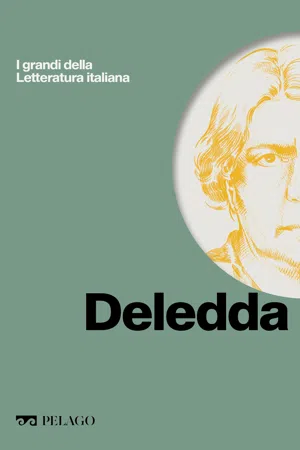
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Deledda
Informazioni su questo libro
Grazia Deledda (prima, e finora unica, italiana ad aver ricevuto il Nobel per la letteratura) ha narrato la sua Sardegna come luogo mitico e come archetipo di tutti i luoghi, terra senza tempo e sentimento di un tempo irrimediabilmente perduto, spazio dell'essere e universo antropologico entro cui si consuma l'eterno dramma del vivere. La sua è stata un'operazione culturale volta alla ricomposizione, attraverso la sublimazione letteraria, di questa identità che supera la separazione storico-culturale dell'isola con il continente per diventare spazio dell'esistenza assoluta. Nei suoi romanzi, in cui sono forti gli echi degli autori russi, convivono l'ineluttabilità del destino e dell'ingiustizia con la coscienza del peccato e dell'errore che si accompagna al tormento della colpa, alla necessità dell'espiazione e del castigo; ma anche un forte vitalismo in contrapposizione all'affanno di questa «lenta morte della vita».
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
LetteraturaCategoria
Didattica generaleIL SUO MONDO E LE SUE IDEE
Grazia Deledda iniziò il suo percorso di formazione nella temperie culturale e morale tipica del villaggio, del microcosmo antropologicamente connotato, con proprie lingue, propri saperi, proprie consuetudini difficilmente traducibili attraverso codici e sistemi segnici di inappartenenza. Mosse i primi passi dentro una comunità educante i cui tipi, miti e archetipi divennero per lei quasi subito fonte di ispirazione e oggetto inesauribile di scrittura.
Come scriveva Carlo Bo, «la Deledda potrebbe vivere senza la Sardegna ma non potrebbe essere senza gli anni della sua formazione in Sardegna, nel mondo chiuso di Nuoro. È a Nuoro che ha cominciato a sentire e in maniera così forte la sua educazione, è a Nuoro che è nata Cosima, forse l’immagine più felice di quella natura che aveva accettato e prima cercato di vivere in un altro mondo. Ecco perché si sbaglia quando la si considera una scrittrice regionale, ecco perché si sta nel vero quando la si coglie nel suo segreto più intimo del grande sogno».1
Durante il periodo nuorese la giovane Grazia indirizzò i suoi scritti verso un universo lontano. Era il «vago immaginar», erano i primi acerbi frutti di letture d’appendice assai di moda in quei tempi, che rappresentavano i tentativi di una ragazza di provincia di presentarsi a un pubblico d’oltremare, quello delle tante Italie da poco riunificate. Era l’opera di trasfigurazione in finzione letteraria di un mondo peculiare e complesso, di una terra-madre ancora incontaminata che, con i suoi “monti-protezione”, era stata nido e presidio ma, in una certa fase, anche limitazione. Quei primi voli incerti divennero ben presto il tentativo di oltrepassare la “finestra-limine” e proiettarsi nel mondo:
“FIGURATI TU UNA RAGAZZA CHE RIMANE MESI INTERI SENZA USCIRE DI CASA; SETTIMANE E SETTIMANE SENZA PARLARE AD ANIMA CHE NON SIA DELLA FAMIGLIA; RINCHIUSA IN UNA CASA GAIA E TRANQUILLA SÌ, MA NELLA CUI VIA NON PASSA NESSUNO, IL CUI ORIZZONTE È CHIUSO DA TRISTI MONTAGNE: UNA FANCIULLA CHE NON AMA, NON SOFFRE, NON HA PENSIERI PER L’AVVENIRE, NON SOGNI NÉ BUONI NÉ CATTIVI, NON AMICHE, NON PASSATEMPI, NULLA INFINE, NULLA, E DIMMI COME PUÒ ESSA FARE A NON ANNOIARSI. I LIBRI... I GIORNALI... IL LAVORO... LA FAMIGLIA! I LIBRI E I GIORNALI SONO I MIEI AMICI E GUAI A ME SENZA DI LORO.2”
Il suo apprendistato letterario iniziò dunque presto, con la lettura delle opere di Enrico Costa, Victor Hugo e François-René de Chateaubriand (che lasciarono nella sua fantasia «una traccia profonda») e da quando strinse rapporti di collaborazione con le tante riviste di consumo che in quel periodo proliferavano ovunque, in Sardegna e fuori. A diciassette anni inviò alla rivista popolare romana L’Ultima Moda, della quale era un’affezionata lettrice, un breve racconto intitolato Sangue sardo. Nello stesso anno, sempre sulla rivista dell’editore Edoardo Perino, uscirono il racconto Remigia Helder e la prima parte del romanzo Memorie di Fernanda. Oltre che straordinarie palestre letterarie, i giornali furono, non meno delle intense relazioni epistolari (nei primi anni si ricordano, tra le altre, quelle con Epaminonda Provaglio, Stanis Manca e Angelo De Gubernatis), importanti canali comunicativi in grado di catapultare all’interno di un più ampio e fecondo reticolo di interscambi.
Dopo le nozze con Palmiro Madesani (celebrate l’undici gennaio 1900 nella chiesa del Rosario a Nuoro) e il rientro a Cagliari, dove il marito temporaneamente lavorava, l’8 marzo di quell’anno i neo sposi s’imbarcarono sul piroscafo Paraguay diretto a Napoli, e da lì in treno verso Roma. Il matrimonio aprì, dunque, la “fase continentale” con l’arrivo nella «Gerusalemme dell’arte», la città tanto amata e tanto agognata («avevo un irresistibile miraggio del mondo e soprattutto di Roma»):
“ROMA ERA LA SUA META: LO SENTIVA. NON SAPEVA ANCORA COME SAREBBE RIUSCITA AD ANDARCI: NON C’ERA NESSUNA SPERANZA, NESSUNA PROBABILITÀ: NON L’ILLUSIONE DI UN MATRIMONIO CHE L’AVREBBE CONDOTTA LAGGIÙ: EPPURE SENTIVA CHE CI SAREBBE ANDATA. MA NON ERA AMBIZIONE MONDANA, LA SUA, NON PENSAVA A ROMA PER I SUOI SPLENDORI: ERA UNA SPECIE DI CITTÀ VERAMENTE SANTA, LA GERUSALEMME DELL’ARTE, IL LUOGO DOVE SI È PIÙ VICINI A DIO, E ALLA GLORIA.3”
Gli anni romani, durante i quali ricercò sollecitazioni molteplici e aggiornò modalità espressive e linguaggi, indiscutibilmente segnarono un punto di svolta nella sua maturazione letteraria. Entrò in contatto con i cenacoli di intellettuali e artisti più conosciuti della capitale. Alla sua formazione etica ed estetica, intellettuale e umana, concorsero da un lato la solida cultura delle origini (agro-pastorale, orale, sardofona), dall’altro la cultura urbana, scritta, italiana ed europea. Queste due componenti prepararono il terreno, non senza interferenze, per le opere più mature, soprattutto dopo la lenta evoluzione che si compì nel vivace ambiente della casa dello scrittore Giovanni Cena, nei salotti della contessa Ersilia Lovatelli Caetani [archeologa, prima donna a entrare nell’Accademia dei Lincei nel maggio 1879 – ndr] e dei coniugi Maraini, nelle case del conte Giuseppe Primoli e dello scultore Giovanni Prini.
Il trentennio compreso tra la metà degli anni Ottanta e lo scoppio della Prima guerra mondiale fu un periodo storico complesso e contraddittorio, nel quale il vecchio convisse col nuovo. Da una parte, infatti, si andò gradatamente diffondendo nella società europea la consapevolezza di vivere in un continente sempre più al centro del mondo. Dall’altra i più avvertiti iniziarono a capire che dietro la belle époque si celava la coscienza della crisi dell’uomo e della società. Una crisi progressiva della cultura naturalistico-positivista e un ritorno di tendenze irrazionalistiche di matrice romantica con la novità, tipica del decadentismo, di un “io” non più indiviso e compatto (come lo era stato quello romantico), ma deflagrato e insondabile nella sua coscienza, relativo e magmatico nella sua identità. Il “male di vivere” divenne ben presto una condizione estesa all’intera dimensione dell’esistenza così come la mancata sintonia tra l’uomo moderno e il suo ambiente di vita.
Anche l’opera della Deledda – soprattutto quella della maturità, oramai lontana dalle concezioni positiviste – rivestì un ruolo importante in questo contesto, grazie alla sua capacità di suscitare nel lettore un bisogno di autenticità, attraverso l’appassionata rappresentazione dell’“automodello” sardo e la proiezione simbolica del suo universale concreto.
Sullo sfondo di paesaggi edenici, carichi di emozioni e suggestioni incantatorie, l’isola è restituita e intesa, infatti, come luogo mitico e come archetipo di tutti i luoghi, terra senza tempo e sentimento di un tempo irrimediabilmente perduto, spazio ontologico e universo antropologico entro cui si consuma l’eterno dramma del vivere.
Tramite la sua operazione artistica la Sardegna entrò a far parte dell’immaginario europeo. Una realtà geografica si trasformò – come scrisse il critico e filologo Nicola Tanda – nella «terra del mito», metafora di una condizione esistenziale, quella del «primitivo», che proprio la cultura del Novecento aveva recuperato come unica risposta possibile al disagio esistenziale creato dalla società industriale e alle angosce dell’uomo contemporaneo di fronte al progresso scientifico.
Certamente ella guardò, soprattutto agli esordi, a una letteratura fin de siècle che si esplicava secondo architetture d’intreccio, configurazioni di trame, ritmi e artifici narrativi derivanti dal feuilleton e dal repertorio del romanzo popolare a puntate. Peraltro alla fine dell’Ottocento, in Sardegna, riscuotevano un grande successo le opere di Enrico Costa («di cui io sono una specie di discepola», diceva) e tanti suoi romanzi, «caldi di amor patrio, pieni d’entusiasmo o di tristezze per le bellezze o per le miserie dell’isola».
Tuttavia, questo spiega poco del portato della sua poetica e della profondità etica e ontologica della sua narrativa. L’uso più o meno sapiente di tecniche e motivi ricorrenti esemplati dal vasto repertorio della tradizione e riadattati in un mutato contesto linguistico e culturale non si risolse mai in un artigianato compositivo fine a se stesso. Se fosse solamente questo, non si comprenderebbe l’enorme successo di pubblico ottenuto dalle sue storie in Europa e nel mondo.
Nei suoi procedimenti scritturali non si trova compiacimento retorico o pura maniera. La Deledda utilizzò l’artificio per raggiungere un fine più alto, più pedagogico.
Perciò la si può considerare figlia ed erede, a suo modo, della grande tradizione umanistica che aveva teorizzato il «mescolare l’utile al dolce» («miscere utile dulci») e l’«insegnare divertendo» («docere delectando»), e costituito il fondamento di un’idea della letteratura da intendersi come arte educatrice con finalità essenzialmente etiche, concepita per insegnare e dilettare, consolare e far riflettere. Dentro quest’ottica si spiega la forza modellizzante espressa su di lei da alcuni autori della letteratura italiana (Manzoni, D’Annunzio, Capuana, Fogazzaro, Serao, Tozzi), francese (Chateaubriand, Hugo, Balzac, Sand, Zola, Bourget) russa (Gor’kij, Čechov, Tolstoj, Dostoevskij) e sarda (Enrico Costa e Salvatore Farina). Ma, soprattutto, fondamentale risultò essere l’ambiente nuorese e la marcata connotazione in senso antropologicoreligioso della sua concezione del mondo e della vita:
“TANTE VOLTE, QUANDO HO PIEGATO IL VISO SULLA VORAGINE SANGUINANTE DELLA VITA, HO RICORDATO IL CURIOSO RITO DEGLI ANTICHISSIMI AVI.”
La Deledda diventò col tempo la più autorevole e raffinata interprete di un’operazione culturale tutta volta alla ricomposizione, attraverso la sublimazione letteraria, di questa identità dimidiata (cultura sarda versus cultura italiana). Durante il periodo nuorese i processi di proiezione verso il continente («A Roma, a Roma!») non si risolsero mai entro uno sterile e angusto orizzonte interno. Certamente la tensione conoscitiva tutta centripeta celava un’idea dell’insularità concepita come limite geofisico (periferia –> centro) che verosimilmente si tramutò per lei in complesso d’inferiorità e in condizione di svantaggio. Ma dinanzi al processo di capovolgimento culturale e prospettico (Interno/Esterno –> Esterno/Interno) posto in essere, durante gli anni romani, da una Deledda più matura e consapevole, l’Isola, nell’atto stesso della creazione artistica, ritornò a essere centro e non più periferia («ogni punto dell’universo è anche il centro dell’universo»), tòpos semantico e archetipo del sentimento lirico, scenario primordiale e ragione fondante della propria riconosciuta universalità, oltre che immagine di una terra e di un popolo consegnata all’Italia e al mondo.
Nelle migliori pagine dell’opera deleddiana si legge della miserevole condizione dell’uomo, «essere-alla morte», e della sua insondabile natura che agisce – lacerata tra bene e male, pulsioni interne e cogenze esterne, predestinazione e libero arbitrio – entro la limitata scacchiera della vita; una vita che è relazione e progetto, affanno e dolore, ma anche provvidenza e mistero:
“IL NOSTRO GRANDE AFFANNO È LA LENTA MORTE DELLA VITA. PERCIÒ DOBBIAMO CERCAR DI TRATTENERE LA VITA, DI INTENSIFICARLA, DANDOLE IL PIÙ RICCO POSSIBILE CONTENUTO.”
La coscienza del peccato e dell’errore che si accompagna al tormento della colpa, alla necessità dell’espiazione e del castigo, la pulsione primordiale delle passioni e l’imponderabile portata dei suoi effetti, l’ineluttabilità del destino e dell’ingiustizia, la fatalità del suo contrario, le manifestazioni dell’amore e dell’odio, visceralmente e autenticamente vissute, segnano la tragica esperienza del vivere di un’umanità primitiva, «malfatata e dolente», «gettata» in un mondo unico, incontaminato, di ancestrale e paradisiaca bellezza, spazio dell’esistenza assoluta.
La Deledda sapeva, in linea con la grande letteratura europea, che la natura umana è altresì manifestazione dell’universo psichico abitato da pulsioni e rimozioni, compensazioni e censure (le opere di Freud e di Jung erano state oggetto di discussione con l’amico Federigo Tozzi e la sorella Nicolina). Semmai, l’idea che quella soggettività chiamata “io” fosse “agita” da qualcosa derivante dal profondo, era stata già di Schopenhauer e di Nietzsche, ma soprattutto, in letteratura, di Dostoevskij e della migliore produzione russa.
La coralità e il policentrismo di alcuni romanzi deleddiani, la loro orditura tematica, l’identità morale e il sistema attanziale dei personaggi, rinviano a capolavori come I fratelli Karamazov e Delitto e castigo (in verità, anche una parte importante della produzione novellistica, attesta vicinanza e corrispondenze a quella sorta di antropologia morale che è il lascito migliore dell’opera dostoevskiana).
E questo paesaggio dell’anima («l’anima moderna con tutte le sue malattie») va inteso come luogo di un’esperienza interiore dalla quale riaffiorano ansie e inquietudini profonde, impulsi proibiti che recano angoscia: da una parte intervengono i divieti sociali, gli impedimenti, le costrizioni e le resistenze della comunità di appartenenza, dall’altra, come in una sorta di doppio, maturano nell’intimo altri pensieri, altre immagini, altri ricordi che agiscono sugli esistenti. Nel gesto d’esistere, accanto allo slancio vitale si accompagna sempre la prostrazione della sofferenza provocata dal male, non di rado sovrastata dall’icona incombente della morte. Eros e Thanatos, pulsione di piacere e pulsione distruttiva – derivante dall’impossibilità di soddisfacimento della prima – convivono in forte contrapposizione dialettica.
L’io narrante, coscienza extradiegetica che media tra bisogni istintuali dei personaggi e contro-tendenze oppressive e censorie della realtà esterna, sembrerebbe rivestire il ruolo del demiurgo onnisciente, arbitro e osservatore neutrale delle complesse dinamiche di relazione intercorrenti tra identità etiche trasfigurate in figure che recitano il loro dramma in un cupo teatro dell’anima.
In realtà il sentimento di adesione o repulsione autorale rispetto a questo o a quel personaggio trova nella religiosità professata e vissuta una delle discriminanti di fondo. Di fronte al dolore, all’ingiustizia, alle forze del male e all’angoscia generata dall’avvertito senso della finitudine («la vita è così breve, che tutte le cose del mondo passano così presto […] i nostri anni, gli anni da passare nel mondo, stanno dentro il pugno di un bambino»), l’uomo può soccombere, giungendo allo scacco e al naufragio, ma può altresì salvarsi, scegliendo il dono della fede e il mistero di Dio («Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma, grande sopra ogni fortuna, la fede nella vita e in Dio»).
Scriveva nel romanzo Elias Portolu: «Deciditi, Elias Portolu, non perder tempo; pensa che dobbiamo morire, che la nostra vita è tanto breve, che abbiamo un’anima sola e che dobbiamo salvarla».
Altri tormenti vive chi, nel libero arbitrio, ha scelto la via del male, lontano dal timor di Dio e dal senso del limite, e deve sopportare il peso della colpa e l’angoscia del naufrago sospeso sull’abisso «del nulla». Si legge nel romanzo L’edera: «Era un dolore senza nome; l’angoscia del naufrago che scende nell’abisso molle e amaro del mare e ricorda i dolori della vita – belli e piacevoli in paragone al mostruoso dolore della morte».
Le figure deleddiane vivono sino in fondo, senza sconti, la loro incarnazione in personaggi da tragedia. L’unica ricompensa del dolore è la sua trasformazione in vissuto. L’imperscrutabile disegno di Dio, «il nostro Padrone» costituisce lo sfondo di una pragmatica degli esistenti che sembrano agitarsi senza muoversi, colti in una sorta di fissità granitica, immodificabili nei loro ruoli e sempre uguali dietro le loro tragiche maschere. La maturazione del personaggio, quando avviene, si realizza significativamente sulla “via di Damasco”, dal buio e dalla cecità del male alla luce e alla rivelazione del bene (errore –> colpa –> con...
Indice dei contenuti
- Collana
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- La più “russa” degli italiani
- PANORAMA
- FOCUS a cura di Dino Manca
- APPROFONDIMENTI
- Piano dell’opera
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Deledda di Dino Manca, AA.VV.,AA.VV., Dino Manca in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Didattica generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.