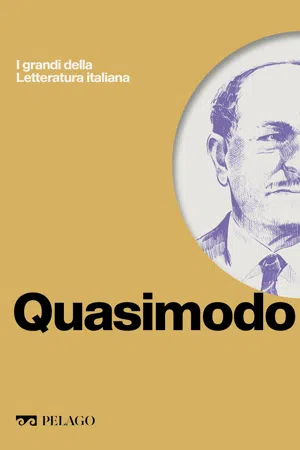
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Quasimodo
Informazioni su questo libro
L'itinerario poetico di Salvatore Quasimodo si è sviluppato da una poesia di stampo soggettivo a una di tipo oggettivo: dalla biografia di sé e della Sicilia con le sue testimonianze di antiche civiltà e i suoi splendidi paesaggi a quella della realtà storica, nel tentativo di cantare per tutti, ma senza porsi come nuovo poeta vate, quanto come testimone di storia vissuta. Con l'andare degli anni negò la poetica fine a se stessa, ovvero il primato della parola pura e assoluta, i monologhi dell'io, considerando invece la lirica come un dialogo drammatico, come «un impegno» a «rifare l'uomo», specie dopo che gli eventi della prima metà del Novecento ne avevano inasprito la condizione universale di dolore e di schiavitù. Il Nobel ricevuto nel 1959 premiò soprattutto questo senso di "civismo poetico", ma fu equivocato da molti critici che destinarono Quasimodo a un oblio progressivo, mentre proprio nel quadro socio-culturale di oggi la sua opera meriterebbe di essere rivalutata.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
LetteraturaCategoria
Didattica generaleIL SUO MONDO E LE SUE IDEE
ITINERARIO DI QUASIMODO
L’esperienza poetica di Salvatore Quasimodo può essere agevolmente suddivisa in due tempi principali. Nel primo, dagli esordi degli anni Trenta al 1942, la voce della sua lirica è autobiografica, ermetica, simbolica e mitica, mentre nel secondo tempo diventa sociale e civile. Si può dire che il passare degli anni – gli anni di una nazione in guerra, anche con se stessa e con la propria storia recente – e l’osservazione della miseria umana con la conseguente presa di coscienza del dolore e del destino di morte che accomunano gli uomini, abbiano condotto Quasimodo da una poesia di stampo soggettivo ad una di tipo oggettivo: dalla biografia di sé e della splendida Sicilia a quella della realtà storica, nel tentativo, più volte praticato dai maggiori poeti italiani, di cantare per tutti.
Per Quasimodo, però, non si è trattato del tentativo di porsi come nuovo poeta vate, quanto di un’esigenza naturale e fortemente maturata con la storia vissuta.
Una maturazione, cioè, di contenuti, ma anche di forme – dunque una identificazione, un riconoscimento, un’evoluzione –, dall’iniziale tendenza al monologo allo sbocco del dialogo, dal verso che suona chiuso come una sentenza («m’è dentro il male vostro che mi scava», Terra, v. 10; «E tutto mi sa di miracolo», Specchio, v. 7; «sono un uomo solo, / un solo inferno», Al tuo lume naufrago, vv. 18-19) alla retorica delle interrogazioni e ai frequenti enjambement, o inarcature del verso (ad esempio: «O neppure la morte ora consola / più i vivi, la morte per amore?», Lettera, vv. 15-16; «Giorno dopo giorno: parole maledette e il sangue / e l’oro. Vi riconosco, miei simili, mostri / della terra. Al vostro morso è caduta la pietà / e la croce gentile ci ha lasciati»,5 Giorno dopo giorno, vv. 1-4), da versi brevi e parole isolate a forme quasi narrative.
Ciò che unisce i due periodi della poesia quasimodiana è la costante raffinatezza del linguaggio, il lavorìo linguistico del poeta, come pure una sua cupa visione dell’esistenza di fronte all’incredibile bellezza della natura, della terra e dell’amore.
Una prima fase (con Acque e terre, Òboe sommerso, Erato e Apòllion e tutte le prove confluite e antologizzate in Ed è subito sera del 1942) e una seconda (soprattutto con Giorno dopo giorno, La vita non è sogno, i libri degli anni Quaranta), due tempi diversi che comprendono un itinerario lungo che attraversa momenti centrali del Novecento – il Fascismo, la Seconda guerra mondiale, la Resistenza, la ricostruzione – e ci consegna un poeta capace di annullare o ridurre «il frastuono della nostra società» consentendoci di ricuperare «spazi silenziosi e assorti, abitati da simboli, miti, archetipi», come ha scritto Rosalma Salina Borello. E poi in grado di farci riflettere sulla storia, sul senso e sul ruolo dell’uomo (e del poeta) in essa.
Un poeta che con l’andare degli anni nega con acute riflessioni di poetica l’art pour l’art, ovvero il primato della parola pura e assoluta.
A suo modo, un lirico in viaggio, sradicato, esule involontario, come scritto sulla targa della casa natale a Modica, che sente il motivo dell’esilio ricercando le perdute origini greche attraverso la poesia del mito o l’esperienza della traduzione, ri-creazione dei Lirici greci (1940), un poeta che ha saputo descrivere e cogliere il dolore e il sentimento di lacerazione dell’uomo indicando la strada alla poesia contemporanea:
“RIFARE L’UOMO, QUESTO È L’IMPEGNO.”
Un lirico impeccabile, e sommo, nella prima fase in cui emerge la nostalgia della sua isola che si fa memoria e canto, con i suoi miti, le stagioni, la terra e l’acqua; poi capace di evolversi dall’iniziale tono ermetico e cantare per tutti, senza eccessi di eloquenza, perché il dramma storico della guerra devastatrice della vita degli uomini, unito alle esperienze dell’occupazione straniera e della Resistenza, come sottolineava Arnaldo Bocelli nel 1968 evidenziandone la preziosa evoluzione stilistica e contenutistica, lo hanno richiamato «dalle atemporali evocazioni di miti e memorie» e condotto all’ambientazione di essi «in determinate situazioni psicologiche e cronologiche (anzi storiche), e insomma all’hic et nunc della responsabilità civile».
Ma c’è anche, come vedremo, una terza fase della poesia quasimodiana, costituita dai tre libri che escono tra gli anni Cinquanta e Sessanta: Il falso e vero verde, La terra impareggiabile, Dare e avere.
Si può aggiungere, in via introduttiva, che Quasimodo ha scritto numerosi discorsi, saggi (Petrarca e il sentimento della solitudine del 1945, Il poeta e il politico e altri saggi del 1960) e traduzioni; che taluni critici hanno visto un’involuzione nella sua poesia postbellica, ma che essa soprattutto, esprimendo un tragico sentimento di vita del nostro tempo, gli è valsa il Nobel; che pochi, infine, conoscono le sue prime prove (specie Bacia la soglia della tua casa e Notturni del re silenzioso, due manoscritti riemersi postumi), forse ripudiate per i facili echi dannunziani e pascoliani, ma non prive anch’esse di momenti felici.
Per capire il mondo e le idee dell’autore, così come il suo stile, la tecnica, la visione politica, faremo riferimento a due elementi essenziali: il paesaggio e la storia entro cui si è svolta la vicenda umana e poetica di Quasimodo.
«LA MIA SIEPE È LA SICILIA», MILANO E ALTRI LUOGHI
Come per altri poeti del Novecento, anche per l’opera di Quasimodo la geografia poetica, il paesaggio, i luoghi hanno un ruolo di primaria importanza. Se infatti non si può capire Montale senza far riferimento alla Liguria, leggere Ungaretti senza pensare all’Egitto, al Carso, a Roma o ai fiumi della sua esistenza, se è impensabile un Saba senza la mitteleuropea Trieste, così non si può fare a meno di valutare il peso e il ruolo che la Sicilia ha avuto nel cuore, nei modi, nei toni, nelle strutture profonde della poesia quasimodiana.
La Sicilia è prima di tutto la terra natale del poeta, ma è anche la terra dalla quale Quasimodo prende a più riprese le distanze dal 1919 in poi, e definitivamente nel 1934, ottenuto come geometra un trasferimento a Milano. È subito, in quegli anni, l’isola distante che si presta al gioco della trasfigurazione poetica, dell’astrazione, della nostalgia come strumento di un viaggio interiore, verrebbe da dire mentale, verso le origini, verso il mito e la natura. È un paradiso perduto e costantemente ridisegnato sulla carta.
Come nella poesia intitolata Strada di Agrigentum dove, fin dal titolo latineggiante, si instaura un rapporto con qualcosa di passato, di trascorso e di assente. E l’avverbio che apre il testo è, infatti, in fortissima contrapposizione con il «dura» che lo segue: il primo, «Là», è il segno della indeterminata distanza e, dunque, dell’inappartenenza sopraggiunta, mentre il verbo assicura, al contrario, una permanenza, un persistere di vento che è frutto del «ricordo» che, in qualche misura, rassicura l’io ormai staccato, lontano da quella strada che è «Là» (vv. 1 e 4-6): «Là dura un vento che ricordo acceso», che scompiglia le criniere di cavalli in corsa sulla pianura e «che macchia e rode l’arenaria e il cuore / dei telamoni lugubri, riversi / sopra l’erba».
Il testo, per fare un esempio, è tratto da Nuove poesie (1936-1942) e testimonia non solo il gusto della memoria e della rievocazione della terra siciliana (e qui in particolare il ricordo va alla splendida Valle dei Templi agrigentina: con i telamoni, queste enormi sculture di giganti abbattute dal tempo e riverse nel prato che rappresentano il simbolo di una civiltà che è scomparsa), ma anche, per riferimento indiretto, per il gioco allusivo, il senso di chiaro sradicamento del poeta esule nella terra lombarda. Il viaggio dell’anima «grigia / di rancori» nella sua terra, il tornare a quel vento, ai suoni e agli ulivi saraceni è connotato «tristemente» nell’espressione drammatica di uno stato di lontananza. L’anima del poeta torna a quel vento, annusa perfino il muschio che riveste i giganti (vv. 11-12 e 14-17): «E più t’accori s’odi ancora il suono / che s’allontana largo verso il mare» e «il marranzano tristemente vibra / nella gola al carraio che risale / il colle nitido di luna, lento / tra il murmure d’ulivi saraceni».
Il disegno del paesaggio siciliano è affidato qui a rapidi, quasi distratti cenni a segni, suoni, umori che fanno capo all’immaginario materiale: l’aria (il «vento» più volte ripetuto), l’acqua («mare»), la terra («le pianure», «l’arenaria», «l’erba», «il delicato muschio» e così via), mentre ciò che è «acceso» nel testo sembra proprio il ricordo di questa immagine, al cui pensiero l’anima («Come sola») siculo-greca, «antica», del poeta si accora, si scalda enumerandone i tratti, seguendo il suono del «marranzano» fino al mare, ai dolci colli sotto la luna.
Strada di Agrigentum è il riconoscimento di un distacco, un quadro, tutt’altro che bucolico o idillico, mosso dal fuoco memoriale che visita e muove lo spazio (modificandolo e accendendolo; consentendogli cioè di essere ancora), come le criniere dei cavalli in corsa, dandoci, in filigrana, un esempio di ciò che sapeva Quasimodo:
“IL POETA SA, OGGI, CHE NON PUÒ SCRIVERE IDILLI.6”
Ciò che s’è voluto mostrare con questa prima lettura è un modo tipico di procedere della poesia di Quasimodo che funziona anche per via di questo particolare ritorno a Itaca.
Più che alla terra promessa, lo sguardo del poeta è volto dentro di sé, per usare un sintagma ungarettiano, al «porto sepolto» dell’io che affonda le proprie radici a Modica, dove Quasimodo nacque, in Sicilia, ma anche alla storia e all’eredità geoculturale e archetipica della regione che rimanda alla Grecia antica.
La Sicilia del poeta è spesso, dunque, un pretesto dove il paese reale trasmuta in un altro dato, simbolico, mitico ed anche psicologico quando a venir alla luce è la sua condizione di esule solitario, oppure la condizione di «Ognuno» come indica la prima parola che sta in cima al libro dei versi di Quasimodo, nella lirica Ed è subito sera.
Il poeta e critico raffinato Sergio Solmi aggiungeva una prefazione a Erato e Apòllion che coglieva alcuni temi centrali della poesia di Quasimodo, riferendosi proprio al senso, il più delle volte solo suggerito nei testi, di una «divisione irreparabile» da un «beato Eden» (l’isola siciliana, una misteriosa città sepolta nel cuore) che «la poesia miracolosamente ravviva nel suo soffio», divisione (e ritorno attraverso memoria e pathos lirico) anche dall’«infanzia» che metaforicamente sta dietro alla Sicilia-Grecia, e che, come prima abbiamo letto del «vento» sulla strada per Agrigento, viene talvolta «risvegliata da un odore di pianta» formando un tema unico e fondamentale dove, scriveva sempre Solmi, «terra e infanzia si confondono in un sogno unico», rivelando come il paese del mito che affiora nel sentimento poetico sia un «paese ancestrale»7 e incorrotto sul quale commisurare, in ultima analisi, la propria solitudine, la condizione di esule involontario, la pena del vivere.
Un altro modo di questo approssimarsi alla terra natale, di questa nostalgia classica e ancestrale come potremmo chiamarla, dal punto di vista della vita e della cultura, è quello compiuto da Quasimodo attraverso l’esperienza della traduzione dei Lirici greci con le loro voci classiche trasportate in una fresca aria di contemporaneità, che, sul piano della tecnica e della storia della poesia, Natale Tedesco ha proposto come un valido espediente per «dotare di forme autoctone» la voce dell’ermetismo italiano.
La Sicilia, come vedremo avanti, è presente in tutta l’opera del poeta con i suoi paesaggi ariosi fatti di alberi, acque, cieli che favoriscono il gioco di specchi di Quasimodo che vi fa emergere le proprie emozioni attraverso l’uso dell’analogia, il ripetersi fitto di echi, in un continuo rimando e confronto tra il microcosmo dell’io e il macrocosmo dello spazio.
Nella prima fase della poesia di Quasimodo prevale quindi una caratterizzazione del paesaggio siciliano come proiezione dell’io. Ed è stato lo stesso poeta a collocare in quest’ottica la sua isola. Nelle pagine di Una poetica (1950) scrive infatti: «La parola isola, o la Sicilia, s’identificano nell’estremo tentativo di accordi col mondo esterno», e «Potrei dire che la mia terra è “dolore attivo”, al quale si richiama una parte della memoria quando nasce un dialogo interiore con una persona amata lontana o passata all’altra riva degli affetti». E poi ancora: «quale poeta non ha posto la sua siepe come confine del mondo, come limite dove il suo sguardo arriva più distintamente? La mia siepe è la Sicilia; una siepe che chiude antichissime civiltà e necropoli e latomie e telamoni spezzati sull’erba», e qui il ricordo va appunto a Strada di Agrigentum, «cave di salgemma e zolfare e donne in pianto da secoli per i figli uccisi, e furori contenuti o scatenati, banditi per amore o per giustizia. Anch’io non ho cercato lontano il mio canto».
Il rimando tra interno ed esterno, mediante il quale il poeta interpreta il mondo e l’uomo, è visibile anche quando nella poesia prende il sopravvento l’irruzione della storia, degli eventi esterni. Essi, specie da Giorno dopo giorno (1947) in avanti, rendono le visioni e le immagini del paesaggio ancora più cupe e dolorose, per esempio in Milano, agosto 1943.
Proprio la città lombarda è l’altro luogo principale della poesia e della vita di Quasimodo: è il luogo della maturità, dove il poeta frequenta caffè e artisti, è la città trasformata dalla guerra, immagine della Resistenza, della solidarietà umana, simbolo di un popolo in lotta: «lontana dalla Sicilia dell’infanzia è anche la città umana dei Navigli, delle nebbie poetiche e fredde» ha scritto Gilberto Finzi. Ma proprio come la Sicilia, anche Milano, luogo geografico, paesaggio sia poetico sia etico – e potremmo concludere che si tratta più di simboli che di luoghi reali –, subirà col tempo una trasformazione nei versi del poeta. La Sicilia diventerà pian piano il pretesto di un doloroso e rancoroso canto contro la miseria umana dell’isola, Milano diventerà la città modello dei consumi e dei bisogni capitalistici: per un Quasimodo orientato alla difesa degli umili, la città sarà il perfetto simbolo di falsi miti, quali il benessere, il progresso.
Attraverso l’esperienza dei luoghi, lo vedremo anche più avanti, Quasimodo prima rintraccia il simbolo della solitudine umana nel concetto di “isola”, ossia di isolamento dell’“uomo solo”, quindi registra i mali storici e infine economico-sociali che mantengono l’uomo in una condizione universale di dolore e di schiavitù.
Nelle ultime raccolte dell’autore si susseguono anche altri climi e luoghi, a volte essi affiorano secondo una «maniera» abilissima di fare versi, ma spesso senza l’urgenza simbolica e poetica consona alla poesia maggiore di Quasimodo, frutto di occasioni e di esperienze di viaggio dell’ultimo decennio di vita a seguito del Nobel.
In conclusione, ciò che preme sottolineare è l’invasiva presenza del paesaggio, siciliano, milanese o più vario, nel quale il poeta ambienta dapprima le vicissitudini dell’io e poi cala le vicende dell’uomo contemporaneo.
L’ERMETISMO E UNA NUOVA POESIA
Il decennio fra 1930 e 1940 vede affermarsi in Italia l’ermetismo. Una corrente poetica, che opera soprattutto a Firenze e che subisce la lezione di Ungaretti, Montale e Quasimodo. L’ermetismo – si pensi a Luzi, Gatto, Sinisgalli fra gli altri – tendeva a liquidare il dannunzianesimo e il pascolismo, era aperto agli influssi del simbolismo, di Mallarmé e Valéry, volto ad usare le parole non tanto nel loro valore comunicativo quanto per restituire loro una primordiale carica espressiva ed evocativa, collocandole, attraverso la rottura più o meno forte dei legami logici, l’uso d’un periodare ellittico ed analogico, in una sfera quasi astorica e atemporale densa di folgoranti e istantanee illuminazioni che finiscono per avere qualcosa di fisso, di ieratico: un nitore classico che pare situarsi fuori dal tempo. Una ricerca della poesia assoluta e pura, per dirla in breve, teorizzata con accezione negativa nel saggio di Francesco Flora del 1936 La poesia ermetica che ne additava l...
Indice dei contenuti
- Collana
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- L’oblio ingeneroso
- PANORAMA
- FOCUS a cura di Roberto Mosena
- APPROFONDIMENTI
- Piano dell’opera
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Quasimodo di Roberto Mosena, AA.VV.,AA.VV., Roberto Mosena in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Didattica generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.