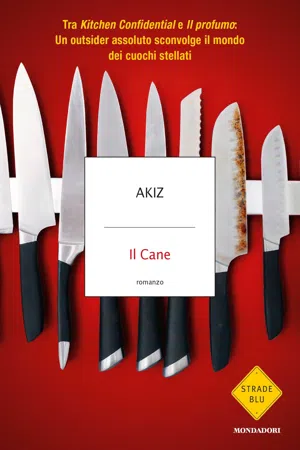Lo chiamavamo il Cane. Il nome gliel’aveva dato Vaslav, credo. Non ho idea, ma penso sia stato Vaslav a cominciare.
«Cane. Qui. Pulire.» Lo stile era questo. Comunque, non c’è voluto molto prima che il ragazzo rispondesse a quel nome e alzasse lo sguardo quando lo chiamavi così.
Per tutti noi il Cane era un enigma. Una specie di sfinge. Una sfinge con gli occhi piccoli – capocchie di spillo, come se dietro le pupille si fosse accumulata una corrente velenosa, bluastra –, e lunghi capelli che bisticciavano sulla sua testa. Il volto aveva un’aria febbrile, avida e governata dall’istinto, quasi perversa, eppure in qualche modo ricordava una statua d’altri tempi, in filigrana. Più di una volta ho visto donne riempirsi di macchie paonazze in faccia, mentre guardavano il Cane di nascosto; se lui non fosse stato così strambo e taciturno, avrebbe potuto averle tutte.
Si diceva che per tutta la sua infanzia fosse stato rinchiuso in un buco sottoterra, al buio, da qualche parte in Kosovo: se sia vero, non lo so. Pare lo tenessero prigioniero sotto una botola e che in quel periodo non abbia visto anima viva. Neanche un raggio di luce. Solo silenzio assoluto, nero come la pece. Il suo unico legame con il mondo esterno era il cibo. Quello glielo allungavano ogni giorno attraverso la botola. Alimenti semplici, resti messi insieme senza amore. Soprattutto pane. Fagioli. Patate. A volte avanzi di carne di pollo.
A poco a poco, in quell’isolamento, le sue papille gustative dovevano essersi sviluppate come il tatto di un cieco: a un certo punto gli riusciva di leggere il cibo come altri esseri umani leggevano il giornale. Pare fosse in grado di sentire se le patate erano state raccolte nei pressi di un’autostrada o se l’animale da cui proveniva la carne era stato macellato senza provare dolore o tra sofferenze atroci. O chi avesse cucinato il cibo. Se era un uomo o una donna. Se lei prima si era lavata le mani, se aveva il ciclo o aveva fatto sesso di recente. Quasi riuscisse a vedere i campi di patate nella fosca luce autunnale come immagini sulla lingua. Le tette sudate della donna dietro i fornelli e le ascelle giallo nicotina dei conducenti di carrelli elevatori nei capannoni di grandi depositi.
Come fosse approdato in città non riuscivi a cavarglielo di bocca, ma qualcuno una volta aveva detto che il Cane, un paio d’anni prima, era arrivato da clandestino sul pianale di un camion polacco. Pare che con sé avesse soltanto una busta di plastica gialla in cui aveva stipato tutti i suoi averi, e se le voci non mentono la cicatrice che aveva in testa gliel’aveva lasciata la mazza da baseball dell’autista del camion che lo aveva scoperto mentre strisciava fuori dal telone.
Quando lo conobbi, doveva avere appena vent’anni, non parlava praticamente mai e, nel caso, solo con frasi brevi, guaste. Non guardava le persone in faccia, ma sotto il mento, sempre, all’altezza della gola, in un punto imprecisato tra il collo e la bocca; solo se qualcosa lo stupiva ti guardava negli occhi, fisso, atterrito, per qualche frazione di secondo appena, come un animale spaventato a morte. Il Cane era un genio. Ed era mio fratello.
Quando lo vidi per la prima volta, l’inverno era finito da un pezzo e le prime sere tiepide dell’anno cominciavano a sciogliere la fredda desolazione della città, i martelli pneumatici dei cantieri suonavano di nuovo più carezzevoli, e lo stridore dei binari della ferrovia non era più così brutale come in prossimità del Capodanno. Le ultime decorazioni natalizie erano state staccate dagli alberi lungo il viale, e una notte, poco prima che facesse giorno, me lo trovai di fronte all’improvviso, nel sottopassaggio davanti al chiosco.
Aveva le mani infilate nelle tasche di un bomber sudicio, e guardava fisso verso di me. Assente. Muto, come se avesse fiutato una pista.
Russe agghindate e strafatte di coca determinate a mettere in salvo il trucco sbiadito prima dell’alba, turisti spagnoli sotto l’effetto dell’ecstasy che si trascinavano a casa con gli zaini in spalla come reduci di guerra con larghi sorrisi e passeggeri di autobus isterici lo guardavano incuriositi. Come spazzatura e relitti alla deriva venivano riversati alla sua destra e alla sua sinistra nella calca, e persino gli zombie nei loro sacchi a pelo puzzolenti di eroina dolciastra e piscio accampati sul ciglio della strada, davanti al negozietto aperto tutta la notte, lo seguivano con sguardi nervosi.
All’epoca io lavoravo con Vaslav da quasi un anno. Fino a poco tempo prima al chiosco vendevamo ancora cibo cinese. In quel momento smerciavamo kebab, börek e polpette. Al calare dell’oscurità, dagli altoparlanti sopra la cassa strillavano sguaiati cantanti pop russi. Vaslav alzava così tanto il volume che i nottambuli stanchi e rintronati venivano attratti dalla musica come da un faro, come le mosche dalla merda, e non potevano far altro che concedersi un’ultima sosta, prima di trascinarsi a casa e collassare sfiniti una volta varcata la soglia, con gli occhi cerchiati di rosso e i pantaloni chiazzati di ayran.
Vaslav chiamò il Cane e gli offrì un kebab. Per averlo avrebbe dovuto pulire la vaschetta incrostata sotto la griglia raschiandola con la spatola. Quello in realtà era compito mio, ma mi era toccato andare a prendere le patatine fritte surgelate nel bagagliaio di Vaslav. Evidentemente il Cane era così affamato che annuì, prese in mano la spatola e attaccò a raschiare. Da quel momento in poi venne ogni giorno. Vaslav gli faceva lavare il pavimento, ungere i recipienti per arrostire e grattare via le merde di cane dalle gomme della sua vecchia Classe S. Vaslav era un brutto personaggio. Quando urlava, spesse vene rosse, grasse come viscidi lombrichi e larghe come avambracci, gli si gonfiavano sul collo, strizzate dal maglione dolcevita nero. E Vaslav, in realtà, urlava sempre. Aveva i capelli corti come nell’esercito. Niente nuca. Se è vero che piove sempre sul bagnato, nel caso di Vaslav doveva essersi trattato di un nubifragio. Il Cane non batteva ciglio. Se Vaslav gli sputava addosso, non si puliva neanche il muco dal retro della giacca, ma continuava a grattare via la salsa giallo-bruna dai secchi di plastica, come se aspettasse in silenzio, stoicamente, il suo momento.
Dall’altro lato della strada, poco più avanti, quella primavera riaprirono l’El Cion. Già da tempo girava voce che il vecchio proprietario fosse stato fatto fuori, il locale rimesso a nuovo dall’estate precedente, e che Valentino fosse tornato in pista come capocuoco. Era stato in galera per due anni: a quanto pare aveva fatto saltare gli incisivi a un cliente perché aveva più volte rimandato indietro il suo cibo. In rete circolava un video in cui l’uomo giaceva a terra, con il labbro superiore gonfio e aperto come una salsiccia alla griglia, e tastava il pavimento con mani tremolanti cercando di ritrovare i denti. Sullo sfondo c’era un tizio con la divisa da cuoco, di spalle era davvero molto simile a Valentino, e qualcuno lo tirava per la manica e cercava di rinchiuderlo in cucina come se fosse un rinoceronte evaso da uno zoo.
Valentino era un colpo mortale per gli esangui e forzati esperimenti di laboratorio della cucina molecolare e per la reazionaria e ormai sorpassata cucina mediterranea. Era un incendio devastante per il gusto, un incidente frontale per i sensi dei suoi clienti: dovevi guardare e affondare i denti, volente o nolente. Dopo il primo morso rigiravi gli occhi all’insù, fino a mostrare il bianco, e quando lo scandaloso ragù o petto di fagiano ti scendeva giù per la gola, grugnivi, gemevi e sospiravi, e gli occhi ti si riempivano di malinconia, prendevi un respiro profondo, mentre il sapore ti tuonava in bocca a tutto volume, un po’ come quando si viene nei pantaloni, e poi sorridevi rasserenato, e scuotevi la testa leggero e ti chiedevi come potesse, un sapore del genere, essere stato creato da un essere umano. Si era tutti d’accordo che Valentino si fosse di nuovo superato e fosse quasi da non credere, e sì, le voci su di lui probabilmente erano vere, qualcuno conosceva un tizio che una volta lo aveva incontrato di persona, e circolavano molte altre storie, ma non adesso, no, per favore, non era quello il momento di parlarne, mai assaggiato il suo salmone in salsa d’arancia e rafano? Leggendario, no, sul serio.
Giovani colleghi di tutto il mondo cercavano di imitare Valentino. Un cuoco newyorkese in Europa, che negli Stati Uniti non avrebbe avuto alcuna chance, sbraitavano i suoi nemici. Uno per cui le celebrità si sarebbero sottoposte a qualunque umiliazione pur di rimediare un tavolo, sussurravano i suoi ragazzi, e si diceva che nella cantina di Valentino fossero custoditi vini per una cifra che si aggirava sui quattrocentomila euro.
L’unico ristorante che poteva competere con la forza fredda, bruta ed elegante dell’El Cion era il Gaspar. Mentre Valentino era in galera, Gaspar era strisciato fuori dal suo nascondiglio, si era avvicinato al trono di Valentino e l’aveva attaccato con rabbiosa ostinazione. Le brigate di cucina dei due ristoranti erano acerrime nemiche, e certi cuochi sostenevano che il cliente cui ora mancavano gli incisivi, quello che aveva fatto riportare il cibo indietro per tre volte, fosse uno del Gaspar, mandato lì e pagato dal cuoco rivale perché rompesse i coglioni a Valentino fino a farlo partire come un razzo di Capodanno.
Il vero motivo della lite fra Gaspar e Valentino, però, risaliva a molto tempo addietro. Anni prima, attraverso diversi canali e intermediari, a Valentino era riuscito di mettere le mani su un tipo di sale davvero esclusivo estratto da monaci tibetani in una miniera himalayana. Di falso sale dell’Himalaya ce n’era a palate. Ma veniva quasi tutto dal Pakistan. Da Khewra. In certi casi addirittura dalla Polonia. Tutta robaccia. Quello, invece, era di una minuscola miniera del passo Khardung La. Si diceva che il sapore fosse indescrivibile. Azzurro, quasi turchese, si sfaldava sulla lingua come neve. I monaci lo chiamavano “Respiro degli dei”. Una volta l’anno, bambini muniti di minuscoli cucchiai lo raschiavano via dalla roccia. Cucchiai piccoli come unghie di pollice. Poi gli anziani del villaggio lo lasciavano riposare per un anno all’aria fresca, fine, pietrosa, resa asciutta dal sole di montagna. Lo si usava solo per le cerimonie rituali. A dire il vero era tabù.
Fin qui, tutto bene. Da un giorno all’altro, però, Valentino non fu più rifornito. Pare che Gaspar avesse fatto sapere ai monaci dell’Himalaya che tipo era. Uno che non prendeva molto sul serio i valori buddhisti, ma tirava di coca come un aspirapolvere e picchiava i clienti, una cattiva persona, capace di ridurre in polpette un’aquila sacra tibetana senza battere ciglio. Da allora il Gaspar era diventato l’unico ristorante in città in cui servissero quel sale. Forse addirittura l’unico nel paese, se non in tutta Europa, a quanto mi risulta. E da allora infuriava la guerra. Da allora tra l’El Cion e il Gaspar scorreva tiepido sangue rosso, untuoso, e adesso nell’ambiente girava voce che Valentino non avrebbe retto a lungo tutto lo stress della cucina, e lui stesso, nel profondo, sentiva che il suo tempo era scaduto, e ormai distingueva i giorni della settimana solo perché leggeva la scritta sugli scomparti del portapillole, e credeva che l’El Cion avesse ormai da tempo passato il suo zenit, vale a dire i primi anni del nuovo secolo. Già, quelli sì che erano bei tempi, all’epoca l’El Cion era ancora un locale all’avanguardia. Ma che Valentino oggi, dopo la riapertura, potesse ancora riallacciarsi al suo vecchio stile radicale erano in molti a dubitarne. Era invecchiato, bastava vedere le sue foto in rete, il suo aspetto, gli ultimi anni lo avevano davvero messo a dura prova, sì, esatto, era proprio quello lì, in alto a sinistra, il tizio con lo sguardo folle abbagliato dal flash era lui, ci si bisbigliava con la mano davanti alla bocca.
E il tempo, in effetti, era trascorso. Nessuno aveva calato una scaletta di corda a Valentino perché potesse rimontare a bordo, la carovana era andata oltre, le voci e le storie su di lui cominciavano a ripetersi, c’era una certa sete di novità.
Da un paio di settimane, però, Valentino era in libertà, e adesso stava nuovamente dietro i fornelli. Ad affiancarlo c’era Lily, la sua sous chef, che aveva trent’anni e ne dimostrava cinquanta. Un’ex tossica con i capelli biondo platino e bulbi oculari gialli di nicotina. Nella sua vita precedente era stata un pitbull, c’erano le prove. Il suo vero nome era Ulrike, ma si poteva chiamarla solo Lily. In mezzo agli occhi, dove Charles Manson aveva la svastica, lei si era tatuata una croce. Lily ci andava giù pesante. Dopo una notte tremenda, forse un paio di anni prima, aveva avuto una rivelazione: le era apparsa Maria, nuda come un verme e con la faccia tutta dipinta, come se stesse andando a battere; Lily all’epoca era in terapia intensiva per via di un’overdose, piena di fili come una marionetta. Maria l’aveva guardata negli occhi, sfiorandola con estrema dolcezza, come a Lily non era ancora mai capitato nella vita, e le aveva sussurrato all’orecchio che lei, Lily, era sua figlia, che doveva piantarla una buona volta con quella merda, e che i suoi genitori erano dei falliti completi, soprattutto suo padre, quel depravato, era proprio uno zero assoluto, e a parte quello lei non si chiamava Ulrike ma Lily, e da quel momento in poi doveva resistere alle tentazioni e smettere di pomparsi dentro schifezze, e che il diavolo aveva migliaia di facce, e si sarebbe appostato ovunque, e lei avrebbe dovuto stare attenta per non farsi rigirare come un calzino. Poi Maria si era dissolta nella pallida aria primaverile della clinica. Le finestre erano spalancate, da fuori arrivava il rumore di un cantiere e dei bambini diretti a scuola; era mattina presto, la porta si era aperta ed era entrata l’infermiera a chiederle se aveva dormito bene: sì, aveva dormito, però non si chiamava Ulrike, ma Lily, e il cartello là davanti, sulla testiera del letto, be’, bisognava subito cambiare il nome scritto sopra.
Da quel giorno Lily era diventata una straight edge, e affinché non nascessero malintesi, si era incisa la X degli edge direttamente sui dorsi delle mani con un coltello per sfilettare. Non beveva, non tirava di coca, non si fumava più neanche una canna, né le sigarette, se facesse sesso o meno non lo sapeva nessuno, e in ogni caso non le piacevano i ragazzi, e non ne faceva mistero. Si faceva più volte al giorno il segno della croce. Prima e dopo il lavoro scompariva nel cesso, si inginocchiava, pregava e ringraziava la Madre santissima, era l’unico posto in cui potesse dialogare con lei a tu per tu. E non si accorgeva nemmeno di stare alla stessa altezza di piscio e merda delle cameriere.
In compenso era fermamente contraria a tutte le forme e i prodotti del satanismo, e per i vari fornitori e lavapiatti con i capelli lunghi e i tatuaggi gotici non c’era davvero molto da ridere quando Lily appariva all’orizzonte.
Lily era sfuggita alla morte per un soffio, e all’El Cion, per la prima volta in vita sua, aveva trovato una casa. Valentino era buono con lei, tutti la rispettavano e apprezzavano il suo rigore, non capitava mai che dalla porta entrasse uno zio ubriaco a tirarle via le coperte, mentre lei poteva colpire i ragazzi col cucchiaio di legno ogni volta che voleva, doveva solo badare a non rendere qualcuno inabile al lavoro o seriamente storpio. La cucina era il regno di Lily, era la sua casa, la sua vita, il suo passato e il suo futuro, custodiva l’El Cion come la luce dei suoi occhi, nessuno doveva nuocere al suo regno, amen. Poi si asciugava le lacrime, tirava lo sciacquone e scendeva nuovamente in pista.
Lily odiava gli stranieri e gli uomini e tutto ciò che aveva un pisello, e gli ebrei e i musulmani, ma non era una cattiva persona, era solo di cattivo umore, sempre, e c’erano cuochi nella sua brigata che avevano paura di essere morsi da lei.
Valentino rappresentava la testa e le palle dell’El Cion, ma Lily era il cuore. Un cuore freddo come una cannula di acciaio chirurgico e duro come l’impiantito di cemento di una camera di tortura. Valentino dipendeva da lei completamente, Lily dirigeva la banda come una galea; se Valentino fosse morto di overdose, lei avrebbe potuto mandare avanti la baracca per giorni, forse addirittura settimane, senza che qualcuno là fuori, dall’altro lato del passe, in sala, là dove non si sentivano le nostre grida, senza che qualcuno di là si accorgesse che Lily gestiva l’attività da sola. Ma se Lily fosse mancata anche un solo giorno, l’El Cion si sarebbe fermato. Valentino avrebbe menato le mani come un pazzo, ci sarebbero stati feriti e lacrime, e niente avrebbe più funzionato. In sala avrebbero chiesto che fine avesse fatto la tartare di tonno ...