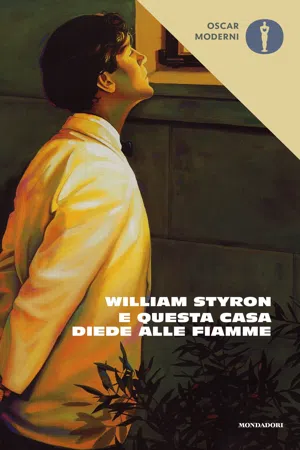Sambuco.
Dell’itinerario Salerno-Sambuco, il volume Italia delle guide Nagel ha questo da dirci: “La strada è tagliata, quasi per l’intero suo percorso, lungo le scogliere della costa. Un panorama sempre vario si spiega dinanzi ai nostri occhi, con scorci continui di mare azzurro, di rocce imponenti e di gole profonde. Si lascia Salerno da Via Indipendenza. La strada piega verso il mare (sotto di noi Marina di Vietri). Si riguadagna la costa, di dove si gode d’una magnifica vista su Salerno, Marina di Vietri, le due rocce (Due Fratelli) e Raito. Dietro un tornante ci appare d’improvviso il pittoresco villaggio di Cetara (7 km). Si torna al mare, poi ci si riaddentra costeggiando il cupo burrone di Erchie, e ci si riaccosta ancora una volta al mare all’altezza di Capo Tomolo. Attraversata una gola dalle alte pareti rocciose, si giunge in vista di Minori ed Atrani, sovrastate dall’alto da Sambuco. Oltrepassata Atrani, la strada cambia direzione e si inerpica per la Valle del Dragone”.
Su Sambuco in specie la guida Nagel è particolarmente lirica: “(m 309) cittadina d’aspetto singolare, in un paesaggio di straordinaria bellezza; estremamente suggestivo il contrasto fra la sua posizione isolata e l’amenità dei dintorni, fra la decadenza dei suoi antichi palazzi e la festosità dei suoi giardini. Sorta nel IX secolo sotto il dominio d’Amalfi, Sambuco conobbe particolare prosperità nel XIII secolo”.
Certo, oggi Sambuco non ha conservato molto dell’antica prosperità; tuttavia, in grazia della sua posizione geografica, si trova senza dubbio in condizioni migliori di tanti altri paesi italiani. Appollaiata in cima allo strapiombo, remota ed eccezionalmente difficile a raggiungersi, è un modello di invulnerabilità, ed è certamente una delle poche località italiane sfuggite ai bombardamenti e alle invasioni di questi ultimi anni. Fosse stata lungo un qualsiasi itinerario strategico, Sambuco non avrebbe avuto tale fortuna, e un giorno o l’altro si sarebbe trovata, come Monte Cassino, ridotta a un’unica orrenda rovina. Invece le operazioni belliche l’hanno lasciata intatta, quasi ignorata, cosicché le sue case, le sue chiese e i suoi cortili, per quanto corrosi dalla miseria, sembrano a paragone di quelli dei paesi circostanti essersi orgogliosamente, e quasi ingiustamente, preservati, come una persona sana e vigorosa in mezzo a un gruppo di reduci stremati e storpiati. Forse fu proprio questo isolamento di Sambuco, questo suo essere rimasta ignara della guerra e degli sciagurati atti di violenza che ne sono il naturale portato, che rese gli avvenimenti di quella non lontana estate così terribili e sconvolgenti per tutti.
Non volendo, per quanto sopra, incorrere fin dall’inizio nell’accusa di una troppo facile ricerca dell’effetto drammatico, dirò subito che questi avvenimenti furono un assassinio e uno stupro, anch’esso seguito da morte, e inoltre una serie di altri casi meno violenti ma non meno sinistri e inquietanti. Tali avvenimenti ebbero luogo, o almeno ebbero origine, al Palazzo d’Affitto (“... un curioso insieme di edifici arabo-normanni, resi particolarmente pittoreschi e suggestivi dalla lussureggiante vegetazione che li circonda. Dal giardino pensile si domina un magnifico panorama”) e coinvolsero parecchia gente del luogo e almeno tre americani. Uno di questi americani, Mason Flagg, è ora morto. Un altro, Cass Kinsolving, è vivo e vegeto, e se questa storia ha un eroe è a lui, ritengo, che spetta tale parte. Certamente non a me.
Mi chiamo Peter Leverett. Sono bianco, protestante, anglosassone, nato e cresciuto in Virginia. Ho appena passato la trentina, e godo di buona salute e d’un aspetto più che passabile, se pur privo di qualsiasi romantico fulgore. Sono di abitudini tranquille, curioso più del normale, e sessualmente molto dotato, per quanto questa sia una presunzione comune a tutti i giovani appena normali. Ho vissuto e lavorato in questi ultimi anni a New York. Senza orgoglio e senza imbarazzo, confesso che sono, per usare la terminologia dei nostri tempi, quel che si dice uno square: un benpensante, un conformista. Di professione faccio l’avvocato. Sono abbastanza ambizioso per desiderare di riuscire nel mio lavoro, ma non sono un arrivista, ed essendo costituzionalmente incapace d’intrallazzi e armeggii, ho idea che rimarrò nella vita a quel livello di dignitosa mediocrità che fu già di tutti i miei antenati, su entrambe le linee dell’albero genealogico. Non lo dico per cinismo, e neanche per affettazione d’umiltà. Io sono un realista, e vi posso assicurare, in ragione della mia esperienza, che la professione legale – anche in un settore scialbo come il mio, che non va oltre i danni civili, i testamenti e i contratti – richiede ipocrisie, raggiri e colpi bassi ai nostri migliori amici, esattamente quanto qualsiasi altro mestiere. No, non è cosa per me. Ormai sono, per così dire, incollato alla mia sorte, e cerco di trarne il massimo piacere possibile. La professione legale non darà forse tante soddisfazioni quante ne dà la carriera del compositore, che un tempo ebbi idea di tentare, ma rende molto molto di più; e inoltre in America nessuno sta a sentire i compositori, mentre la legge riesce sempre a far penetrare la sua musica, sottile a un tempo e maestosa e avvincente, nel cervello degli uomini. O, almeno, a me piace pensarla così.
Alcuni anni fa, al tempo in cui, tornato dall’Italia e da Sambuco, mi ero trovato un impiego presso una società di New York (una società di second’ordine, devo ammettere, e neanche in Wall Street, ma abbastanza vicina da permettere a qualche bell’ingegno del nostro ufficio di suggerire lo slogan “Fate un altro isolato e risparmierete”), alcuni anni fa, dicevo, mi trovavo in condizioni di spirito davvero infelici. La morte di un amico – specialmente nelle circostanze che accompagnarono quella di Mason Flagg, e soprattutto quando ci si è trovati sul posto, quando si è stati testimoni di quel furioso e sanguinoso scempio – non è cosa che si possa facilmente scacciare dal cervello. Questo vale anche se, com’era il mio caso, io mi ero ritenuto totalmente estraneo a Mason e a tutto ciò che egli rappresentava. Della fine di Mason parlerò fra breve, e spero che sarà descritta in tutta la sua necessaria veridicità; per il momento consentite che io mi limiti a dire che quella fine mi aveva ridotto in uno stato di estremo abbattimento.
Per tutto quel periodo non feci che sognare tradimenti e perfidie, e questi sogni mi perseguitavano per tutta la giornata. Ne ricordo uno in particolare, un incubo terribile che, come accade in questi casi, continuava a ripetersi. Mi trovavo in una casa, non so dove, e cercavo di addormentarmi; era notte fonda, una notte fredda e tempestosa. Improvvisamente sentivo un rumore alla finestra, un suono sinistro, distinto dall’infuriare del vento e della pioggia. Guardavo fuori, e scorgevo un’ombra, una figura in movimento, dai contorni indefiniti, la buia sagoma di un intruso che vedevo avanzare verso di me, furtiva e minacciosa. In preda al panico, mi aggrappavo al telefono per chiamare l’amico, che abitava nelle vicinanze (il mio migliore amico, l’ultimo, il più caro dei miei amici: negli incubi tutto è sempre esagerato, tutto al superlativo): era lui, lo sapevo, era lui l’unico abbastanza fidato e abbastanza vicino da potermi venire in aiuto. Ma nessuno rispondeva ai miei frenetici squilli. Allora deponevo il ricevitore, e sentivo un picchiettio sommesso alla finestra, e mi voltavo e vedevo – scoperta ora nella sua demoniaca malignità, dietro il vetro rigato dalla pioggia – il volto sinistro e omicida di quello stesso amico...
Chi mi aveva tradito? O chi avevo tradito io? Non sapevo dirlo, ma ero certo che tutto ciò aveva qualcosa a che fare con Sambuco. E sebbene la fine di Mason non m’avesse granché addolorato – questo è bene metterlo in chiaro subito, una volta per tutte –, pure quanto era avvenuto in quella cittadina italiana ancora mi lasciava depresso, penosamente depresso. Ora, ripensandoci, mi accorgo che quel che mi tormentava era probabilmente un ben molesto sospetto: e cioè che, sebbene io non fossi in alcun modo la causa della morte di Mason, pure avrei potuto fare qualcosa per prevenirla.
La natura, beninteso, sa sempre come comportarsi con i nostri stati d’abbattimento, anche i più feroci. A poco a poco, così impercettibilmente che a malapena me ne rendevo conto, quelle memorie cominciarono ad affievolirsi, a impallidire; e non passò molto tempo che già mi sentivo quasi normale. Tanto che, pochi mesi dopo, addirittura mi fidanzai. Si chiamava Annette, ed era bella, e ricca, anche.
Ma se la mia tristezza si era quasi completamente dissipata, la curiosità di chiarire certi interrogativi restava ancora viva. Sapevo che i resti di Mason, molti mesi prima, erano stati portati via da quell’Italia che lui detestava, e riposavano ora – ammesso che di un Mason, se pur morto, si possa dire che riposi – da qualche parte in terra americana. A Rye, N.Y., mi pare, ma non ha importanza. Sapevo poi che la ragazza italiana che, secondo l’accusa, Mason aveva violentato e percosso, era morta anche lei (l’avevo vista, quella notte, sia pure per pochi secondi; era bella, d’una bellezza assoluta, sconvolgente: e questo credo spieghi molto della tristezza che doveva cogliermi più tardi). E sapevo infine che il caso – la tragedia, come l’avevano definita i giornali di Napoli – era chiuso, e che, coi due protagonisti così decisamente e irrevocabilmente morti, poco c’era rimasto, per le comari o i pettegoli o i semplici curiosi, da inzupparci il pane. Scoprii che anche i giornali di New York non avevano dedicato molto spazio a quella storia – nonostante il nome di Flagg, coi suoi richiami più o meno gloriosi –, forse perché Sambuco era, dopotutto, un luogo assai lontano, ma più probabilmente perché non era rimasto nessuno che potesse esporre la propria infamia e la propria colpevolezza alle luci rapaci della ribalta. Insomma, se si eccettua la particolare circostanza che in quei giorni io mi ero trovato a Sambuco, per molti versi di quello scempio tremendo io non ne sapevo più dell’ultimo arrivato.
Soltanto che qualcosa, invece, io la sapevo; ed era questo che continuava a tormentarmi, anche quando quella cupa malinconia di cui ho detto era ormai svanita da un pezzo. Sapevo qualcosa, e se anche questo qualcosa non era granché, più un forte sospetto che altro, pure fu sufficiente a tener deste la mia perplessità e la mia curiosità per un anno, e forse più. Tuttavia anche questa curiosità si sarebbe senz’altro dileguata dalla mia mente, se non fosse stato per una vignetta del «New York Times» che mi capitò sotto gli occhi, una domenica...
Chiunque abbia mai vissuto solo in un appartamento di New York conosce o ricorda il particolare carattere della domenica. Quel lento risveglio in piena mattina, in mezzo a una città improvvisamente e assurdamente silenziosa, e le tazzine di caffè e quegli ingombranti pesantissimi giornali, e il senso d’indolenza e di noia, e i cortili pieni di sole dove gatti dagli occhi socchiusi rasentano sinuosi i muretti, mentre in aria svolazzano piccioni e la campana di una chiesa lascia cadere nel silenzio malinconici, sconfortati rintocchi. Sono giornate inerti e torpide, dove però s’insinua anche una vaga ma incessante, smaniosa inquietudine, né mai sono riuscito a immaginarne il motivo. Sarà forse che nella più invadente delle città viene momentaneamente ristabilito il diritto di ciascuno alla propria intimità, e le solite domande – “Che faccio? Dove vado?” – si pongono con una insistenza che mai potrebbero avere di lunedì. Quella particolare domenica di cui sto parlando era una domenica di fine primavera, epoca poco propizia alle introspezioni. La mia ragazza se n’era andata a trovare i suoi a Pound Ridge, i miei amici erano fuori città o già occupati, e io mi ero abbottonato il colletto della camicia, e mi disponevo a una solitaria passeggiata per Washington Square quando, per puro caso, mi capitarono in mano le pagine politiche del «Times». Può darsi che in quel primo pomeriggio mi fosse successo di ripensare a Sambuco, di risvegliare antiche tristezze ed eccitare rimpianti e futili recriminazioni. Può darsi. Ma quel che so con certezza è che quando vidi la vignetta, e sotto, inconfondibile, la firma – “C. Kinsolving” – mi balzò il cuore in petto, e mi sentii come scagliato indietro nel tempo verso Sambuco, sospinto di ricordo in ricordo, senza peso, come una foglia. Di nuovo quella storia mi si riversò addosso, ma senza orrore stavolta, senza sudori freddi. Quel pomeriggio non uscii. Osservai meglio la vignetta: era stata riportata da un giornale di Charleston, South Carolina. Esaminai la vignetta e la firma, e presi a passeggiare su e giù per la stanza, fumando sigarette su sigarette, fino a farmi dolere le gengive, e contemplando fuori, nei quieti giardini domenicali (molto presto non ci saranno più giardini, al Greenwich Village), i piccioni, i bevitori di birra in camicia fantasia e i gatti vagabondi. Infine, al calar della sera, quando per tutta la strada l’ora di cena s’annunciava con un tintinnar di stoviglie, mi misi a tavolino e scrissi una lettera a Cass. La finii che era mezzanotte. Non avevo cenato, ed ero stanco morto. Poco dopo l’una uscii di casa, e mi mangiai due hamburger al White Tower, in Greenwich Avenue. Tornando imbucai la lettera – un documento, più che una lettera – che avevo indirizzato a Cass presso il giornale di Charleston.
La risposta si fece attendere molto. Passò un mese, poi ancora qualche settimana, ed ero già sul punto di prendere il coraggio a due mani e scrivere una seconda lettera, quando, un giorno di luglio, mi giunse questa risposta:
Caro Peter,
naturale che mi ricordo di te, e mi ha fatto molto piacere ricevere tue notizie. Hai ragione, anch’io non credo che esistano molti C. Kinsolving. Sono lieto che la mia vignetta ti sia piaciuta e considero una fortuna che ti sia capitato di vederla sul «Times», se non altro perché ti ha spinto a metterti in comunicazione con me e scrivermi una così simpatica lettera. Sono molto fiero di quella vignetta: per quanto io disprezzi la politica in generale, ritengo sia un bello schiaffo all’ipocrisia di Washington. Riguardo alla tua domanda, queste vignette sono solo un’occupazione di contorno, non la mia vera professione: infatti lavoro mezza giornata in una fabbrica di sigari qui a Charleston, e tengo inoltre un corso di pittura, ma ambedue queste attività languiscono un poco verso la fine dell’estate. Tuttavia non disprezzo affatto la caricatura, che è forse la vera Forma d’Arte Americana (non scherzo), e a ogni modo mi considero un diretto discendente di Daumier e Rowlandson. Mettici anche che ci rimedio 35 pezzi a vignetta, e qualche volta anche di più, che non è poi il caso di sputarci sopra. Anche Poppy ha un lavoro, ai cantieri navali, è una specie di contabile, e abbiamo un’ottima donna di colore che bada ai bambini quando non sono a scuola e, insomma, se pure forse non nuotiamo nell’oro come B. Baruch, altro eminente figlio della Carolina, ce la caviamo, non c’è male. Inoltre passo tutto il mio tempo libero a dipingere, e quella paralizzante morte dello spirito di cui tu sei stato testimone è quasi completamente superata.
Peter, volevo sempre ringraziarti per quello che hai fatto a Sambuco per Poppy e tutti noi. Poppy mi ha raccontato tutto, e io dovrei ora chiederti scusa, adducendo magari la magra giustificazione che non sapevo come rintracciarti a New York City. Ma questa sarebbe una bugia, perciò mi limiterò a ringraziarti di nuovo, sperando che tu capisca.
Comprendo benissimo anche il tuo interesse per M. e il tuo desiderio di conoscere più a fondo quella che era la situazione laggiù a Sambuco. Per conto mio, mi riesce molto difficile parlare di M. e di quel che è accaduto, e persino pensarci. Figurati poi scriverne. Eppure, sai, è curioso: allo stesso modo che tu mi dici d’essere all’oscuro di quello che accadde a Sambuco, così anch’io di tanto in tanto mi domando chi era M., voglio dire chi era davvero, e che cosa lo rodeva e come fu che fece la fine che ha fatto. Non credo che nessuno riuscirà mai a vederci chiaro, e sospetto che sia meglio così, da qualsiasi parte si voglia guardare alla faccenda. Non sbagli a “presumere” che siano stati molto brutti per me i giorni passati laggiù. Penso che fossi arrivato molto vicino a quello che comunemente viene chiamato “l’orlo dell’abisso”. Ma ora pare tutto passato. A proposito, sono due anni che non bevo neanche una goccia di birra. Questo fa di Sofocle una lettura molto più facile, e ora ho deciso di buttarmi su Shakespeare, nella speranza di colmare, a questa verde età, le lacune del sistema scolastico degli Stati Uniti.
Se ti capita di passare da queste parti, Peter, fatti vivo. Abitiamo vicino alla Battery, in una casa costruita duecento anni fa che non costa troppo d’affitto e ha un sacco di posto per un ospite. Poppy ti ricorda con affetto, e i bambini pure.
Molti auguri.
Cass
Non ho mai fatto molto assegnamento su quel “Se ti capita di passare da queste parti”, avendolo usato più volte io stesso, in quelle imbarazzanti situazioni in cui il vero sentimento celato dietro la frase risulta fin troppo evidente. È una formula cortese, cordiale, ma non implica certo un invito molto caloroso e insistente. Non è lo stesso del “Mi farebbe tanto piacere rivederti”, ed è distante dal “Ti prego, vieni a trovarmi, sento la tua mancanza” quanto la semplice civiltà lo è dall’amore. Tuttavia nella lettera di C...