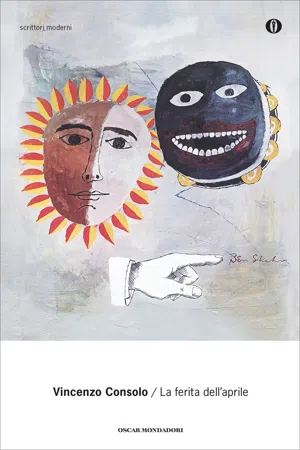Dei primi due anni che passai a viaggiare mi rimane la strada arrotolata come un nastro, che posso svolgere: rivedere i tornanti, i fossi, i tumuli di pietrisco incatramato, la croce di ferro passionista; sentire ancora il sole sulla coscia, l’odore di beccume, la ruota che s’affloscia, la naftalina che svapora dai vestiti. La scuola me la ricordo appena. C’è invece la corriera, la vecchiapregna, come diceva Bitto, poiché, così scassata, era un miracolo se portava gente. Del resto, il miglior tempo lo passai per essa: all’alba, nella piazza del paese, aspettando i passeggeri – malati col cuscino del letto e la coperta, sbrigafaccende, proprietari che avevano a che fare col Registro o col Catasto, gente che si fermava alla marina o partiva col diretto per Messina – e poi, alla stazione, dove faceva coincidenza con l’accelerato delle due e mezza.
Non so come cominciai ad aiutare Bitto, fatto sta che mi vedo salire la scaletta, camminare sopra il tetto per sistemare i colli, lanciargli, al segnale, il capo della corda per legare.
Che posso ricordare di quegli anni di scuola e d’Istituto se li presi controvoglia al primo giorno, se Bitto mi sfotteva per i libri e lusingava con la guida, la corriera, la vita in movimento? Chiedevo anche «biglietto» con a tracolla la borsetta nera, o correvo col cato alla fontana per levare dai vetri il vomito delle donne e dei bambini.
«Ma che vai all’Istituto, a sfacchinare?» chiedeva ma’ vedendomi le mani lorde, la giacca con le macchie.
Come le cose belle, finì la vita sopra la corriera dopo che gli cantarono a zio Peppe di come Bitto m’aveva preso a picciottello. Mi sistemò in una casa ch’affittava e da quel giorno entrai nell’Istituto.
Un buco grande come un pozzo sfregiava il piano superiore verso il mare, alle finestre con le graste sopra le balate, da dove i padri, d’estate, si godono il passeggio della strada, leggendo il breviario nascosti tra le foglie di malvone, come ragazze che aspettano l’amore.
I canali ancora imbiancati di calcina con croci rosse a destra e a sinistra, sulla chiesa e sul teatro, per finta si trattasse d’ospedale. Decisione molto saggia: s’ingannavano gli aeroplani, ma le navi? le navi guardavano in modo orizzontale e il risultato è questo buco grande come un pozzo. Il proiettile era entrato dal signor rettore, aveva sfondato la parete opposta e s’era conficcato nel cortile: la O era scomparsa e la T dell’ISTITUTO pendeva nell’aria per un chiodo. Allora corse voce che tutto il fabbricato s’era sciolto in polverone, ma tornati dallo sfollamento si constatò questo danno poco grave, e siccome i muratori s’erano squagliati come chinino in tempo di malaria, ancora quest’anno sono sul castello a tirare le cardarelle con l’impasto.
Il cortile in discesa, un pezzo di collina digradante: il passovolante, l’altalena, i trampoli, le piastrelle, il liberare. La massacanaglia dei bastasi corre impazzita appresso a un pallone; altri, noialtri, ci spassiamo con l’Oca e col Monòpoli.
Nel mese di dicembre, la seconda quindicina, eravamo in chiesa per sentire la novena. Un freddo per le ossa: pareva un cielo aperto (vento di terra e vento di mare), lo spostamento d’aria aveva fatto zasse dei vetri colorati e i sacchi che ci avevano appuntato sbattevano sul muro come vele. Fortuna che già dai Morti s’era cominciato a far colletta nelle messe per questi vetri d’anteguerra con l’agnello e le palme, la vite e i tralci, la roccia e i sette ruscelli, gigli e margherite. Alle nove, nella bella stagione, andavano ad incrociarsi a mezz’aria raggi d’azzurro al rosa e, con l’incenso, a uno comunicato o che fosse solo in grazia, pareva d’essere tra quelle belle nuvole che sono i paradisi nei santini.
Un freddo! Con la funzione che dura dura, sempre fermi. L’unica era fare l’incensiere, ma può toccare una sera e, aspetta aspetta, può finire magari con lo scarto: innanzi tutto occorre serietà, non ridere a guardare in faccia i compagni quando si viene alle balaustre, il braccio morto e la mano a pigna, tre colpi a destra, tre al centro e tre a sinistra. Ma anche gli accoliti, che tra chiesa e sagrestia andavano e venivano secondo la funzione, potevano approfittare del turibolo, e magari delle sfoglie per l’ostie e del vino. I cantori, sempre quelli, passati al vaglio delle prove con le scale, voce pura e argentina, bellezza dell’anima riflessa negli occhi e nella gola: Tano Squillace in questo portava la bandiera, e pure Vittorio Seminara, eletto di recente presidente dell’Immacolata. È finita quando gonfiano le menne a forma di bottone e il labbro sotto il naso si fa nero, viene una voce nuova incontrollabile che vuole imitare l’uomo e non lo sa: «Il problema più grave nei climi troppo caldi è quello dibattuto dello stato di purezza nel periodo dell’adolescenza».
Quella sera l’incensiere fece un patatràc. Io, per me, l’avevo pensata bene quell’una due volte che mi toccò di farlo (dice che diventavo rosso, e che motivo c’era?), occhi a terra e «Tieni Alfio Cirino e Filadelfio, ahi Alfio Cirino e Filadelfio, povero Alfio Cirino e Filadelfio». Era fatta: inchino, dietrofront, genuflessione e via.
Successe che Costa Benito, il figlio dell’ex custode della camera dell’ex fascio, spuntò nel pomeriggio all’Istituto incignando una camicia verde, e fin qui niente da dire, ma si tradì coi due fratelli dietro, in camicia rossa e bianca (quest’ultima la portava il piccolino grasso e sulle spalle si leggeva chiaro il ricamo scucito dello stemma del re): papapapaaa... attenti! e il Costa capì l’antifona e smandò quei due a casa che quasi piangevano per la pena di perdere un bollino valevole cinquanta per tutta la novena ai fini del cinema Fiat Voluntas Dei Angelo Musco la sera di Natale o Capodanno. In chiesa, in prima fila, Filippo Mùstica (sempre lui era!) si sporse, fece l’imbuto e attaccò:
e la bandiera del tricolore
è sempre stata la più bella
eccetera, e il Costa, ch’avea portato il braccio avanti con la mano a pigna e stava cominciando tieni Alfio, a uso mio, finì di ragionare: le catenelle d’oro gli s’impigliarono nel merletto della cotta e la brace si sparpagliò per i tre gradini del presbiterio. Ahi oh, chi si chinava sotto il banco per sfogarsi, chi si metteva il fazzoletto in bocca. Il Costa, dopo un vano tentativo di raccogliere i tizzoni, se ne scappò in sagrestia. Accorse il sorvegliante, che bada all’ordine e alla disciplina, e fece i psi ehi psi con una faccia che poi mi sentite. Subito ricomposti, si volse l’attenzione al signor rettore che funzionava e all’altare, sopra il quale era stata messa la grotta di cartone nascosta dal sipario viola che sarebbe caduto la notte del ventiquattro al gloria in excelsis con le campane a tutta forza e volontà. La chiesa si fece scura in un momento e solo le candele schiarivano l’altare. Il chierico pedalò con tutta foga e subito ci fu uno stridio e poi le prime note soffiate e il canto dei soprani e dei contralti alternativamente:
«Regem venturum Dominum...»
«Venite, adoremus.»
«Ecce Dominus veniet, et erit in die illa lux magna...»
E la luce non veniva, ci voleva un’altra raffica di vento per scavallare i fili che facevano contatto, ma i cantori con lo scuro parevano più belli: da dove sbucano queste voci, dal cielo, dalla terra, da sotto la pianeta, il piviale?
«Prope est iam Dominus...»
«Veni, Domine, et noli tardare...»
«Veni, et ostende nobis faciem tuam...»
Il cantico finì e l’armonio si sgonfiò come una rana e, nel silenzio, un passo pesante di scarpe chiodate, che a pensarle strisciare sopra il pavimento fanno la pelle rizza, avanzò dal fondo buio della chiesa nel corridoio fra mezzo i banchi. Uuuhhh... fece il vento, e le fiammelle dell’altare rabbrividirono e la luce ritornò di botto. Un soldato alto e magro apparve ai piedi del presbiterio: ahu-là, tutti gli occhi addosso a lui, ma, di spalle, c’era solo l’uniforme, col cinturone largo che pendeva dalla vita sopra l’anca. Alla genuflessione s’accartocciò come un albero d’inverno, poi risorse, svoltò verso destra e la faccia mandò bagliori per via degli occhiali. Svoltò ancora e si mostrò di fronte, ma la gran croce rossa sopra il petto si prese l’attenzione e non lasciò tempo per il resto. Si calò sul gradino della nicchia di San Bosco, aprì il breviario, vi ficcò la testa di cardello, si mise a mormorare.
Cantò forte il signor rettore in tono di capitolo:
«Praecursor pro nobis ingreditur... Ipse est Rex iustitiae, cuius generatio non habet fine-e-em.»
«Deo gratia-a-as» risposero i cantori.
Chi stava più attento alla funzione? Noi dei primi banchi sbirciavamo il militare storcendo gli occhi, ché c’era il sorvegliante che puntava.
Disse Filippo: «Questo è un tenente cappellano. Che cerca, se la guerra ormai finì?».
I cantori attaccarono ancora un inno, un’arietta svelta e scattante che non pareva gregoriano, la si poteva benissimo ballare. E perché no? In sagrestia, uh quante volte, coi moccoli in mano. Io chiudevo gli occhi appena appena, le ciglia si sfioravano, e i cantori sul presbiterio, da un lato e dall’altro, avanzavano cantando al centro a fare il girotondo, le belle sottane rosse e le cotte bianche gonfie di vento, poi si lasciavano scambiandosi i posti, e poi di nuovo, sino all’amen. Dice che gli antichi danzavano e sta scritto che David s’inventava le preghiere cantando e danzando con la cetra in mano. Ma i cantori, lì all’altare, si lasciavano portare parimenti, ondeggiando a tempo le teste.
«Nei suoi angeli e nei suoi santi»: il rettore gli accoliti i cantori se ne entrarono in fila in sagrestia, i fedeli se ne uscirono dalla porta in fondo e noi dell’oratorio e della scuola restammo fermi ai nostri posti per sentire la predica serale del nostro sorvegliante.
Squillace, Seminara e gli altri chierichetti tornarono tra i banchi spogliati delle vesti. Salì il sorvegliante sopra il pulpito, s’aggrappò al davanzale con le mani, si dondolò indietro e avanti, così avanti che quasi si buttava, ci fissò a uno a uno dentro gli occhi, la bocca stretta come una linea di gesso: parla o non parla? la prima parola ci avrebbe aperto il cuore, oh finalmente! Inqualificabili, sciocchi, stupidi, a ridere per un motivo per il quale da ridere non c’era, anzi; scambiare la chiesa pel cortile o il teatro; prepararsi così male al Santo Natale, male. Questo discorso ormai si conosceva, la novità fu il richiamo a Filippo, personale.
«Tu, Mùstica,» e lo puntò col dito «alzati.»
Filippo non era tipo che si perdeva tanto presto, s’alzò molle molle come uno svegliato dentro il sonno.
«E ora dimmi: ci credi o non ci credi che lì dentro c’è nostro Signore?»
Che parole mai faceva il sorvegliante? Filippo allargò le braccia e abbassò la testa per dire «naturale».
«E allora,» tuonò il superiore «perché ti muovi parli ridi, ah? Se tu avessi sempre presente questo... Tu e i tuoi compagni!»
Il tenente cappellano aveva chiuso il breviario, s’era seduto e ascoltava con un sorriso sulle labbra.
Il sorvegliante staccò le braccia dal pulpito e le incrociò sul petto.
«Ed ora, ma non ve lo meritate,» disse «vi do una bella notizia: è giunto in mezzo a noi, assegnato a questo Istituto, un nostro confratello, don Sergio» e sorrise al cappellano. «Don Sergio è un reduce, un cappellano militare che torna dalla guerra. Il Signore è stato buono a volerlo inviare proprio qui. Non sta a me dire chi è don Sergio: imparerete voi stessi a conoscerlo ed amarlo. Ora lo prego di rivolgervi poche parole di saluto.»
Il sorvegliante scese dal pulpito e vi salì il cappellano. Cominciò: «Cari ragazzi...».
Com’era rauco, la voce gli usciva affogata, come di venditore alla fine della fiera.
«Immaginate...»
Perché non sputava...