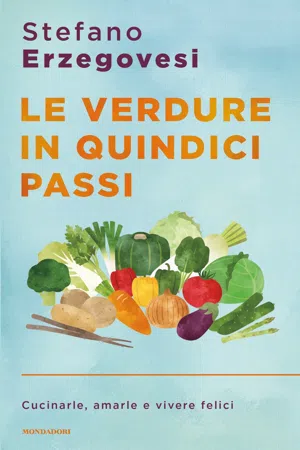Nome scientifico (specie): ASPARAGUS OFFICINALIS L.
Genere: ASPARAGUS
Famiglia: LILIACEAE
Non solo pipì profumata
L’asparago, se non lo conosciamo bene, ci può mettere piuttosto a disagio. Già la puzzettina di zolfo che si sparge per casa, mentre lo cuociamo, non ispira niente di buono. Mettiamoci poi la consistenza sotto i denti, facilmente legnosa e, gran finale, l’odore di pipì tipo fuga di gas – è il metantiolo – che risale dal luogo più segreto di casa.
Tutto ci fa pensare, erroneamente, a qualcosa di ostico da mangiare e difficile da digerire. Per questi motivi, un asparago conosciuto male vorrà dire colori spenti, odori pungenti e consistenze fibrose. E non pensate di essere i soli a conoscerlo male: in moltissimi ristoranti, anche di livello medio/alto, ve li servono così e vi fanno passare la voglia di mangiarli in altre occasioni.
Al contrario, un asparago conosciuto bene – e trattato bene – sarà il cuore pulsante di piatti ricchi di gusto e amici della salute.
Cominciamo quindi ad analizzarlo da vicino. Solo dopo aver fatto questa conoscenza, impareremo a trattarlo bene in cucina.
CARATTERISTICHE
Una grande famiglia
L’asparago appartiene alle Liliaceae, una famiglia molto numerosa che comprende circa settecento specie tra piante ornamentali (come gigli e mughetti) e ortaggi (come la cipolla e il porro, di cui parleremo più avanti).
A causa della presenza dei composti solforati, ottimi per la salute ma troppo odorosi per i nasi sensibili, le verdure della famiglia delle Liliaceae sono tra le più incomprese del mondo vegetale. Il primo scopo che ci proponiamo qui è proprio quello di fare amicizia con le verdure meno conosciute e più trascurate, riportandole a tavola in porzioni generose e in varie occasioni, sia quotidiane sia di festa.
Schiena dritta, testa alta, crescita vigorosa
Cercate su Internet una foto di asparagi che crescono in campo o, meglio, fate una gita in un’azienda agricola e andate a vederli dal vivo.
L’asparago presenta un fusto robusto che sottoterra diventa rizoma1 – simile a una radice – e fuori terra genera i turioni, cioè i germogli, che costituiscono la parte commestibile della pianta e che crescono sodi, belli dritti e a testa alta, come a voler affermare la loro dignità.
Per l’ottima capacità di adattarsi, l’asparago cresce con facilità in climi e condizioni ambientali varie e, se non intervengono malattie, è un vero campione di crescita: può continuare a produrre germogli per ben quindici anni, fatto molto raro nel mondo delle verdure.
È primavera
Di stagionalità primaverile, i turioni di asparago vanno raccolti non appena spuntati dal terreno, per non perdere il loro ottimo sapore, la tenerezza e la carnosità. Proprio dal loro colore dipendono le varietà della pianta: di per sé verdi (come l’80% degli asparagi prodotti in Italia), i turioni possono assumere sfumature bianche o violacee nel momento in cui sono sottoposti a modalità di coltura forzate, che arrestano il naturale processo di sintesi della clorofilla. A questo fine, può essere impedita agli asparagi l’esposizione ai raggi solari attraverso una copertura di terra o di fogli di plastica scura.
Addomesticati e selvatici
Oltre alle specie coltivate, sono molto ricercati gli asparagi selvatici, che si distinguono per il loro aspetto più sottile e per il sapore intenso, dalle connotazioni quasi amarognole.
Ricordiamoci l’empatia per le piante e immaginiamo la fatica in più che deve fare una verdura selvatica: se non è coccolata in una serra riscaldata, né aiutata dall’uomo a liberarsi dai parassiti, dovrà naturalmente produrre da sé molte più sostanze fitochimiche difensive. Sarà quindi più amarognola ma, allo stesso tempo, più ricca di micronutrienti salutari.
ASPETTI STORICI E GEOGRAFICI
Gli asparagi hanno origini molto antiche, e lungo è stato il cammino che li ha portati fino alle nostre tavole.
Mezzaluna fertile
Prime testimonianze della loro coltivazione sono raffigurate sui bassorilievi rinvenuti nella Valle del Nilo, risalenti a più di duemila anni fa; i terreni sabbiosi caratterizzanti le rive dei fiumi Tigri ed Eufrate ne hanno favorito un’ingente produzione in tutta la Mesopotamia, per poi diffondersi in Egitto e Asia Minore e giungere alle coste del Mediterraneo.
Da Roma all’Europa
Gli asparagi incontrarono un enorme successo presso i Romani, ai quali si deve la loro denominazione. Si scelse il nome asparagus per il significato latino di quest’ultimo: «germoglio».
Al gastronomo Marco Gavio Apicio e al suo De re coquinaria (raccolta di ricette di cucina romana compilata nel I secolo d.C.) sono invece da ricondurre i primi cenni e consigli sulle migliori tecniche di preparazione degli asparagi, così da creare un ottimale connubio tra il loro presunto potere afrodisiaco – probabilmente evocato dalla loro crescita «sempre eretta» – e il piacere del gusto.
Al declinare dell’Impero Romano corrispose un calo nella diffusione dell’asparago in tutta Europa, con l’eccezione degli orti di regge e monasteri, dove la pianta continuò a essere coltivata per scopi medicinali (soprattutto come depurativo).
Riscoperti durante il Rinascimento, gli asparagi tornarono in auge soprattutto grazie a Luigi XIV: vero appassionato di questa verdura, il Re Sole ne programmò la coltura sistematica in tutta la Francia, rendendola di conseguenza popolare nell’intero continente europeo. Adesso capite perché i francesi, ancora oggi, hanno il culto degli asperges vertes pochées (asparagi verdi, cotti in acqua bollente), accompagnati da gustosissime – a volte un po’ grasse – salsine.
Ai giorni nostri
Oggi l’asparago è coltivato in molti Paesi del mondo in diverse varietà, che costituiscono spesso specialità locali tutelate da marchi di origine. Se inizialmente l’asparago veniva raccolto una volta spuntato dal terreno, presentando la tipica colorazione verde, il XVIII secolo ha segnato la nascita di nuove metodologie di coltivazione che prevedono la raccolta dei turioni bianchi, caratteristici oggi di molte specialità venete (come il bianco di Bassano del Grappa e il bianco di Badoere) e nordeuropee, o di turioni violacei (come il violetto di Albenga). Le disposizioni legislative europee prevedono una classificazione delle varietà di asparagi strutturata in quattro categorie (bianchi, violetti, violetti/verdi e verdi) alle quali corrispondono spesso qualità e gusti diversi.
Anche qui ricordiamo di provare empatia verso lo sforzo degli amici asparagi nel produrre pigmenti colorati: più sono colorati, più saranno ricchi di fitochimici, salutari ma amarognoli; più sono bianchi, più saranno stati protetti dall’uomo durante la crescita, quindi meno ricchi di fitochimici e più delicati al palato.
COMPOSIZIONE, NUTRIENTI E PROPRIETÀ
Depurativi, ma anche… muscolosi
La composizione chimica di 100 g di asparagi è:2
- acqua 91,4%
- fibre 2,1%
- proteine 3,6%
- carboidrati 3,3%
- grassi 0,2%
Colpiscono in primis lo scarso contenuto calorico – meno di 30 kcal per 100 g, proprietà comune a tutte le verdure che tratteremo in questo libro – e la ricchezza d’acqua, che dona effetti depurativi e che è ugualmente tipica di quasi tutte le verdure.
La caratteristica, invece, più atipica per una verdura è la discreta ricchezza di proteine. Una tipica porzione di asparagi da 200 g – mi raccomando, siate sempre abbondanti con le porzioni di verdure! – apporta 7 g di proteine, niente male per una verdura.
Oltre alle proteine, gli asparagi sono ricchi di preziosi micronutrienti. Ne vedremo alcuni nei prossimi paragrafi.
Sotto il verde c’è il giallo: caroteni e vitamina A
Fateci caso quando avete dimenticato per troppo tempo una verdura verde in frigorifero: la clorofilla si degrada e il verde piano piano se ne va. Ma, passato il verde, spunta un altro colore, con mille sfumature tra il giallino e l’arancio: sono i preziosi carotenoidi, potentissimi antiossidanti amici della pelle, degli occhi e delle mucose respiratorie, e che, quando serve, possono essere trasformati dal corpo nella altrettanto preziosa vitamina A.
La vitamina A (chiamata anche retinolo) è una vitamina liposolubile (solubile nei grassi), caratteristica propria di quelle vitamine che, per essere ben assimilate dall’organismo, hanno bisogno di un po’ di condimento grasso. Per questo, nel caso di verdure ricche di carotenoidi, vi consiglierò sempre l’aggiunta di olio extravergine d’oliva, di semi oleosi, frutta a guscio o altri grassi buoni.
La vitamina A ha un forte potere preventivo delle infezioni perché rinforza l’effetto-barriera delle mucose. Garantisce anche un nutrimento per le cartilagini e le ossa, gli organi digerenti, i vasi sanguigni, e la pelle, agendo da fattore di ringiovanimento.
A proposito di barriere utili, la vitamina A è essenziale per un corretto funzionamento della vista grazie alle sue proprietà antiossidanti, che aiutano la retina a proteggersi dai danni causati dai radicali liberi.
La carenza di vitamina A può avere gravi conseguenze, dall’arresto della crescita alla bassa resistenza alle infezioni, dall’insorgere di alterazioni a livello cutaneo alle lesioni oculari. Quindi rimaniamo belli carichi di vitamina A di origine vegetale, mangiando spesso un’ampia varietà di verdure verdi scure o giallo-arancioni.
Vitamina B1 e cervello energetico
Al contrario della vitamina A, le vitamine B sono idrosolubili (solubili nell’acqua) e non possono essere accumulate dal nostro corpo; facilmente eliminate dalle urine, queste vitamine necessitano di una regolare assunzione attraverso il cibo.
La vitamina B1 (o tiamina), contribuendo al processo di conversione degli zuccheri in energia, ricopre un ruolo di primo piano nell’equilibrio dei processi energetici dell’organismo, rilasciando a quest’ultimo il «carburante» necessario per svolgere le sue attività quotidiane.
La vitamina B1 è quindi fondamentale per la regolazione dell’equilibrio nervoso, stimola l’appetito e i movimenti dell’intestino, oltre a favorire l’assorbimento dell’ossigeno da parte delle cellule. Ricordiamo che il beriberi, una grave malattia da prolungata carenza di tiamina, comporta pesanti danni a livello del cervello, del cuore e dei nervi periferici.
Grazie alla presenza di questa vitamina, gli asparagi saranno quindi gli alleati ideali contro nevriti, palpitazioni, disturbi della memoria, astenia fisica e mentale e stitichezza.
⚠ Attenzione, però, a come conserviamo e cuociamo gli asparagi: la vitamina B1 è solubile nell’acqua ed estremamente sensibile al calore, quindi è consigliabile conservarli al buio del frigorifero e in sacchetti opachi. Ancora più importante è cuocerli in maniera rispettosa del loro colore e delle loro vitamine idrosolubili: non sciacquiamole via con la bollitura ma, come vedremo pi...