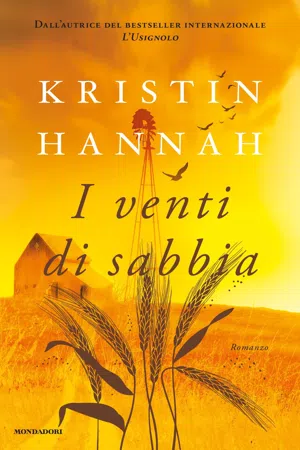L’ultimo giorno di gennaio un fronte gelido raggiunse la valle e vi restò per sette giorni. Il terreno si indurì e ogni mattina la nebbia avvolgeva ogni cosa per ore. Continuava a non esserci lavoro.
Anche se i loro risparmi andavano sempre più assottigliandosi, Elsa era consapevole di quanto fossero fortunati rispetto ad altri: avevano risparmiato i soldi della raccolta del cotone ed erano soltanto in tre. I Dewey avevano sei bocche da sfamare, che presto sarebbero diventate sette. I migranti appena arrivati, quasi tutti senza un soldo in tasca, cercavano di sopravvivere con gli aiuti del governo, misere quantità di cibo distribuite ogni due settimane. Tiravano avanti a frittelle fatte con acqua e farina e pasta di pane fritta. Elsa vedeva chiaramente i segni della denutrizione sui loro volti.
Quella sera, dopo che ebbero cenato con una tazza di fagioli acquosi e una fetta di pane cotto in padella ciascuno, Elsa si sedette su un secchio capovolto accanto alla stufa a legna con la cassetta di metallo aperta sulle gambe. Ant prese posto accanto a lei dando il suo morsettino quotidiano alla barretta di cioccolato Hershey di Natale. Loreda era nella tenda a rileggere Nancy Drew e il passaggio segreto.
Elsa contò di nuovo i soldi.
«Elsa! Ci siamo!»
Sentendo Jean gridare il suo nome, si alzò talmente in fretta che per poco non rovesciò la cassetta del denaro.
Il bambino.
Ant sollevò lo sguardo. «Che succede?»
Elsa corse nella tenda a nascondere la cassetta. «Loreda, vieni con me» disse.
«Dove…»
«Jean sta partorendo.»
Si precipitò alla tenda dei Dewey. Trovò Lucy fuori, in lacrime. «Loreda, porta le bambine da noi. Di’ loro di stare con Ant e di non tornare fino a quando non andrai a prenderle. Poi vieni a darmi una mano.»
Entrò nella tenda buia e umida. Il bagliore dell’unica lanterna accesa riusciva a stento a dissipare le ombre. Vide alcune sagome grigie nell’oscurità: provviste accatastate, un lavandino di fortuna.
Jean era su un materasso appoggiato per terra, sdraiata sul fianco, immobile come un respiro trattenuto.
Elsa le si inginocchiò accanto. «Ehi» disse accarezzandole la fronte umida. «Dov’è Jeb?»
«A Nipomo. Sperava di raccogliere piselli.» Jean ansimava. «Qui c’è qualcosa che non va, Elsa.»
Lei sapeva cosa significavano quelle parole, come lo sapevano tutte le donne che avevano perso un figlio. Il sesto senso di una madre era forte in momenti del genere.
Loreda entrò nella tenda.
«Aiutami a tirarla su» le disse Elsa.
Insieme fecero alzare Jean, che si appoggiò pesantemente a Elsa. «Ti porto all’ospedale» disse lei.
«Non… serve.»
«Sì che serve. Qui non stiamo parlando di un bambino con la tosse o la febbre, Jean, ma di un’emergenza.»
«Non… mi…» Il viso di Jean si irrigidì al sopraggiungere di un’altra contrazione.
Elsa e Loreda la sistemarono sul sedile del passeggero del furgone. «Bada ai bambini, Loreda.»
Elsa avviò il motore, accese le luci e in un attimo sfrecciò via. Andava troppo veloce, facendo sferragliare il furgone sulla strada di fango.
«Non riesco…» disse Jean aggrappandosi al bracciolo. «Portami… indietro…»
Un’altra contrazione.
Elsa svoltò nel parcheggio dell’ospedale, illuminato da costose luci elettriche, e pestò il piede sul freno. «Aspetta qui. Vado a chiamare aiuto.»
Corse dentro, si precipitò lungo il corridoio e si fermò al bancone. «La mia amica sta partorendo.»
La donna alzò lo sguardo, aggrottò la fronte e poi arricciò il naso.
«Sì, lo so, puzzo. Sono una sporca migrante. L’ho capito. Ma la mia amica…»
«Questo ospedale è per i californiani. Sai, quelli che pagano le tasse. Per i cittadini, non per i vagabondi che pretendono soltanto di essere curati.»
«Su, sia umana, per favore…»
«Tu? Stai davvero chiedendo a me di essere umana? Per favore. Guardati. Voi donne sparate fuori bambini come tappi di champagne. Trovati uno di voi che ti aiuti.» Finalmente la donna si alzò. Elsa vide che era ben nutrita, con i polpacci in carne. La donna infilò la mano in un cassetto e tirò fuori un paio di guanti di gomma. «Mi dispiace, ma le regole sono regole. Posso soltanto darti questi.» E le porse i guanti.
«La prego, laverò i pavimenti, pulirò le padelle degli ammalati. Qualsiasi cosa. Lei però la aiuti.»
«Se è davvero così grave, perché sprechi tempo a implorarmi?»
Elsa afferrò i guanti e tornò di corsa al furgone.
«Non vogliono aiutarci» disse a Jean a denti stretti salendo a bordo. «I bravi californiani timorati di Dio se ne fregano della vita di un bambino.»
Tornò all’accampamento il più in fretta possibile, con la collera intrappolata dentro di lei che le serrava la gola.
«Sbrigati, Elsa.»
Una volta arrivata, Elsa aiutò Jean a entrare nella sua tenda fredda e umida.
«Loreda!» gridò.
Lei accorse e andò a sbatterle contro. «Perché siete già tornate?»
«Ci hanno mandate via.»
«Vuoi dire…»
«Vai a prendere dell’acqua. Tanta. E falla bollire.» Poi, vedendo che sua figlia non si muoveva, gridò: «Sbrigati!». E Loreda corse via.
Accese una lampada a cherosene e fece coricare l’amica sul materasso per terra.
In preda a spasmi di dolore, Jean stringeva i denti per non gridare.
Elsa si inginocchiò accanto a lei e le accarezzò i capelli. «Forza, grida.»
«Sta arrivando» disse Jean tra un respiro affannoso e l’altro. «Tieni… i bambini… lontani. Le forbici sono… in quella scatola. E c’è anche del filo.»
Un’altra contrazione.
Guardando la pancia di Jean contorcersi, Elsa capì di avere poco tempo. Tornò di corsa alla sua tenda e ignorò gli occhi spaventati dei bambini. Non c’era tempo per rassicurarli.
Dopo aver agguantato una pila di giornali messi da parte, corse di nuovo alla tenda di Jean e li posò per terra, grata che fossero relativamente puliti.
I titoli le passavano davanti agli occhi. Epidemia di tifo nell’accampamento dei migranti.
Elsa aiutò l’amica a rotolare sui giornali e indossò i guanti.
Jean gridò.
«Forza» disse Elsa inginocchiandosi accanto a lei e accarezzandole i capelli bagnati.
«Ci siamo!» gridò Jean.
Con movimenti rapidi, Elsa si mise tra le gambe aperte di Jean. La testa fece capolino, coperta di umori, blu. «Vedo la testa. Spingi.»
«Sono troppo…»
«Lo so che sei stanca. Spingi.»
Lei scosse la testa.
«Spingi» ripeté Elsa. Alzò lo sguardo e vide la paura negli occhi dell’amica. «Lo so» disse. Capiva davvero quanto Jean temesse quel momento. I bambini morivano nelle circostanze migliori, e quelle erano indubbiamente le peggiori. A volte però sopravvivevano contro ogni aspettativa. «Spingi» ordinò di nuovo, contrapponendo alla paura di Jean una sommessa speranza.
Il corpicino uscì di colpo, in un fiume di sangue, e atterrò tra le mani guantate di Elsa. Troppo piccolo, filiforme quasi. Più piccolo di una scarpa.
Blu.
Elsa sentì un ruggito di rabbia gonfiarsi dentro di lei. “No.” Pulì il sangue dal visino minuscolo, dalla bocca, e implorò: «Respira, piccola».
Jean si issò sui gomiti. Persino lei sembrava non riuscire a respirare da tanto era stanca. «Non respira» disse con un filo di voce.
Elsa cercò di aiutare la bambina. Respirazione bocca a bocca.
Nulla.
Diede un colpetto al minuscolo sedere blu e disse di nuovo: «Respira».
Nulla.
Nulla.
Jean indicò un cestino di paglia con dentro la morbida coperta color lavanda.
Elsa srotolò il cordone ombelicale e lo tagliò, poi si alzò lentamente in piedi. Debole. Tremante. Avvolse la minuscola creatura immobile nella coperta.
La porse all’amica con gli occhi annebbiati dalle lacrime. «Una bambina» disse, e lei la prese con una delicatezza tale che a Elsa si spezzò il cuore.
Jean le baciò la fronte blu. «La chiamerò Clea, come mia madre.»
Un nome.
L’essenza stessa della speranza. Il principio di un’identità, dato con amore. Elsa si allontanò dalla vista straziante di Jean che sussurrava all’orecchio blu della piccola.
Fuori, Loreda stava camminando nervosamente avanti e indietro.
Elsa guardò sua figlia, vide la domanda dentro i suoi occhi e scosse la testa.
«Oh, no» disse Loreda, e le sue spalle si afflosciarono.
Prima che sua madre potesse cercare di consolarla, lei si voltò e scomparve nella loro tenda.
Elsa rimase lì, immobile. Quell’immagine orribile, tremenda, di un bambino che veniva al mondo su fogli di giornale spiegazzati sulla nuda terra, sarebbe rimasta per sempre impressa nella sua mente.
“La chiamerò Clea.”
Come aveva fatto Jean a trovare la forza di parlare?
Sentì le lacrime arrivare e prendere il sopravvento. Pianse come non piangeva da quando Rafe l’aveva lasciata, pianse fino a quando non ci furono più lacrime dentro di lei, fino a sentirsi prosciugata come la terra che si erano lasciati alle spalle.
Poco dopo le dieci, Loreda finì di scavare la piccola buca e lasciò cadere la pala.
Erano in un’area circondata da alberi piuttosto distante dall’accampamento. Un posto buio come l’umore de...