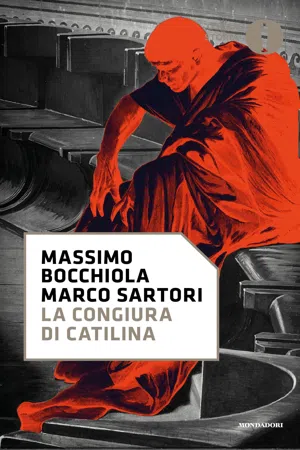Tra le varie fonti della cosiddetta prima congiura di Catilina il racconto più vicino alla data del 66 è di un contemporaneo, lo storico senatorio Tanusio Gemino. Crasso convoca in casa sua un gruppo di uomini a lui legati e con loro progetta per l’inizio dell’anno 65 un attentato di inaudita gravità: attaccare il senato ed eliminare i consoli, insieme con un certo numero di avversari politici già individuati.
Tra i convenuti nella dimora di Crasso ci sono i due consoli designati nelle elezioni del 66: Publio Cornelio Silla, nipote del dittatore, e Publio Autronio Peto, entrambi «popolari», che sono stati privati della somma carica in quanto condannati per corruzione elettorale. A loro va restituita la dignità consolare cosicché possano fare Crasso dittatore secondo una prassi costituzionale corretta che prevede sia il console a nominare questo magistrato.
Crasso a sua volta avrebbe scelto l’allora trentacinquenne Cesare, a lui legato a quell’epoca, come suo magister equitum, vale a dire come suo vice. L’antica e venerata carica di dittatore (un potere militare quasi assoluto per sei mesi in casi di estrema gravità: la carica che era stata di Cincinnato e di Fabio Massimo il Temporeggiatore) aveva perso ogni aspetto militare nel II secolo. Tuttavia Silla l’aveva restaurata attribuendole un significato di riforma costituzionale, e come tale sembrava il grimaldello per scardinare il conservatorismo delle classi dirigenti romane. Un ritorno al passato, insomma, per aprire al nuovo.
Come spesso accade nelle congiure, anche questa, che avrebbe prodotto un massacro, affoga nel ridicolo. Tanusio infatti aggiunge che il giorno stabilito Crasso, «perché si era pentito o perché aveva paura», non si presentò in senato. Cesare di conseguenza non diede il segnale convenuto con gli altri congiurati, cioè il gesto naturale di lasciarsi scivolare la toga dalla spalla.
Altre fonti dicono che uno dei congiurati, il giovane Gneo Pisone – uno di quei giovani audaci, privi di mezzi e corrotti che sono un po’ il modello antropologico del congiurato – avrebbe dovuto provocare incidenti in Spagna, mentre Cesare avrebbe fatto lo stesso a Roma, e che ci sarebbe stato l’intervento dei Galli Ambroni e dei Transpadani. A Pisone fu attribuito straordinariamente il governatorato della Spagna, con il motivo, inverosimile, di allontanarlo da Roma proprio perché aveva congiurato. In Spagna Pisone fu ucciso.
1° gennaio 65 a.C., Campidoglio
Una congiura alquanto strana dunque. Ma ancora più singolare risulta in un altro racconto, quello di Sallustio. Perché il perno dell’azione sembra essere non tanto Crasso quanto appunto Catilina, come vuole il resoconto, «verissimo», che lo storico inserisce come digressione nel più ampio svolgimento della congiura vera e propria.
Il 5 dicembre 66 Catilina e Autronio mettono a parte Pisone (e sicuramente un gruppo di altri che troveremo tra i complici della congiura del 63) del progetto scellerato di uccidere entrambi i consoli il 1° gennaio 65 durante le affollate cerimonie di inaugurazione del consolato.
Queste cerimonie si tenevano in Campidoglio. Qui i consoli, scortati dai littori, salivano in una lenta processione con amici e conoscenti. Erano attesi dal segno del loro potere, il seggio ufficiale, la sella curulis. Sempre sul Campidoglio ringraziavano Giove per la protezione accordata alle cose pubbliche nell’anno appena trascorso e infine offrivano un sacrificio di buoi bianchi al dio, raccomandando ugual sacrificio ai loro successori per l’anno dopo.
L’occasione era delle più solenni, e poteva essere strumentalizzata e costituire un momento di particolare tensione perché il popolo vi faceva sentire la sua voce e le sue volontà.
Un esempio di che cosa potesse accadere durante quei riti pubblici ci è offerto da quanto si verificò qualche anno dopo, nel 58. Il 1° gennaio di quell’anno gruppi di plebei mossi dai capi popolari (Clodio, sopra tutti) e legati alle corporazioni religiose e di mestiere cercarono di rendere pubblico il culto – fino a quel momento privato – della dea egiziana Iside e di associarlo alle divinità tradizionali alle quali proprio in quell’occasione si rivolgevano i voti della comunità. Si voleva approfittare del fatto che quell’anno la festa mobile dei Compitalia (la festa delle divinità tutelari dei compita, gli incroci) coincideva con quella data, e ai Compitalia – come ai Saturnalia a essi legati – partecipavano oltre alla plebe anche gli schiavi, «per servire meglio gli dei».
Su ordine del senato il console Gabinio si oppose a questa richiesta dei popolari rifiutandosi di sacrificare alla dea insieme con le altre divinità. Inoltre gli altari eretti per la nuova dea furono rovesciati.
Ritorniamo al racconto di Sallustio. Una volta impadronitisi dell’antico segno del potere consolare, i fasci, i congiurati avrebbero inviato Pisone in Spagna con un esercito. Ma il piano è scoperto e, dato che non vi sono ripercussioni per i congiurati (un fatto all’apparenza sconcertante, su cui avremo modo di tornare in seguito), viene riproposto un mese dopo, per il 5 febbraio.
In quella data il senato avrebbe dovuto essere scenario della strage non solo dei consoli, ma anche della maggior parte dei suoi membri. Anche questo nuovo atto criminoso tuttavia fallisce perché Catilina dà prematuramente il segnale – anche questa volta un segnale! – ai complici che non sono ancora accorsi in numero sufficiente davanti al senato.
I congiurati sono comunque in numero esiguo. E anche se Machiavelli dice che una congiura ha poche possibilità di procedere se ne sono al corrente più di due o tre uomini, questi falliscono anche la seconda occasione. Un gruppo di improvvisatori malaccorti, quindi? Forse. Ma forse anche questo tentativo si era risaputo, perché secondo lo storico di epoca imperiale Dione Cassio il senato aveva dato una scorta ai consoli per timore di attentati.
Quanto a Pisone, che appare come la punta di diamante della congiura, si reca in Spagna come questore con funzione di governatore grazie all’appoggio di Crasso. Uomo di Crasso, dunque, in opposizione a Pompeo: cosa che la longa manus di Pompeo in quella provincia gli fa pagare. Pisone mostra modi arroganti e crudeli come solo un magistrato romano di età repubblicana può esibire di fronte ai provinciali, e viene ucciso da cavalieri spagnoli che servivano nell’esercito di Roma.
Questa seconda versione dei fatti viene per certi versi confermata da Cicerone in un’orazione (del 62) nella quale difende proprio uno dei due consoli decaduti, Cornelio Silla, dall’accusa di aver partecipato alla congiura. La responsabilità principale sembra tutta di Catilina, insieme ad Autronio, Pisone e Vargunteio (che comparirà ancora nel 63) e di coloro che li avrebbero ispirati, Crasso e Cesare, il quale aspirava nientemeno che al regno. Ma a quella data Catilina e i catilinari di cui l’oratore fa il nome non possono più nuocere.
Un mondo di congiure
I due racconti presentano aspetti contrastanti e per certi versi bizzarri, tanto che non sembra possibile dare una ricostruzione corretta e precisa della congiura. Solo per restare alle differenze più macroscopiche si può notare che cambiano gli attori, perché in Tanusio Gemino troviamo protagonisti Crasso e Cesare che aspirano alla dittatura con la morte dei due consoli, mentre in Sallustio è Catilina insieme ad Autronio e Pisone a dirigere le mosse dei congiurati e ad aspirare al consolato; per di più è ancora Catilina a rinviare l’attentato, che viene così ripetuto, ed è Catilina e non Cesare a mancare il segnale convenuto. Per Sallustio Cesare è assente e Crasso ha una parte solo nell’invio del giovane Pisone in Spagna per tranquillizzare i benpensanti, e nello stesso tempo come difesa da Pompeo.
Le oscurità sono ancora più gravi. Quella che lascia più perplessi è il silenzio e la mancata reazione del senato di fronte a uno, o due, tentativi di eliminare entrambi i consoli: perché non solo Cesare e Crasso continuano tranquillamente la loro carriera – e peraltro non si capisce a che cosa servisse loro la dittatura –, ma anche Catilina può proseguire indisturbato nei suoi tentativi per giungere al consolato negli anni successivi. Il solo provvedimento assunto dal senato sembra sia stato la scorta concessa ai due consoli in carica.
L’unica cosa certa è che nel breve volgere di sei anni a Roma si verificano tre congiure per eliminare i vertici dello Stato e crearne di nuovi, e non solo con Catilina come protagonista. Se infatti consideriamo che il primo triumvirato è un accordo stipulato segretamente da tre potenti, Cesare, Pompeo e Crasso, tutti in qualche misura legati ai popolari, teso a «impedire che nella Repubblica si facesse qualcosa di sgradito a uno di loro tre», dunque una cospirazione per il potere, allora anche i tentativi di Catilina assumono una luce diversa e vanno giudicati su uno sfondo più vasto che non quello, riduttivo, di un’impresa apparentemente sconclusionata.
Il convitato di pietra
E qui vale la pena di ripetere: come possiamo spiegare questa azione così strana, in cui i protagonisti mostrano comportamenti quasi dilettanteschi? Perché questa discordanza tra le narrazioni proprio nei nomi dei protagonisti? E, infine, come mai non si procedette ad alcuna repressione della congiura e dei congiurati?
Cominciamo col dire che non si possono comprendere i fatti accaduti a Roma tra il 66 e il 63, comprese quindi le due congiure passate alla storia come congiure di Catilina, senza un convitato di pietra lontano settimane di viaggio per mare, ma presente nei pensieri di ogni protagonista della vita pubblica.
Quest’uomo è Gneo Pompeo Magno.
Dal 67 Pompeo si trova in Oriente, impegnato prima in una lotta senza quartiere contro i pirati che infestano il Mediterraneo dalle loro basi in Asia Minore, poi nell’ultima guerra contro l’ostinata e feroce resistenza di Mitridate, il sovrano del Ponto, un regno affacciato sul Mar Nero, che da più di vent’anni raccoglieva intorno a sé la resistenza antiromana che covava in Asia specialmente fra i ceti più poveri delle campagne.
Per vincere queste guerre a Pompeo sono attribuiti quei comandi speciali che, secondo alcuni (tra cui l’autorevole voce di Machiavelli), sono la vera causa del passaggio traumatico dalla Repubblica oligarchica al principato militare, ma che comunque mettono in risalto l’incompatibilità del sistema di governo della polis con la conquista di un impero sempre più vasto.
Tali comandi speciali vengono legittimati da due leggi presentate alle assemblee popolari, tra veementi proteste del senato, dai tribuni della plebe Gabinio e Manilio. Esse consentono ai comandanti militari di estendere il loro potere oltre i limiti spaziali e temporali imposti dalla loro provincia (parola che in origine significa solo «incarico»).
Così, ad esempio, Pompeo ha la facoltà di nominare propri luogotenenti e, nonostante la possibilità concreta di conflitti di potere, di entrare nelle province di altri governatori fino a 50 miglia dal mare con un’autorità pari alla loro. Le proposte passano con l’appoggio dei ceti finanziari che vedono minacciati i loro commerci con l’Asia Minore e della plebe urbana che prova sulla propria pelle il pericolo per i rifornimenti alimentari rappresentato dai pirati, giunti anche nel Tirreno.
In ogni caso, l’opposizione dell’aristocrazia senatoria a questo potere che si definisce con una punta di preoccupazione infinitum («senza limiti») non può essere più netta. Lutazio Catulo, ancora il collega di Lepido nella tragica vicenda del 78, affermò in quell’occasione che «Pompeo era una figura troppo eminente per una libera Repubblica, e che il potere non si doveva porre tutto nelle mani di uno solo».
Ciononostante Cesare, una parte del senato e perfino Cicerone si schierano apertamente con Pompeo. In particolare Cicerone, in piena ascesa politica, pronuncia una celebre orazione in difesa della legge Manilia nella quale il credito, l’autorità e la grandezza del generale, le sue capacità amministrative, le imposte della provincia d’Asia, i beni dei cittadini romani nella stessa provincia e appunto gli affari degli appaltatori delle imposte e dei commercianti vincono i dubbi sull’affidamento di un potere così vasto a un singolo uomo.
Il successo all’estero e le ragioni dell’impero impongono di sorvolare sulla crisi della Repubblica. E in questo momento, cioè grosso modo dal 70 al 62, Pompeo è così potente che a Roma non c’è azione politica che non tenga conto del fatto che prima o poi tornerà dall’Oriente al comando di un esercito che lo idolatra.
Perché Pompeo aveva capito quello che aveva capito Mario, che aveva capito Silla, e che prontamente capisce anche Cesare. Cioè che le aspirazioni dei ceti proletarizzati dalla lenta trasformazione della struttura economica della penisola confluivano di necessità in una sorta di contenitore che era l’esercito.
Così quando Mario nel 107 – nel pieno della guerra contro Giugurta – aveva definitivamente arruolato i proletari, con questo ponendosi al culmine di una evoluzione che durava già da tempo, non aveva fatto altro che accelerare la trasformazione di un esercito di cittadini «dilettanti» che combattono quando la patria ne ha bisogno in un esercito di professionisti che vedono nel servizio militare, con il soldo e soprattutto con i bottini e le distribuzioni di terre, la strada per quel riscatto sociale ed economico che i ceti dirigenti non erano riusciti a promuovere.
Erano gli stessi ceti dirigenti che negli anni Novanta del I secolo non avevano dato una risposta agli alleati italici che volevano la cittadinanza, provocando la più inutile delle guerre (la guerra sociale); che erano in lotta con gli esponenti più attivi dell’ordine dei cavalieri (nella formazione delle giurie, o nella politica economica in Asia); e che non capivano le dinamiche della plebe urbana proletarizzata (la quale ad esempio voleva nuovi culti come veicolo di istanze sociali).
E del resto abbiamo osservato in Etruria, da dove siamo partiti, come i fermenti sociali e i problemi economici si saldassero con la questione dell’esercito: i veterani sillani, destinatari delle distribuzioni di terra, sono in competizione con i contadini, ai quali le proprietà sono state requisite perché hanno combattuto dalla parte sbagliata.
Pompeo d’altro canto, come Crasso e Catilina, era stato sillano, e anzi aveva arruolato un esercito di contadini, clienti e veterani del padre, il suo primo maestro nella ricerca di indipendenza nel comando, e l’aveva offerto al dittatore nella guerra civile. Con eserciti a lui devotissimi aveva contribuito alla lotta contro i resti delle truppe mariane sconfiggendo Lepido (altro sillano ridiventato disinvoltamente popolare) e Sertorio in Spagna – e come aveva fatto Silla era giunto a minacciare il senato di marciare su Roma se non gli avesse concesso le forze richieste. Poi aveva offuscato la gloria di Crasso nella guerra servile, quando era arrivato in Italia a dare il colpo di grazia ai disperati schiavi ribelli di Spartaco, e sembrava che la guerra non si potesse chiudere senza il suo intervento.
Infine, con la stessa mancanza di scrupoli che aveva appreso da Silla, ne aveva alterato la costituzione nel 70, l’anno del suo consolato insieme con Crasso, allorché si era reso necessario un decreto del senato per sanare l’irregolarità nella sua carriera pubblica. Pompeo aveva capito che lo Stato romano non si poteva più reggere sulla sola volontà delle famiglie nobiliari, e aveva esteso qualche potere ai popolari con la restaurazione del tribunato della plebe e ai cavalieri dando loro voce nei tribunali sulle malversazioni nelle province.
Inoltre il ripristino della censura in quell’anno, come si vedrà, aveva consentito poi di procedere più speditamente alla registrazione degli italici nel corpo dei cittadini romani, favorendo così un altro gruppo sociale che premeva perché i privilegi dei cittadini romani e dell’oligarchia dominante fossero ridistribuiti.
La svolta «popolare» di Pompeo in realtà non fa che seguire delle intuizioni di Silla, che già aveva allargato il numero dei senatori, e si manifesta in maniera molto più chiara nel suo rapporto con le truppe. Come già Silla, appunto, che era stato accusato di allentare la disciplina degli eserciti mentre combatteva in quelle r...