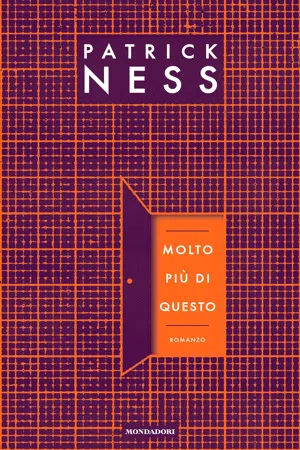Nei primi istanti dopo la sua morte il ragazzo è completamente stordito e confuso. Ha una vaga coscienza del dolore, ma più di tutto è sopraffatto da una stanchezza infinita, come se fosse coperto da strati e strati di coltri pesantissime. Lotta alla cieca per liberarsene, in preda a un (ennesimo) attacco di panico, e sfinito si ribella a funi invisibili che sembrano trattenerlo.
La sua mente non è sgombra, corre e pulsa come se fosse vittima di una febbre terribile, e non è neppure consapevole di cosa sta pensando. Il suo è più una sorta di istinto selvaggio da moribondo, un terrore per quel che dovrà accadere, un terrore per ciò che è già avvenuto.
Il terrore della morte.
Come se potesse ancora combatterla, ancora sfuggirle.
Ha un debole ricordo dello schianto: il suo corpo che continua ad annaspare fra le onde, anche se quella battaglia sembra già persa, e lui che avverte un’improvvisa spinta, un’ondata terrificante che lo trascina via, lontano, sempre più distante. In qualche modo, però, dev’essersi liberato del proprio corpo, perché la spalla non gli duole più mentre si dibatte ciecamente nell’oscurità, incapace di provare altro, a quanto pare, se non l’urgenza terribile di muoversi...
E poi sente un vento freddo sul suo viso. Quasi una brezza, nonostante una cosa del genere sembri impossibile per un’infinità di motivi. È questo freddo che per un istante interrompe l’arrovellarsi febbricitante della sua coscienza, o della sua anima? O del suo spirito? Chi può dirlo?
Per un attimo soltanto si ferma.
C’è qualcosa di nuovo nelle tenebre davanti ai suoi occhi. Un chiarore. Un chiarore verso il quale spingersi, in qualche modo, e lui si sente protendersi, il suo corpo – debolissimo, quasi del tutto inservibile – che si allunga verso quella luce crescente.
Cade. Cade su una superficie solida, da cui riceve una sensazione di freschezza, nella quale si lascia sprofondare, facendosi avvolgere.
È immobile. Rinuncia alla battaglia. Si lascia sopraffare dall’oblio.
L’oblio è un grigio purgatorio. Il ragazzo è semicosciente, non del tutto addormentato ma neppure sveglio, come disconnesso da ogni cosa, incapace di muoversi o pensare o ricevere segnali, in grado appena di esistere.
Passa una quantità impossibile di tempo, un giorno, un anno, forse un’eternità, non ha modo di saperlo. Infine, in lontananza, la luce comincia lenta, quasi impercettibilmente, a mutare. Emerge un grigiore, che a poco a poco si fa più chiaro, e il ragazzo inizia a riaversi.
Il suo primo pensiero, afferrato appena più che articolato, è che si sente come se fosse schiacciato su un blocco di cemento. È cosciente solo di quanto sia freddo sotto di lui, quanto sia resistente, e vi si avvinghia come se non volesse volar via nello spazio. Staziona intorno a quell’idea per una quantità indefinibile di tempo, lasciandola definirsi e connettersi al suo corpo, ad altri pensieri...
La parola “obitorio” balena improvvisa da qualche parte dentro di lui – dove altro è che si viene deposti su una superficie rigida e fredda? – e con terrore crescente apre gli occhi, rendendosi conto solo ora che li teneva ancora chiusi. Prova a gridare che non devono seppellirlo, non devono fargli l’autopsia, che c’è stato un terribile, terribile errore. Ma le parole non vogliono formarsi, la gola si ribella, come se non fosse stata usata per anni, e allora tossisce, si tira su a sedere spaventato, con la vista confusa e annebbiata, come se guardasse il mondo da dietro spesse lastre di vetro sporco.
Batte le palpebre ripetutamente, sforzandosi di vedere qualcosa. Le sagome indistinte intorno a lui cominciano pian piano a prendere forma. Si rende conto che non si trova sul tavolo gelido di un obitorio.
È...
È...
Dove?
Disorientato, strizza gli occhi dolorosamente in quella che adesso sembra la luce del primo mattino. Si guarda attorno, cercando di cogliere, di percepire, di capire.
Giace su un vialetto di cemento che taglia in due il giardinetto di un’abitazione e conduce dal marciapiede a una porta d’ingresso alle sue spalle.
Non è casa sua.
E c’è altro che non quadra.
Respira per qualche istante, pesantemente, quasi ansimando, intontito, mentre inizia a mettere a fuoco. Si sente tremare per il freddo e si stringe le braccia addosso, avvertendo l’umidità che impregna i suoi...
Non sono i suoi vestiti.
Abbassa gli occhi, più lentamente di quanto vorrebbe. Sbatte ancora le palpebre, sforzandosi di guardare. Non sembrano davvero abiti, ma semplici strisce di stoffa bianca che mal si adattano a nomi come “pantaloni” o “maglietta”: gli stanno appiccicati addosso più come bende che come vestiti. E su un fianco sono bagnati di...
Resta interdetto.
Non è acqua di mare, non quella gelida e pungente dell’oceano dove poco fa stava...
(affogando)
E solo metà del suo corpo è bagnata. L’altra, la metà che poggiava a terra, è gelata, ma asciutta.
Si guarda intorno, più confuso che mai. Perché quella non può essere altro che rugiada. Il sole è basso nel cielo, e sembra mattina. Sotto di lui, riesce persino a scorgere la sagoma asciutta del punto in cui giaceva.
Come se fosse rimasto lì steso per tutta la notte.
Ma non è possibile. Ricorda il freddo tagliente dell’acqua invernale, il grigio del cielo livido, il gelo che mai l’avrebbe lasciato sopravvivere per così tante ore...
Ma il cielo non era questo qui. Alza lo sguardo: questo non è neppure invernale. La temperatura è quella del mattino, di un giorno in arrivo che potrebbe persino essere mite, persino estivo. Niente a che vedere con il vento pungente della spiaggia. Nulla a che fare con il giorno della sua...
Della sua morte.
Si trattiene ancora un attimo a respirare, respirare e basta, se ci riesce. Intorno c’è solo silenzio, gli unici suoni sono quelli che lui produce.
Si volta lentamente a guardare la casa. La percepisce sempre meglio, a mano a mano che gli occhi si adattano alla luce e, verrebbe da dire, si riabituano a vedere.
Poi, fra la confusione e l’annebbiamento, un lieve brivido si fa strada nella sua mente svuotata.
Un tocco, un accenno, un sentore di...
Di...
Di qualcosa di familiare?
Prova ad alzarsi e quella sensazione svanisce. Tirarsi su è complicato, inaspettatamente complicato, e ricasca all’indietro. È tremendamente debole, i suoi muscoli si oppongono anche al semplice ordine di alzarsi in piedi. Già stare seduto è uno sforzo che lo lascia senza fiato e deve fermarsi un attimo, ansimante.
Allunga la mano per afferrarsi a un arbusto dall’aspetto massiccio sul bordo del vialetto, nel tentativo di sollevarsi di nuovo in piedi...
Ma la ritrae all’istante perché delle spine gli pungono le dita.
Non è una pianta qualsiasi. È un arbusto infestante cresciuto a dismisura. Le aiuole lungo il vialetto fino alla porta sono completamente invase di erbacce, che superano abbondantemente in altezza i muretti divisori di pietra. Sembrano quasi creature animate che si tendono verso di lui, pronte ad aggredirlo nel caso osasse avvicinarsi. Altre piante selvatiche, enormi, alte più di un metro, quasi un metro e mezzo, sbucano da ogni centimetro di terra e da ogni fessura nel vialetto, e ce n’è persino una schiacciata sotto di lui, lì dove fino a poco prima giaceva.
Prova di nuovo ad alzarsi, e alla fine ci riesce, barcollando pericolosamente per un momento. Ha la testa pesante e intontita, trema ancora. Le bende bianche che lo fasciano non lo tengono al caldo e, piuttosto preoccupato, nota che non lo coprono nemmeno in modo adeguato. Ha le gambe e il busto ben avvolti, e così anche le braccia e buona parte della schiena. Ma la cosa scioccante è che tutta la zona dall’ombelico alle cosce è nuda agli occhi del mondo, sia davanti che dietro. Le sue parti più intime sono assurdamente esposte al sole del mattino. Si affanna a cercare di tirar giù quella poca stoffa per coprirsi, ma è appiccicata alla sua pelle e non si sposta.
Allora usa le mani e si guarda intorno per controllare se qualcuno l’ha visto.
Ma non c’è nessuno. Proprio nessuno.
“Sto sognando?” pensa, e le parole lo raggiungono in ritardo, smorzate, come da una grande distanza. “È l’ultimo sogno prima della morte?”
I giardinetti delle case circostanti sono tutti invasi allo stesso modo. Nei punti in cui doveva esserci un semplice prato l’erba è alta più di un metro. Anche l’asfalto della strada è spaccato, e proprio lì in mezzo sbucano altre piante cresciute in maniera quasi indecente, alcune delle quali potrebbero persino ambire allo stato di alberi.
Ci sono automobili parcheggiate sulla via, con carrozzeria, parabrezza e finestrini ricoperti di polvere e terra. Quasi tutte poggiano per intero su quattro pneumatici sgonfi.
Nulla si muove. Nessun veicolo che sfreccia e, a giudicare dalla vegetazione, deve essere trascorso tantissimo tempo dall’ultima volta che un’auto è passata di qui. La strada prosegue a sinistra fino a incrociarsi con un’altra arteria più ampia, a occhio una di quelle principali, che dovrebbe essere affollata e trafficata. Ma non ci sono macchine in moto neppure lì e all’altezza dell’incrocio nota un fosso enorme, largo dodici, forse quindici metri, dal quale sembra sbucare un fitto intrico di erbacce.
Il ragazzo prova a mettersi in ascolto. Non sente alcun rombo di motori. Né da questa strada, né da quella più in là. Attende per un lungo istante. E poi un altro po’. Si volta a destra, verso l’altro capo della via, e nello spazio fra due edifici intravede dei binari tendendo automaticamente l’orecchio.
Ma non ci sono treni.
Né persone.
Se fosse mattino come sembra, dovrebbe esserci chi esce di casa, chi si mette in auto e va al lavoro. Chi porta i cani a spasso, chi consegna la posta, chi cammina diretto a scuola.
Le strade dovrebbero essere piene. Le porte dovrebbero aprirsi e chiudersi.
Ma non c’è nessuno. Niente auto, né treni, né persone.
E adesso che vede bene, ora che gli occhi e il cervello mettono a fuoco correttamente, pure questa via e la geografia stessa di questo luogo sembrano strane. Le case sono addossate le une alle altre, tutte in fila, senza garage o ampi cortili e con vicoletti ogni quattro o cinque palazzi. È tutto diverso rispetto alla via di casa sua. A dirla tutta, non sembra neppure una strada americana. Sembra quasi...
Sembra quasi inglese.
Questa parola gli riecheggia nella testa. Suona decisiva, come se cercasse disperatamente di afferrare qualcosa, ma nella sua mente annebbiata, scioccata e confusa non fa altro che accrescere la sua ansia.
È una parola sbagliata. Totalmente sbagliata.
Barcolla ancora un po’, deve afferrarsi a una pianta dall’aspetto robusto. Gli prende l’impulso di entrare nell’edificio, cercare qualcosa con cui coprirsi; e poi questa casa, questa casa...
La guarda accigliato.
Che cosa sa di questa casa?
Con sua grande sorpresa, senza neppure accorgersi di aver deciso, muove un...