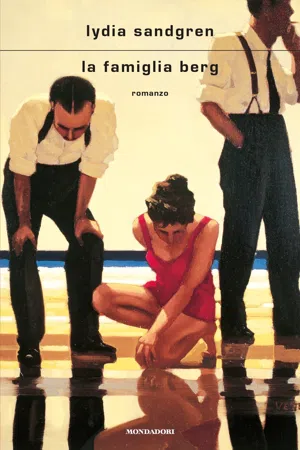I
INTERVISTATORE: Può raccontare qualcosa del suo rapporto con Parigi?
MARTIN BERG: [si allunga all’indietro.] Sono stato abbastanza astuto da trasferirmi a Parigi da giovane, quando ero plasmabile. Credo sia stata un’esperienza preziosissima. Enormemente preziosa. Era importante tornare a Göteborg e prendere la decisione che volevo vivere qui. Sarebbe stata un’altra cosa se fossi rimasto qui. E non avessi visto niente del mondo.
INTERVISTATORE: In che senso preziosa?
MARTIN BERG: Mi ero messo in testa che avrei scritto. Come si fa a ventitré, ventiquattro anni. “Mi trasferirò a Parigi e scriverò un romanzo.” Decidere una cosa del genere è un’esperienza significativa. Vuol dire guardare negli occhi la pagina bianca.
*
Avevano cominciato a parlarne al liceo.
In un modo o nell’altro tutte le strade conducevano a Parigi. William Wallace aveva scritto Giorni di Patagonia al solito tavolo alla Closerie des Lilas, in una condizione ciclica di caduta e ripresa dall’ebbrezza, mentre fumava quei sigaretti che mal si addicevano al suo aspetto da ragazzino. Hemingway aveva scritto Festa mobile e Joyce aveva finalmente concluso Ulisse, che era stato pubblicato con una copertina azzurra come il mar Egeo.
In realtà il progetto di Parigi era stato costituito solo da programmi infondati finché a sorpresa Per Andrén non raccontò di poter affittare un appartamento tramite un parente.
«Una mansarda» disse Per facendo quasi cadere la birra quando si chinò in avanti «con vista sui tetti e sulla Torre Eiffel. Che ne dite?»
Era eticamente corretto non andare? Non era la grande occasione di Martin? L’audace salto verso l’eternità? Il cambio di ambiente da Göteborg (grigiastra, piovosa, ben nota) a Parigi (luccicante, vivace, infinita) non era proprio quello che ci voleva per prendere finalmente il via con quel romanzo che ancora era un cumulo di appunti? Non era ciò che avrebbe liberato le sue idee strepitose? Non sarebbe diventato un Wallace, un Hemingway, un Joyce? Non era il suo sogno da anni?
«Mi sembra ottimo» rispose Gustav.
Senza grandi speranze Martin inviò la richiesta di una borsa di studio a un fondo per studenti dell’Università di Göteborg. Fu sorpreso nel vedersi concesse quindicimila corone, che insieme al capitale risparmiato nelle estati alle Poste sarebbero bastate per un po’, a condizione di vivere con sobrietà. In uno slancio di intraprendenza Gustav si mise alla ricerca di programmi di scambio tra la Valand e una scuola d’arte di Parigi e fece domanda. Per, che dei tre era il più bravo a pianificare, si era iscritto a un corso di francese alla Sorbona.
«Ah. Be’… ah» disse Cecilia la prima volta che Martin parlò dell’idea.
«Puoi venire anche tu» rispose, perché pensava che lei se lo aspettasse.
Cecilia scosse la testa. «Devo scrivere la tesi. E non posso permettermelo. È solo che…» La voce si spense e Martin riempì rapidamente il silenzio raccontando i dettagli pratici. Tenne l’argomento principale per ultimo.
«Credo davvero che mi farebbe bene per scrivere. Sai, un’opportunità del genere non capita tante volte. Bisogna saltare sul treno quando passa.»
«Assolutamente.»
Durante l’ultimo anno avevano trascorso insieme gran parte dei giorni e delle notti e la nostalgia era ancora un concetto astratto. Sembrava che la situazione si potesse gestire con telefonate e lettere e durante l’estate Cecilia poteva andare a trovarli. Forse sarebbe stato perfino un bene non avere distrazioni. Martin aveva sentito che i pugili si astenevano dal sesso prima di un match importante. Invece che dando sfogo alla carne avrebbe incanalato tutta la sua libido nella letteratura e questa volta quel bastardo di un romanzo sarebbe venuto fuori.
«È come se fossi obbligato ad andare» disse. «Altrimenti diventerò vecchio e acido. Sarò un quarantenne che si pente di non averlo fatto. Non posso fare questo a me stesso. Se mi capisci.»
«Certo.»
«Immagina che tutta la tua vita sia stata una sorta di pedana di rincorsa per raggiungere un punto speciale ed è in quel punto che comincia tutto. Oppure prendiamo una porta. Immagina una porta. La si attraversa. Tutta la vita è stata una preparazione per attraversare quella porta. È il simbolo di qualcosa di più esistenziale. È il destino, anche se Sartre non parla di “destino”… in effetti disprezza fortemente il concetto di “destino” o meglio della fede dell’uomo in questo “destino” come qualcosa che determina e condiziona la sua vita oltre i limiti del suo controllo e della possibilità di assumersene la responsabilità. In ogni caso, se per un momento ci concediamo una concezione più quotidiana dell’idea di “destino”, il destino di una persona è attraversare quella porta. Le strade della sua esistenza lo hanno condotto lì e ora deve compiere quel passo, o salto… Kierkegaard, un altro esistenzialista, parla proprio di salto…»
«Ho letto Kierkegaard.»
«Ovviamente…ehm… dov’ero arrivato?»
«Al salto attraverso la porta.»
«Sì, dunque, bisogna compiere il salto attraverso la porta. È questo il punto. Osare, buttarsi e osare. Alla fin fine l’esistenza non è altro che un’unica lunga esortazione a osare. A mollare la presa e surfare sulle onde dell’incertezza invece di sguazzare vicino alla costa dove di sicuro si tocca e si rimane al riparo nel campo visivo dei genitori.»
«Che c’è dall’altra parte?»
«Cosa?»
«Dall’altra parte della porta.»
Mentre si dedicavano ai preparativi per il viaggio, Cecilia era sempre più presa dagli allenamenti di corsa.
All’inizio Martin faceva fatica a sovrapporre la Sportiva Cissi all’immagine della sua ragazza. Nelle altre occasioni non portava mai la coda di cavallo. Nelle altre occasioni non indossava mai reggiseni sportivi e magliette. Nelle altre occasioni non era tanto facile scambiarla con una qualunque ragazza fissata con gli allenamenti. Nel suo stile di corsa c’era qualcosa di ridicolo (schiena dritta, mento leggermente sollevato) e non si limitava alle aree previste per l’attività fisica, bensì correva dove le andava, di solito in città.
Già a scuola Martin aveva capito che doveva scegliere da che parte stare nell’eterna lotta tra Corpo e Mente. Aveva scelto la Mente e di conseguenza aveva smesso di sforzarsi per essere bravo negli sport di squadra, nel maneggiare la palla e nella coordinazione. Non bastava però essere scarso; bisognava anche mostrare disprezzo in un modo convincente. Martin lo faceva stando sugli spalti insieme a quelli con “la caviglia slogata” a leggere Camus. Se erano all’aperto, fumava una sigaretta per sottolineare bene quanto gliene fregava della propria capacità polmonare.
Il destino non sembrava del tutto d’accordo, perché lo aveva dotato di un certo talento per la corsa. Siccome non poteva resistere alla tentazione di essere il migliore della classe in qualcosa, ogni tanto si trascinava sulla pista degli ottocento metri con le sue gambe pallide che spuntavano dai pantaloncini che utilizzava in media quattro volte a quadrimestre, si posizionava sulla linea di partenza e si abbandonava al Corpo.
La cosa fantastica della corsa era che non serviva pensare. Non bisognava tenere d’occhio altre persone o imprevedibili palloni insidiosi. Non bisognava puntare tutto su un unico lancio che si rischiava di sbagliare. Nella corsa c’era sempre la possibilità di aumentare un pochino. Anche se si gareggiava con altri non era una vera e propria prova di forza come nella boxe o nella lotta, in cui si veniva palesemente sopraffatti.
Non serviva un avversario o un concorrente e di conseguenza si evitava il rischio di perdere. Martin correva più spesso di quanto non volesse far vedere e perciò era riuscito a difendere il suo record sugli ottocento metri per tre anni di fila, cosa che per il professore di ginnastica appariva come un miracolo della fisica.
Cecilia correva un determinato numero di volte alla settimana, aumentava le distanze gradualmente e in breve arrivò a qualche decina di chilometri. Correva al mattino. Correva se pioveva. Quando cominciò a fare buio si comprò un orrendo giubbotto riflettente.
E poi smise di fumare, e a quel punto Martin si domandò se non fosse andata troppo oltre.
Era un martedì sera di fine autunno ed erano tutti stanchi. Martin era stanco del corso di letteratura, perché non faceva che leggere e leggere e non aveva mai letto abbastanza. Cecilia era stanca perché frequentava sia Tedesco che storia delle idee, scriveva la tesi e aveva appena corso venti chilometri. Gustav era stanco perché era di nuovo in una fase da Come Artista Sono Un Bluff e dormiva tutto il giorno. Però erano usciti a mangiare e bere qualche birra al Gyllene Prag, e nel complesso la vita sembrava un po’ più piacevole. Dopo cena Gustav tirò fuori il portasigarette che era appartenuto a quel viveur di suo nonno che era annegato durante un giro in barca a vela all’alba al largo di Cap d’Antibes. Lo porse a Martin, che ne prese una, e a Cecilia, che con sorpresa di tutti disse:
«No, grazie. Ho smesso.»
«Hai smesso?» chiese Martin.
«Non dovresti accorgerti di una cosa del genere?» intervenne Gustav.
Cecilia annuì, non si capiva a chi dei due. «Non posso fumare e correre insieme.»
«Ma non fumi mentre corri» disse Martin sentendosi spiritoso per circa un secondo.
«Ovviamente non fumo mentre corro.»
«Quindi hai smesso così di colpo?» domandò Gustav.
«Esatto.»
«Non è faticoso?»
«Be’, sì. Per esempio adesso ho una gran voglia di fumare.»
«Che cazzo allora» disse Martin. «Non succede niente se ne prendi una. Una sigarettina. Non fa differenza.»
«Invece sì» ribatté Cecilia. «Fa tutta la differenza. Se prendo una sigarettina vuol dire che non ho smesso. Se prendo una sigarettina al massimo ho ridotto, ma non ho smesso.»
«Ma è così importante smettere?» disse Martin. Afferrò il portasigarette di Gustav e glielo mise davanti. «Tu ne vuoi una!»
«Ma lasciala in pace» intervenne Gustav.
«Mi chiedo soltanto: perché è così importante smettere?» La discussione infervorò Martin al punto che non riusciva a spiegarsi bene. «Capisco che si faccia fatica quando si corre, ma così tanta fatica no, e lo so per esperienza perché io fumo e corro, anche se in momenti diversi. E si possono eliminare diciamo sette delle dieci sigarette che si fumerebbero normalmente e mantenerne tre, tre simpatiche sigarettine da fumare proprio dopo una simpatica cena fuori, per esempio. Qual è il problema? Eh?»
«Nessuno ha detto che sia un problema» rispose Cecilia. «Io ho detto soltanto che ho smesso.»
«Ma scusa, Cissi, fumi forse mezzo pacchetto al giorno da quando ti conosco…»
«Meno di mezzo pacchetto.»
«Facciamo da due a tre pacchetti a settimana. Possiamo concordare da due a tre pacchetti a settimana?»
«Da due a tre pacchetti a settimana, sì.»
«E questo che c’entra?» chiese Gustav.
«Aspetta un attimo» disse Martin. «Allora: fumi da due a tre pacchetti a settimana da quando ti conosco, ovvero da un anno e mezzo, e probabilmente un pezzo anche prima.»
«Esatto.»
«E fumi questi da due a tre pacchetti a settimana con grande piacere e, almeno per quanto ne so io, nessuno o pochissimi sensi di colpa per fare una cosa che in fin dei conti è pericolosa per la tua salute.»
«Corretto» disse Cecilia.
«E ora, un giorno, così, decidi di smettere. Di colpo. Senza ridurre. Cento per cento.»
«Esatto. Dove vuoi arrivare?»
Al tavolo calò il silenzio per qualche istante, perché Martin aveva dimenticato il punto. Per nascondere il disorientamento tirò fuori un’altra sigaretta e la accese.
«Semplicemente non capisco cosa ci sia di così pericoloso a fumarne una.»
Cecilia scrollò le spalle. «Perché anche se è solo una è comunque una.»
«Ma quindi… hai fumato per tutto questo tempo e riuscivi a correre anche prima.»
«Sì.»
«Non è un po’, sì, un po’…»
«Un po’ cosa?»
«Un po’ eccessivo. Smettere così.»
«Perché ti dà tanto fastidio che abbia smesso?»
«Hai smesso davvero? Quando hai fumato l’ultima?»
«Domenica.»
«Sono» Martin contò in silenzio «cinque giorni. Cinque giorni! Ricomincerai.»
«Ma cazzo, lo saprò bene io se ho smesso di fumare o no?» sbottò Cecilia.
«Certo. Assolutamente.»
«Possiamo parlare d’altro?» suggerì Gustav.
«Ti do una settimana» disse Martin.
«Oh Signore» ribatté Cecilia.
Di tanto in tanto Martin le mandava delle frecciatine ...