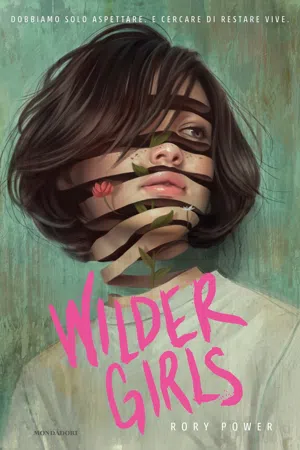C’è qualcosa. Lontano, tra gli alberi, nell’oscurità bianca, dove la foresta si infittisce. Lo vedo muoversi dal tetto, dal modo in cui la vegetazione gli si piega intorno mentre si sposta veloce in direzione dell’oceano.
Dalle dimensioni sembrerebbe un coyote, di quelli grossi che ti arrivano fino alle spalle. Con denti che potresti stringere in mano come fossero coltelli. Lo so perché una volta ne ho trovato uno, incastrato nella cancellata. L’ho preso e l’ho nascosto sotto il letto.
Un altro rumore dalla macchia e poi di nuovo silenzio. Dall’altra parte del tetto a terrazza, Byatt abbassa il fucile e lo appoggia al parapetto. La strada è vuota.
Io tengo il mio sollevato, il mirino davanti all’occhio sinistro, non si sa mai. L’altro occhio è morto, è diventato cieco durante una crisi. La palpebra superiore si è chiusa fondendosi con quella inferiore, e sotto sta crescendo qualcosa.
È così per tutte, qui. Siamo malate e strane, e non sappiamo perché. Ci esplodono cose da dentro il corpo, perdiamo parti di noi, poi la pelle indurisce e diventa liscia.
Attraverso il mirino, sotto il sole di mezzogiorno che toglie colore al mondo, vedo la foresta allungarsi fino al bordo dell’isola, e poi l’oceano. Pini irti di aculei come sempre, più alti della casa. Qua e là un buco dove c’è qualche quercia o betulla che ha perso le foglie, ma per il resto una cupola compatta di aghi irrigiditi dal gelo. Ne sbuca fuori solo l’antenna della radio, inutile ora che è stato spento il segnale.
In fondo alla strada qualcuno grida e dagli alberi esce la Squadra della Barca che torna a casa. Solo poche persone possono spingersi dall’altra parte dell’isola, fino al molo dove un tempo attraccavano i traghetti che andavano e venivano dal continente e dove ora la Marina militare consegna cibo e vestiario. Tutti gli altri devono restare dentro la cancellata, a pregare che la squadra torni a casa sana e salva.
La più alta, la signorina Welch, si ferma all’ingresso e armeggia con la serratura finché finalmente il cancello si apre e la Squadra della Barca entra con passo affaticato e guance rosse per il freddo. Sono tornate tutte e tre, tutte e tre piegate sotto il peso delle scatolette, delle confezioni di carne e delle zollette di zucchero. La Welch si volta per chiudersi il cancello alle spalle. È l’insegnante più giovane, di neanche cinque anni più grande delle alunne delle ultime classi. Prima viveva nell’ala dei dormitori e faceva finta di niente se qualcuna violava il coprifuoco. Ora ci conta ogni mattina per assicurarsi che non sia morto nessuno durante la notte.
La Welch agita un braccio per segnalare che è tutto a posto, e Byatt risponde nello stesso modo. Io controllo il cancello, Byatt controlla la strada. A volte ci scambiamo, ma dura poco perché il mio occhio non funziona per guardare lontano. In ogni caso sono più brava a sparare di metà delle ragazze che potrebbero prendere il mio posto.
L’ultima ragazza della squadra si infila sotto il portico uscendo dal mio campo visivo, e questo segna la fine del nostro turno. Scarico il fucile. Ripongo i proiettili nella scatola per la ragazza successiva. Me ne faccio scivolare uno in tasca, non si sa mai.
Dalla terrazza al terzo piano, il tetto declina dolcemente fino al secondo. Da lì per entrare in casa ci appendiamo al bordo e poi ci lanciamo dentro la finestra aperta. Era più difficile quando indossavamo gonne e calzini, e una voce dentro di noi ancora ci diceva di tenere le ginocchia chiuse. Ma era molto tempo fa. Ora, con i nostri jeans stracciati, non abbiamo niente di cui preoccuparci.
Byatt entra dopo di me, lasciando un’altra serie di strisciate sul davanzale. Si getta i capelli su una spalla. Sono lisci come i miei, luminosi, di un castano deciso. E puliti. Anche quando non c’è pane, c’è sempre shampoo.
«Che cos’hai visto?» mi chiede.
Mi stringo nelle spalle. «Niente.»
La colazione è stata scarsa e mi sento le gambe deboli per la fame. So che è lo stesso per Byatt, per cui scendiamo subito di sotto per il pranzo, nel salone dall’alto soffitto al pianterreno. Tavoli graffiati e sbilenchi, un camino, divani dallo schienale alto svuotati dell’imbottitura per bruciarla nella stufa. E noi ragazze, tante ragazze, piene di vita.
Eravamo circa un centinaio quando tutto è cominciato, e venti insegnanti. Tutte insieme riempivamo entrambe le ali della vecchia casa. Ora ce ne basta una.
Le ragazze della Barca oltrepassano la porta d’ingresso, lasciano cadere le borse e parte la battaglia per il cibo. Ci mandano soprattutto scatolette, a volte pacchi di carne essiccata. Quasi mai cibi freschi, e mai a sufficienza per tutte. Nei giorni normali durante i pasti c’è solo la Welch in cucina, che apre con la chiave la dispensa in cui conserviamo le scorte e distribuisce le razioni più piccole che si siano mai viste. Ma oggi è giorno di consegna, e le ragazze della Squadra della Barca hanno portato nuovi rifornimenti; il che significa che la Welch e la direttrice se ne laveranno le mani e ci lasceranno litigare per accaparrarci qualcosa.
Io e Byatt non abbiamo bisogno di combattere. Reese è accanto alla porta e trascina una sacca di lato per noi. Se fosse chiunque altro, tutte si infastidirebbero, ma è Reese – la mano sinistra con dita affilate e coperte di squame – per cui nessuno dice niente.
È stata una delle ultime ad ammalarsi. Pensavo che l’avesse scampata, che forse si era salvata, ma poi sono comparse: squame di un color argento cangiante hanno cominciato ad affiorare sulla sua pelle come se provenissero dall’interno del corpo; era successa la stessa cosa a una ragazza del nostro anno. Le si erano propagate dappertutto e il suo sangue si era fatto sempre più freddo, finché non si è più svegliata. Così abbiamo pensato che fosse arrivata la fine anche per Reese; l’abbiamo portata di sopra, nell’attesa che morisse. E invece, il giorno prima era nell’infermeria e il giorno dopo era ancora fra noi; con una mano sinistra abnorme, ma comunque sua.
Reese apre la sacca e io e Byatt frughiamo dentro. Ho lo stomaco che si torce, la bocca piena di saliva. Qualunque cosa, prenderei qualunque cosa. Ma ci è toccata una sacca pessima: sapone, fiammiferi, una confezione di penne, una scatola di proiettili. E poi, sul fondo, un’arancia; una vera arancia fresca, con solo la buccia che ha appena cominciato a marcire.
Stiamo per prenderla, ma sento la mano argentea di Reese sulla nuca, il calore ribolle sotto le squame. La getto a terra, la colpisco in faccia con il ginocchio. La tengo giù con il mio peso e intanto stringo il braccio intorno al collo di Byatt. Una di loro tira un calcio; non so chi, ma mi colpisce dietro la testa e mi butta verso le scale. Sbatto il naso contro il bordo di un gradino. Il dolore esplode, bianco. Le altre ragazze gridano, in cerchio intorno a noi.
Qualcuno mi prende i capelli nel pugno e li tira. Mi volto, mordo i tendini che si gonfiano sulla sua pelle, e lei geme. Allento la presa. Lei allenta la sua, e ci allontaniamo affannosamente l’una dall’altra.
Mi pulisco l’occhio dal sangue. Reese è a terra a metà scala, l’arancia in mano. Ha vinto lei.
Lo chiamiamo Tox, e nei primi mesi a scuola hanno cercato di farne una materia di studio. Storia delle epidemie nelle civiltà occidentali. “Tox”, dal latino. Normative farmaceutiche dello stato del Maine.
La scuola proseguiva come sempre, le insegnanti stavano alla lavagna con i vestiti sporchi di sangue e programmavano verifiche come se fosse scontato che la settimana successiva ci saremmo state ancora tutte. Il mondo non sta finendo, dicevano, e lo stesso vale per la vostra istruzione.
Colazione nella sala della mensa. Matematica, inglese, francese. Pranzo. Esercitazione di tiro. Visite mediche e pronto soccorso, la signorina Welch che bendava ferite e la direttrice che ti infilava aghi nel braccio. Insieme per la cena e poi chiuse dentro per la notte. No, non so perché state male, ci diceva la Welch. Sì, starete bene. Sì, tornerete a casa presto.
Quella fase è durata poco. Le classi rimanevano indietro con il programma mentre il Tox si portava via una professoressa dopo l’altra. Le regole si sgretolavano e svanivano a poco a poco, finché non ne è rimasto che il nudo scheletro. Ma ancora contavamo i giorni, ci svegliavamo ogni mattina scrutando il cielo in cerca di telecamere e luci. La gente del continente se ne sta occupando, diceva sempre la Welch. Se ne sono occupati dall’istante in cui la direttrice ha chiamato Camp Nash, sulla costa, per chiedere aiuto; stanno cercando una cura. Nel primo carico di rifornimenti recuperato dalla Squadra della Barca c’era un biglietto, stampato su carta intestata della Marina, e firmato.
DA: Segreteria della Marina militare, Ufficiale al comando del Dipartimento della difesa, Forza di Risposta a Incidente Chimico/Biologico (FRICB), Direttore di Camp Nash, Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CDC)
A: Scuola femminile Raxter, isola di Raxter
OGGETTO: Procedure di quarantena raccomandate dal CDC
Si dispone l’isolamento completo e la quarantena con effetto immediato. È fatto divieto ai soggetti di uscire dalla proprietà della scuola, per la loro sicurezza e per bloccare il contagio. Chiunque oltrepassi i cancelli, a eccezione della squadra autorizzata al recupero dei rifornimenti (vedi oltre), agirà in violazione delle norme della quarantena.
Si provvede all’interruzione dell’accesso alle linee telefoniche e a internet; le comunicazioni andranno inoltrate attraverso i canali radio ufficiali. È imposto il livello massimo di segretezza su ogni informazione.
I rifornimenti saranno scaricati sul molo occidentale. Data e ora verranno segnalate per mezzo del faro di Camp Nash.
Diagnosi e cura in fase di sviluppo. Il CDC coopererà con strutture locali nella ricerca di una cura. Spedizione in arrivo.
Aspettare, e restare vive. Pensavamo sarebbe stato facile – stare insieme dentro la recinzione, al riparo dalla foresta, al riparo dagli animali diventati affamati e strani – ma le ragazze continuavano a soccombere. Gli attacchi distruggevano i loro corpi al punto che non riuscivano più a respirare, vi lasciavano ferite che non guarivano, e a volte instillavano dentro di loro una violenza febbrile, che le faceva rivoltare contro se stesse. E succede ancora. L’unica differenza è che ora abbiamo imparato che tutto quello che possiamo fare è prenderci cura l’una dell’altra.
Reese e Byatt appartengono a me e io appartengo a loro. È per loro che prego quando passo davanti alla bacheca e sfioro con due dita il biglietto della Marina ancora appuntato là, ingiallito e arricciato. Un talismano, un promemoria della promessa che ci hanno fatto. La cura sta arrivando, l’importante è rimanere vive.
Reese conficca un’unghia argentata nell’arancia e comincia a sbucciarla, e io mi costringo a distogliere lo sguardo. Quando c’è cibo fresco come quello, facciamo a botte per accaparrarcelo. Lei dice che è l’unico modo leale di risolvere la situazione. Nessuna carità, nessuna pietà. Non lo prenderebbe mai se non sentisse di meritarselo.
Intorno a noi le altre ragazze si stanno radunando tra vortici di risate acute, e frugano tra gli abiti che traboccano da ogni borsa. La Marina ce ne manda ancora in base al nostro numero originario. Gonne e stivali troppo piccoli che nessuna riesce più a calzare.
E giacche. Non smettono mai di mandarci giacche, da quando il gelo ha cominciato a coprire l’erba. Era appena iniziata la primavera quando è arrivato il Tox, e per quell’estate siamo state bene con le gonne e le camicette dell’uniforme; ma poi è arrivato l’inverno lungo e rigido del Maine. Di giorno accendevamo il fuoco e di notte andavano i generatori f...