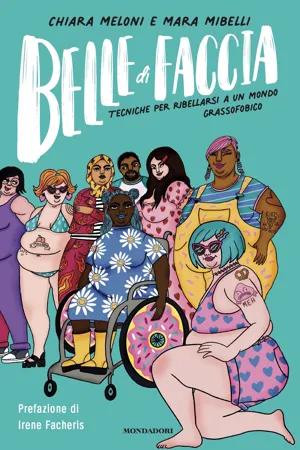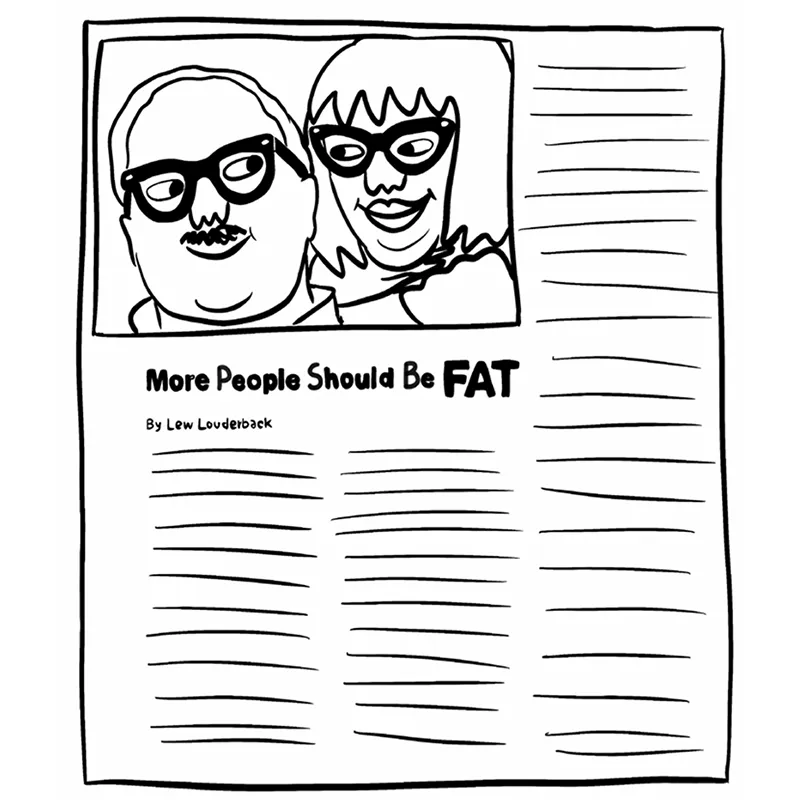Siamo sincere, questo libro e il nostro attivismo non esisterebbero senza una sonora INCAZZATURA che, a un certo punto, è diventata troppo grande e strutturata per rimanere confinata nelle nostre conversazioni telefoniche e nelle nostre app di messaggistica istantanea. Di solito non siamo presuntuose, ma entrambe siamo giunte alla conclusione che questo Frankenstein che avevamo generato con la potenza delle nostre imprecazioni non potesse rimanere confinato tra di noi, che bisognasse PARLARNE CON TUTTƏ.
Perché eravamo così arrabbiate, stanche, esasperate e piene Maria Giovanna piene? Innanzitutto lo eravamo perché, nonostante la body positivity fosse ormai sulla bocca di tuttə, un hashtag di tendenza, uno slogan da stampare su T-shirt in poliestere (ma solo fino alla L!), i corpi come il nostro e più grassi del nostro continuavano a non essere rappresentati, secondariamente perché in molti casi venivano persino cacciati via a pedate dal movimento da folle di influencer inferocite armate dei forconi della salute.
Per anni abbiamo visto donne bianche, cisgender, non-disabili, magre o che si discostavano pochissimo dall’ideale di magrezza torcersi come lombrichi e appallottolarsi come porcellini di terra (in inglese c’è un simpatico verbo anche per questo: slouching) per mostrare un rotolino di pelle, essere definite coraggiose perché mettevano in mostra la cellulite o le smagliature, ma i corpi grassi (come gli altri corpi non conformi) continuavano a non esistere, non venivano neanche nominati o erano apertamente estromessi dalla conversazione.
Ma alla fine che roba è questa body positivity e perché è stata fraintesa e usata a sproposito?
Il grande successo, ma probabilmente anche il grande equivoco generatosi intorno a questo movimento tanto abusato quanto largamente frainteso, ha incredibilmente a che fare con la vendita di saponette con un quarto di crema idratante:
NEL 2004, INFATTI, LA UNILEVER LANCIÒ LA CAMPAGNA “DOVE FOR REAL BEAUTY”, NELLA QUALE, PER LA PRIMA VOLTA, UN BRAND DI PRODOTTI PER LA CURA PERSONALE NON CAPITALIZZAVA SULL’INSICUREZZA
e sul senso di inadeguatezza femminili per vendere di più, ma celebrava la cosiddetta “bellezza autentica” delle donne comuni, delle sue clienti potenziali con una serie di scatti che ritraevano donne sorridenti con corpi diversi tra loro, invitandole a piacersi e ad accettarsi così com’erano.
Riguardandola ora, la campagna non è esattamente il non plus ultra in termini di rappresentazione (le donne disabili non esistono, come non esistono quelle davvero grasse e anche le persone nere e di etnie differenti da quella bianca sono in minoranza) e parlare di vera bellezza è molto problematico su vari livelli. Ma il panorama pubblicitario fino a quel momento era talmente desolante e degradante nel suo trattamento dei corpi femminili che il messaggio fu senza dubbio un momento di empowerment per molte donne. E di sicuro lo è stato per quei furboni della Dove, ovviamente, visto che il brand raddoppiò le vendite e continuò a cavalcare il tema con una serie di video diventati virali, seguito a ruota da altri brand che avevano capito il potenziale dirompente di quel messaggio.
ORA POTEVANO VENDERE ALLE DONNE UN NUOVO PRODOTTO: L’ACCETTAZIONE E L’AMORE PER SE STESSE, E FARE ANCHE BELLA FIGURA MENTRE GUADAGNAVANO.
Che buoni samaritani!
Quindi alla fine la body positivity l’ha inventata la Dove, che unendo l’utile al dilettevole ha lanciato un movimento per la liberazione dei corpi mentre cercava di convincerci a lavarci le ascelle con il suo sapone? Non proprio: la Real Beauty Campaign non ha fatto altro che intercettare una serie di temi caldi in circolazione da molto tempo, dalla lotta ai disturbi alimentari alla critica agli standard di bellezza.
Ma allora da dove vengono questi concetti radicali che le influencer e i brand ci stanno vendendo, opportunamente edulcorati e ripuliti dalle istanze più politiche grazie a un vigoroso white e pink washing?
L’espressione “body positive” venne usata per la prima volta negli anni Ottanta del secolo scorso da alcune organizzazioni che si occupavano di persone sieropositive; a metà degli anni Novanta venne ripresa dalla psicologa Deb Burgard, ricercatrice e attivista tra le fondatrici di HAES (Health at Every Size, approccio alla salute neutrale rispetto al peso corporeo) per il suo progetto chiamato appunto Body Positive. In contemporanea The Body Positive divenne anche il nome di un’organizzazione, ancora attiva, fondata da Connie Sobczak in onore di sua sorella, morta a causa di un disturbo alimentare di cui anche lei aveva sofferto, e da Elizabeth Scott, educatrice e psicoterapeuta.
Le espressioni “body positive” e “body positivity”, a prescindere dall’attività delle associazioni che hanno coniato e utilizzato questi termini, descrivono la corrente di pensiero secondo la quale ogni corpo (a prescindere dallo stato di salute, dal peso, dall’abilità, dall’identità di genere, dalla razza) è valido e ha diritto alla propria dignità e allo stesso rispetto, con particolare riguardo ai corpi non conformi.
LE ORIGINI: IL MOVIMENTO PER LA FAT ACCEPTANCE
Nemmeno le idee del movimento Body Positive erano però nuove: nascevano infatti dai concetti diffusi qualche decade prima dal movimento per la fat acceptance, nato negli Stati Uniti e diffusosi anche in Europa grazie a collettivi femministi, lesbici e queer.
Il primo evento documentato nella storia del movimento, ricostruita dall’attivista e sociologa inglese Charlotte Cooper in Fat Activism, fu decisamente iconico e spettacolare: nel 1967 lo speaker radiofonico Steve Post, che era stato grasso da bambino, decise di organizzare un sit-in per esprimere il proprio disappunto, e quello dei suoi ascoltatori, per il modo in cui i corpi grassi venivano trattati:
CINQUECENTO PERSONE, GRASSE E NON, SI RIUNIRONO A CENTRAL PARK PER IL FAT-IN
indossando indumenti a righe orizzontali (pensate da quanti anni le riviste ci propinano consigli per sembrare più magrə), bruciando libri sulle diete ed effigi di Twiggy – simbolo del modello di bellezza imperante – e mangiando insieme dolci e altre prelibatezze proibite dalla già fiorente cultura delle diete.
Non possiamo avallare la scelta di bruciare foto di Twiggy (prendersela con una donna solo perché magra non ci sembra neanche vagamente femminista o body positive), ma le altre due attività le approviamo senza remore, tanto che alla voce “hobby” nel nostro curriculum ora abbiamo scritto “mangiare torte e gelati bruciando libri sulle diete vestite rigorosamente a righe orizzontali”.
Il fat-in, anche se privo di solide basi teoriche o motivazioni politiche ben definite (la stessa Cooper era indecisa se interpretarlo come uno scherzo o una performance situazionista finché non lesse una dichiarazione postuma di Post che ne rivendicava la serietà), lasciò il segno nell’opinione pubblica e contribuì sicuramente ad avviare la conversazione sui corpi grassi e sulla loro condizione.
Nello stesso anno, sul “Saturday Evening Post”, uscì un articolo scritto da Llewellyn Louderback dal titolo provocatorio, More People Should Be Fat (Più persone dovrebbero essere grasse): pur essendo grasso, Louderback scrisse l’articolo principalmente in difesa di sua moglie e delle donne grasse, riconoscendo come queste ultime fossero maggiormente vessate per il loro peso, e parlò di temi come la discriminazione sul lavoro, l’industria delle diete, gli standard di bellezza e il classismo.
Bill Fabrey, a sua volta marito di una donna grassa, rimase talmente colpito dall’articolo che chiamò ogni Louderback sull’elenco telefonico fino a che non riuscì a contattare Llewellyn per proporgli la fondazione di un’associazione per la difesa dei diritti delle persone grasse. C’è anche da dire che questo gesto romantico di Fabrey – il quale racconta che pensò all’associazione come regalo per sua moglie dopo aver trascorso una giornata intera a cercare invano un regalo della sua taglia – non era del tutto privo di tornaconto personale (come anche quello di Louderback): nel liberare i corpi grassi dallo stigma, quella vecchia volpe di Bill voleva anche liberare se stesso dalle discriminazioni che subiva in quanto fat admirer, ovvero uomo che preferiva le donne grasse. Louderback accettò la proposta, ma non volle ricoprire cariche istituzionali nell’associazione, così fu Fabrey a diventare il presidente della neonata NAAFA (National Association to Advance Fat Acceptance).
La NAAFA costituiva un importante passo avanti nella storia dell’attivismo per la liberazione dei corpi grassi, ma c’era anche un problemino di sbilanciamento di potere mica da nulla: fondata da due uomini attratti dalle donne grasse, l’associazione divenne una sorta di club per cuori solitari in cui i fat admirer potevano interagire con l’oggetto dei loro desideri, e questo creò ovviamente delle situazioni spiacevoli tra attenzioni non richieste e marginalizzazione delle donne non eteronormate. Un ambiente fondamentalmente patriarcale quindi, dove le donne avevano poca voce in capitolo (le stesse mogli dei fondatori, Anne Fabrey e Joyce Louderback, comparivano come motivazione ma non come parte attiva), dove vigeva un clima conservatore, eteronormativo, spesso in aperto conflitto con le femministe e le lesbiche oppure che utilizzava un femminismo paraculo, come token, tanto per scrollarsi di dosso le accuse di maschilismo. In un ambiente del genere le donne non interessate a incontrare potenziali partner e quelle non eteronormate avevano poco spazio e poca autonomia come soggetti politici.
A RISOLVERE QUESTI PUNTI CRITICI, FORTUNATAMENTE, PENSÒ IL COLLETTIVO FEMMINISTA DAL LEGGENDARIO NOME DI “THE FAT UNDERGROUND”.
Fondato da Judy Freespirit e Aldebaran, due femministe ebree che operavano nel campo della terapia radicale e autrici in seguito del Fat Liberation Manifesto, The Fat Underground nacque dopo il tentativo fallito, nel 1973, di portare il femminismo all’interno della NAAFA. Come ricorda la stessa Freespirit, il loro approccio era decisamente più radicale: mentre NAAFA cercava di ispirare simpatia con il volontariato, sperando che l’immagine della persona grassa gentile e mansueta ispirasse la gente a essere un po’ meno stronza, The Fat Underground non cercava la simpatia di nessuno ma faceva irruzione ai convegni sulle diete e in qualunque altro luogo ritenesse di oppressione con l’intento di disturbare e di provocare.
Non vi nascondiamo che questo è il nostro genere e che siamo esaltate come degli ultras mentre scriviamo questo paragrafo.
Queste Avenger della grassezza non avevano leader, gerarchia, tesseramenti o regole ferree, ma produssero, nei pochi anni di vita del collettivo, materiali importantissimi, teorizzarono per la prima volta l’oppressione del corpo grasso in una prospettiva correlata a tutte le altre oppressioni, misero in discussione l’establishment medico e la cultura delle diete e raccolsero testimonianze scritte e video (tra cui quello intitolato appunto The Fat Underground e reperibile su YouTube grazie a Charlotte Cooper). I risultati di questo lavoro si riflettono nella pubblicazione del Fat Liberation Manifesto e di Shadow on a Tightrope, una raccolta di scritti di donne grasse. Le istanze del gruppo, anche dopo il suo scioglimento nel 1976, si diffusero attraverso le reti e le pubblicazioni femministe lesbiche e ispirarono la formazione spontanea di altri gruppi di attiviste grasse non solo negli Stati Uniti ma anche in Gran Bretagna nel corso degli anni Ottanta e Novanta.
Intendiamoci, il fat feminism non era perfetto, e dove sradicava alcune forme di oppressione ne perpetrava talvolta altre: è emblematica, per esempio, l’assenza delle donne nere tra quelle che vengono ricordate come le fondatrici del movimento e la loro sparizione dalla storia (come, ahinoi, accade troppo spesso), nonostante la stessa Judy Freespirit ricordasse quanto la fat acceptance fosse in debito con il movimento per i diritti civili, il black power e le attiviste nere, e nonostante la grassofobia abbia proprio il razzismo come origine principale. Ci sembra quindi doveroso ricordare alcune donne nere di cui sono rimasti scritti che affrontano il tema dei corpi grassi: Margaret K. Bass – che nel suo saggio On Being a Fat Black Girl in a Fat-Hating Culture (Sull’essere una ragazza nera grassa in una cultura che odia il grasso) racconta la sua esperienza di segregazione razziale, pregiudizio e odio per il proprio corpo vissuta negli anni Cinquanta e Sessanta – e Johnnie Tillmon, attivista welfare, che nel 1972 raccontava come la sua condizione di donna nera, grassa e povera che viveva grazie ai sussidi la mettesse in una posizione particolarmente sfavorevole perché situata all’intersezione di varie identità marginalizzate.
Tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, comunque, il fat feminism iniziò ad andare in stallo e a essere colonizzato da discorsi body positive centrati sull’immagine corporea. Il discorso femminista sui corpi grassi conti...