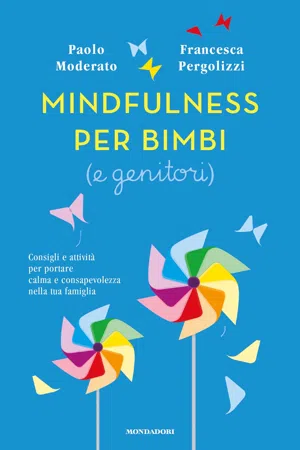La parola inglese “mindfulness” è la traduzione del termine sanscrito sati, che esprime i concetti di consapevolezza, attenzione e ricordo.
La pratica della consapevolezza fu insegnata più di due millenni fa dal principe Siddharta Gotama (circa 566-486 a.C.), conosciuto come il Buddha, un uomo che, dopo anni di sforzi e ricerca dell’illuminazione, ritrovò e scoprì la nobile verità, ossia la sofferenza umana, da cui non ci si può sottrarre essendo connaturata all’esistenza dell’uomo.
Nella tradizione buddhista si differenziano due tipi di correnti: la tradizione Theravada (scuola degli anziani) è la corrente più conservativa ed è praticata nella zona meridionale e orientale dell’Asia da più di 2500 anni; mentre la Mahayana (grande veicolo) è la corrente più recente, si è diffusa nei primi secoli dell’era cristiana in Asia orientale e ha dato origine alla corrente giapponese zen.
La moderna pratica di mindfulness si è sviluppata dalla tradizione Theravada, che comprende due tipi di meditazione: la samatha, che pone attenzione sulla concentrazione e sulla quiete, e la vipassana, centrata sulla consapevolezza, che ha avuto più successo nel mondo occidentale. Queste due pratiche sono interdipendenti e, insieme, costituiscono la mindfulness.
La meditazione viene definita in modi differenti a seconda delle tradizioni contemplative. Secondo Matthieu Ricard, monaco tibetano e scrittore francese, questo termine indica la “familiarizzazione” con una nuova visione delle cose e un nuovo modo di trattare e conoscere i nostri pensieri, le relazioni con gli altri e con il mondo vivente.
Nella tradizione buddhista, la mindfulness centrata sulla consapevolezza si insegna attraverso la pratica della contemplazione del corpo, del respiro, delle sensazioni e della mente. La consapevolezza implica un’attenzione intenzionalmente focalizzata su ciò che sta accadendo qui e ora. A ciò si aggiunge una componente importante: l’accettazione, cioè l’atteggiamento non giudicante verso la propria esperienza, l’aspetto più difficile nella pratica della mindfulness.
Con la mindfulness possiamo accedere a una consapevolezza profonda dei nostri processi mentali e, nel contempo, ottenere chiarezza dei nostri stati d’animo nel momento presente. Questo atteggiamento ci aiuta a sviluppare la disponibilità a osservare e accogliere le esperienze dentro e fuori di noi così come si manifestano. La disponibilità è una posizione di apertura all’esperienza nel presente, senza che necessariamente ci piaccia.
Per poter apprezzare tutti i momenti che il presente ci riserva è necessario imparare a vedere e accettare anche il dolore come parte importante e integrante della nostra vita. “Dobbiamo imparare a riconoscere e persino ad abbracciare la sofferenza, mentre la nostra consapevolezza di essa ci aiuta a crescere.” Questo ci insegna Thich Nhat Hanh, un monaco zen vietnamita, poeta e costruttore di pace, una delle figure più rappresentative, assieme al Dalai Lama, del buddhismo contemporaneo.
La mindfulness non è yoga, non è una religione, non è una moda hippie, non è spiritualità, non è una terapia, non è una filosofia di vita, non è una tecnica di rilassamento. La mindfulness è consapevolezza, è una pratica per sviluppare l’attenzione volontaria, è un’attitudine innata che ognuno di noi può allenare invitando la mente a rimanere attenta per esempio in un dato compito. Agire in maniera consapevole vuol dire prestare attenzione al momento in cui si vive una certa situazione, diminuire la reattività e avere una risposta circostanziata a uno stimolo esterno, immersa nello stimolo e riconducibile a esso. Agire con consapevolezza vuol dire allenare la propria mente ad affrontare le situazioni con più calma e presenza, e apprendere con maggiore curiosità e apertura.
La pratica della mindfulness è una delle forme più efficaci di rieducazione della mente alla consapevolezza, ma la sua applicazione può risultare difficile data la nostra abitudine alla distrazione e all’inconsapevolezza. Le parole di Siegel (2010) esprimono efficacemente il concetto: “Il modo migliore per misurare il nostro livello di consapevolezza consiste nel chiederci di esaminare i momenti di quotidiana distrazione”.
Tutti noi abbiamo pensieri che affiorano di continuo nella mente, ci procurano ogni giorno sofferenza, ci spingono a cercare il piacere per evitare il dolore, ci fanno vivere nel passato o ci proiettano nel futuro. Il tentativo di sbarazzarci del dolore non fa che amplificarlo, intrappolandoci ancora di più al suo interno, fino a trasformarlo in qualcosa di traumatico. L’unico risultato sarà quello di distoglierci dall’intensità del momento presente. Chiosa ironicamente Mark Twain: “Sono un uomo molto vecchio e ho avuto un gran mucchio di guai, la maggior parte dei quali non mi sono mai capitati”.
La pratica della mindfulness ci permette di scoprire la pienezza del qui e ora, di cogliere che i nostri pensieri sono solo pensieri, di sostenere in maniera efficace un’intera gamma di esperienze emotive e ci aiuta ad accogliere il dolore anziché evitarlo. Così facendo generiamo in noi la flessibilità psicologica, cioè la capacità di adattarci a una situazione con consapevolezza, curiosità e apertura, e possiamo intraprendere efficacemente azioni guidate dai nostri valori. Questo migliora la qualità della nostra vita, aiutandoci a gestire la sofferenza e a generare pace, comprensione e compassione.
La pratica della consapevolezza è un processo di apprendimento del tutto nuovo: la mente è abituata a pensare ai nostri bisogni e a come soddisfarli, e ci fa facilmente cadere nella trappola del controllo per guidare il processo esattamente dove vogliamo. Questo atteggiamento si contrappone a quello della consapevolezza, che richiede una pura attenzione verso il mondo senza cercare di modificare nulla.
La consapevolezza è sempre a nostra disposizione, ma a volte si mimetizza, come un animale timido. Pertanto ci vogliono esercizio e calma per farla uscire allo scoperto, e un po’ di attenzione e di motivazione per riuscire a coglierla.
La consapevolezza è alla portata di tutti: se apriamo le porte dei sensi possiamo vedere, udire, sentire, gustare, assaporare e notare senza farci agganciare dal chiacchiericcio della nostra mente.
I sette pilastri della pratica quotidiana
La pratica quotidiana della consapevolezza secondo Jon Kabat-Zinn (2004) si basa su sette importanti pilastri.
- Il non giudizio La nostra mente ha la straordinaria capacità di viaggiare nel tempo, generando emozioni e pensieri talvolta stupendi, altre volte meno. Sviluppare la capacità di notare questo processo, senza fornire connotazioni “bello” o “brutto” e osservando invece con curiosità le nostre “creature”, ci permette di riconoscerle senza subire la loro tirannia.
- La mente di un principiante Ogni momento è unico e contiene possibilità uniche. Occorre osservare il momento presente con gli occhi di un principiante che si avvicina per la prima volta a un’esperienza e divenire ricettivi alle varie possibilità per evitare di cadere nell’atteggiamento dell’esperto che crede di sapere più di quello che sa.
- Pazienza Ogni situazione ha un proprio tempo di maturazione, come la crisalide che si trasforma in farfalla. Essere pazienti significa accogliere il naturale sviluppo degli eventi nella nostra vita.
- Fiducia nelle proprie capacità Siamo unici e irripetibili e possiamo aspirare a divenire pienamente noi stessi. È importante apprendere dagli altri coltivando la propria autenticità e la fiducia in quello che siamo.
- Accettazione I cambiamenti nella nostra vita ci espongono a una molteplicità di emozioni, pensieri e scelte: l’accettazione di ognuno di essi è un atto di self-compassion e intelligenza. L’accettazione degli eventi così come si manifestano non significa rassegnazione, bensì disponibilità a notare la loro naturale impermanenza.
- Lasciare andare Un pensiero è solo un pensiero. Un’emozione è un insieme di sensazioni che attraversano il nostro corpo in un preciso momento. Possiamo coltivare la capacità di osservarle con curiosità, riconoscerle e lasciarle andare come fossero nuvole nel cielo, barche in mezzo al mare, macchine in continuo movimento.
- Impegno e autodisciplina Sono requisiti fondamentali per praticare la mindfulness in maniera efficace, proprio come per un atleta è importante allenarsi costantemente, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o dal proprio umore.
La pratica della consapevolezza può iniziare con l’osservazione del respiro. Il respiro è un po’ come ritornare a casa, il luogo della pace e della tranquillità. È sempre con noi, ovunque siamo. L’osservazione del respiro si può praticare sempre. Se riusciamo a prenderci qualche minuto per respirare in consapevolezza, possiamo notare la calma nel corpo, nei sentimenti, nelle percezioni, e come cresca uno stupendo senso di gioia e di pace.
Per Thich Nhat Hanh la mindfulness e la concentrazione sono la via per scoprire la felicità e la gioia insite nelle piccole azioni quotidiane. La consapevolezza del corpo, del camminare, del cibo, della natura sono alcune delle pratiche che possono essere coltivate per il nostro benessere e la qualità della nostra vita. Riuscire a essere consapevoli delle foglie cadute per terra, del colore delle nuvole, del sole che scalda, del vociare dei bambini al parco, delle macchine che sfrecciano sulle strade, del sorriso di nostro figlio, dell’abbraccio di un amico, del gesto di gentilezza di uno sconosciuto, tutto ciò appartiene alla definizione di felicità. Non è possibile essere felici nel futuro, solo nel presente.
Non è una questione di credenza, bensì di esperienza.
La ricerca scientifica sugli effetti
della mindfulness
Negli ultimi trent’anni diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato gli effetti straordinari della mindfulness in campo medico, concludendo che un rilassamento profondo in piena coscienza non ottunde l’attenzione bensì la potenzia. Una riduzione dell’attivazione del sistema ortosimpatico e dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene conduce a una conseguente riduzione dello stress e a una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti della vita.
Anche sul versante psicologico e psicoterapeutico la mindfulness ha effetti importanti: favorisce un atteggiamento non giudicante verso sé e gli altri; aiuta le persone ad adattarsi in situazioni incerte, instabili e stressanti e le stimola a prendere contatto con se stesse e con la propria coscienza; sviluppa la responsabilità personale, la compassione, l’empatia e il senso di accettazione verso la realtà e previene i comportamenti impulsivi e compulsivi e il rimuginio patologico (fattore che può condurre chi è predisposto a episodi depressivi).
Un’altra area di ricerca, che accresce l’interesse nella mindfulness, è quella sulla neuro-plasticità, cioè la capacità del cervello di cambiare la sua organizzazione e la sua struttura in base alla sua stessa attività. Sappiamo, infatti, che i neuroni che si attivano insieme potenziano la forza dei collegamenti tra loro stessi, e che l’attività mentale della meditazione attiva specifiche aree del cervello. Sara Lazar et al. (2015), dopo anni di pratica meditativa, hanno dimostrato che la corteccia di aree del cervello associate alla percezione (somatosensoriale, uditiva, visiva e interocettiva) e all’attenzione diventa più spessa. Richard Davidson et al. (2003) dell’Università del Wisconsin hanno riscontrato che, dopo solo otto settimane di training di mindfulness, aumenta l’attività nella corteccia prefrontale sinistra. L’attivazione di quest’area è associata alle sensazioni di benessere, come pure l’aumento dell’attività metabolica in questa parte del cervello è correlato alla forza della risposta immunitaria al vaccino contro l’influenza. Modificazioni ancora più significative si trovano nel cervello dei monaci tibetani che hanno un’esperienza di pratica meditativa compresa tra le 10.000 e le 50.000 ore.
Gli studi sperimentali stanno confermando ciò che i meditatori avevano ipotizzato, e cioè che allenare la mente modifica il cervello. Negli anni Ottanta del secolo scorso numerose ricerche hanno rilevato l’efficacia clinica della meditazione e delle prospettive basate sulla mindfulness sia nei confronti di malattie psichiatriche (come depressione, disturbi d’ansia, disturbi alimentari, abuso di sostanze) sia di disturbi di tipo medico (ipertensione, cefalee, dolori cronici, psoriasi e molti altri, in combinazione con i farmaci appropriati (Benson e Proktor, 2010).
PROTOCOLLI TERAPEUTICI BASATI SULLA MINDFULNESS
Negli ultimi trent’anni sono stati sviluppati protocolli e modelli psicoterapeutici basati su pratiche di mindfulness che hanno dimostrato la loro efficacia: la Mindfulness based stress reduction (MBSR), la Mindfulness based cognitive therapy (MBCT), la Dialectical behavior therapy (DBT) e l’Acceptance and commitment therapy (ACT).
Il primo a sperimentare le applicazioni cliniche della mindfulness fu Jon Kabat-Zinn che già alla fine degli anni Settanta aveva elaborato un programma in ambito ospedaliero per persone che soffrivano di malattie e alle quali la medicina ufficiale non poteva più proporre cure oppure non dava gli esiti sperati. Si trattava di persone con dolore fisico, debilitate dallo stress della malattia e della vita. Il programma, denominato Mindfulness based stress reduction (MBSR), consisteva nell’insegnare ai pazienti ad ascoltare le proprie sensazioni dolorose, accettando anche gli stati interni conseguenti. Questo programma, che prevedeva interventi di gruppo sui pazienti, evidenziò una marcata riduzione della gravità e della frequenza del dolore, oltre che dei disturbi dell’umore, anche in follow-up a tre-quattro anni di distanza. Il programma si basava sul principio per cui l’osservazione non giudicante delle proprie sensazioni di dolore fisico, delle emozioni e dei pensieri derivati da stress permetteva alle persone di sperimentare che si trattava di esperienze temporanee dalle quali non c’era bisogno di fuggire. Di conseguenza, le emozioni negative associate nel passato gradualmente scomparivano, con l’effetto di liberare i pazienti dalla sofferenza che il dolore oppure lo stress avevano provocato. L’effetto secondario fu quello di abbassare anche la percezione del dolore.
Tra le terapie derivate dal MBSR, una delle più diffuse e validate scientificamente è la Mindfulness based cognitive therapy (MBCT), che è rivolta a persone affette da depressione maggiore e mira alla prevenzione delle ricadute (Segal et al., 2002). Anche in questo caso, attraverso la mindfulness i pazienti portavano la propria consapevolezza su eventi negativi che la vita aveva riservato loro, senza cercare di allontanare da sé le emozioni spiacevoli conseguenti, dunque senza ricorrere alle consuete modalità di fuga. Così essi si accorgevano che tali emozioni, come erano arrivate, allo stesso modo se ne andavano. Inoltre, il contatto con il momento presente evitava loro di cadere nella ruminazione come in passato.
Per il trattamento di persone con disturbo borderline di personalità e con alto rischio suicidario, Marsha Linehan ha sviluppato la Dialectical behavioral therapy (DBT), che ha la propria specificità nel connubio fra accettazione e cambiamento. La DBT si è evoluta dalla terapia comportamentale classica che, a causa di un’attenzione rivolta unicamente al cambiamento, non aveva mostrato risultati soddisfacenti in alcuni pazienti, i quali infatti reagivano con atteggiamenti difensivi e/o aggressivi. La componente di accettazione propria della DBT, che fa riferimento alla mindfulness, consiste nella validazione della sofferenza del paziente. Il terapeuta diviene consapevole del suo stato psicologico e del fatto che i suoi comportamenti in seduta possono ferire o deludere. D’altra parte il paziente, attraverso la mindfulness, può vedere il proprio dolore come una naturale conseguenza ...