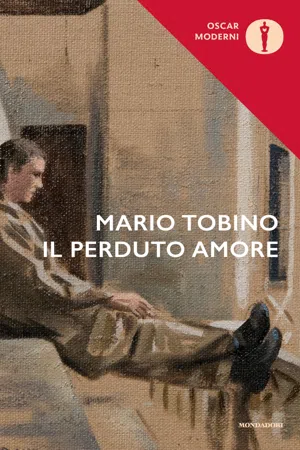«Signor capitano, signor capitano!» e, senza entrare, agitava con insistenza la tenda che fungeva da porta.
«Chi è?» rispose per lui il tenente Alfredo.
«Sono io, Buzzi. È successa una disgrazia.»
«Come? Vengo subito.» Il tenente in pigiama saltò dalla branda e andò verso Buzzi.
«Il tenente Cassuto ha ucciso l’altro Cassuto, Cassuto Mario.»
«Come?»
«Adesso, mentre si andava a letto. Cassuto, l’altro, Cassuto Filippo, scherzava con quel suo modo eccitato, battute sempre stira e, e mentre si levava i calzoni – aveva la rivoltella in tasca – e almanaccava per accompagnare chissà che stupido discorso, è partito un colpo. Lo deve aver preso al cuore. Cassuto Mario che era in piedi davanti a lui ha messo una mano al petto: “Muoio...” è riuscito a dire, ed è cascato giù, gli occhi aperti, già non respirava.»
«Dobbiamo svegliare il capitano. Accidenti, che disgrazia! Per tutti e due. Eh, sì! anche per l’altro, per l’uccisore, sia pure accidentale. Gli altri ufficiali erano presenti?»
«Sì, tutti. Sono rimasti lì, nella baracca. Cassuto ha nel volto una calma, come sorridesse.»
Il capitano continuava a russare fragorosamente. Era un suo disturbo, una malformazione delle fosse nasali e del palato. Appena addormentato iniziava la fanfara. L’aveva preannunciato agli altri due medici, il tenente Alfredo e il tenente Gianfigliazzi: «Vi inviterei a dormire con me, nella tenda 9 × 11; è troppo grande per me solo. Ma badate che russo, e che tamburo! Io non me ne accorgo, ma la mattina dopo, chi ha dormito con me...».
«Che vuole che sia! Tutti russano qualche notte» e poiché la baracca ufficiali era ormai zeppa, accettarono l’ospitalità. Si accorsero poi i due tenenti medici di che potenza era quel russamento, ma insomma erano giovani e scivolavano lo stesso nel sonno.
Il capitano fu svegliato; se ne incaricò il tenente Alfredo stiracchiandolo per una spalla. Era una faccenda grossa: un ufficiale che uccideva, sia pure occasionalmente, un altro ufficiale.
Il tenente Alfredo dovette usare maggiore energia e alla fine fu come se il capitano salisse su lentamente alla luce da un pozzo: «Come? che è successo? perché? chi? ucciso? chi è stato? dove?».
Era stato acceso il lume Petromax che gettava un bagliore livido nell’interno della tenda.
«Signor capitano, una grave disgrazia. Al tenente Cassuto, quello che si chiama Filippo, mentre si spogliava, per caso, gli è partito un colpo dalla pistola e ha colpito il Cassuto Mario... sa, quei due che hanno lo stesso cognome. È morto subito, lo deve aver preso al cuore.»
Il capitano Trenta, ormai ben sveglio, si alterò nel volto, si annerì come gli fosse passato per i lineamenti una spolveratura di fuliggine:
«Come? come? Ancora!» gridò. «Nessuna disciplina. Che cos’è questo ospedale? Che soldati!»
Nei giorni precedenti il capitano Trenta, che era di famiglia militare, ligio al Regolamento, al dovere, già si era sfogato con i due tenenti che dormivano con lui: «Molti ufficiali mancano di marzialità, dell’energia, lo scatto che deve avere chi porta le stellette».
Aveva con disdegno ripetuto: «Faciloni, melensi, battono il passo».
Ed ora questo doloroso e scombiccherato incidente. Il capitano, vestendosi, fu informato con maggior precisione, con più diffusi particolari, che poi in sostanza erano quelli stessi già saputi.
«Andiamo, andiamo a vederlo.»
L’ospedale da campo 129 era disteso in un valloncello del Gebel. Le grandi tende bianche, che sotto i raggi della luna avevano del sogno, sembravano esprimere il profondo desiderio di pace che c’è nel cuore degli uomini.
Dalla 9 × 11 alla baracca, dove dormivano gli ufficiali medici, distavano neppure cento metri. Il capitano Trenta si mise alla testa dell’esiguo drappello: la sua gamba rigida, anchilosata, falciava rabbiosa. Il percorso fu compiuto in tutto silenzio.
Cassuto, Cassuto Mario, era steso sul pavimento così come era caduto; gli occhi chiari, aperti. Era stato lasciato lì per consiglio di un tenente medico ex medico condotto:
«Morte violenta, non va toccato. Aspettiamo il comandante.»
Cassuto aveva le gambe un po’ divaricate come i bambini da poco nati, quando la mamma si prepara a pulirli.
Il capitano Trenta, ancora scuro in faccia, ascoltò di nuovo come si era svolto il fatto. L’occasionale uccisore era in un angolo; piangeva convulsivamente, mormorava a tratti: «L’ho ucciso io, l’ho ucciso io» e si stringeva le tempie con le palme delle mani.
«Dov’è l’aiutante maggiore?» chiese il capitano mirando davanti a sé.
«È andato ad avvertire le crocerossine.»
«Bene» consentì il comandante.
Il tenente che aveva ucciso, sia pure per caso, era divenuto un appestato. Nessuno gli rivolgeva la parola, nessuno lo guardava, non gli era stato fatto nemmeno un povero commento di conforto per la disgrazia che gli era caduta addosso.
Il capitano aveva intorno il capannello di ufficiali medici. Decise:
«Deve essere disarmato. Agli arresti. Mettetelo nello sgabuzzino vicino al comando, la stanzetta che serve per fureria.
«Tenente Del Maestro se ne occupi lei, che è il più anziano.»
«Signorsì.»
“Ed ora? Debbo avvertire l’Alto Comando? telefonare a Barce?” si domandò il capitano. Per un attimo pensò a suo padre, generale medico, quando l’avrebbe saputo. “Che grana mi è capitata, e appena dieci giorni dopo che ho preso il comando.”
«Allora, portatelo nella fureria, disarmato» ripeté.
Il tenente medico Cassuto, Cassuto Filippo, l’uccisore, era un giovane grassoccio, rosso in viso, la voce stridula, quasi di continuo dominato dall’irritazione e dalla burla, come avesse i nervi a fior di pelle e a ogni momento tentasse di nasconderli, di foderarli con le celie; e presto ci si accorgeva che non era riuscito nel suo intento. Insomma un nevrastenico, un nevrastenico alla guerra.
A tavola di più svelava la sua instabile natura: alla vana ricerca di un equilibrio, bevicchiava.
Quella sera, nella baracca, almanaccando più sventatamente del solito, era partito il colpo.
Accompagnate dall’aiutante maggiore, arrivarono due delle crocerossine: la Ludovisi e la Cirié. Si erano vestite in fretta; purtuttavia la benda intorno al viso e il bianco colletto erano stati messi con la solita accuratezza.
Le crocerossine dormivano lì vicino, in una casa araba che era stata requisita. Un lungo corridoio sul fianco della casa era l’unico luogo coperto, tutto il resto, le altre stanze, erano senza tetto. Si alzava il viso e si mirava la moltitudine delle stelle.
E c’era un perché nell’arrivo proprio di queste due crocerossine. Da svegliare sarebbe stata soltanto la Ludovisi ma non si poteva chiamare lei senza destare anche la Cirié, che dormiva nella stessa stanzetta.
Il segreto, conosciuto da tutti, era che il Cassuto, l’ucciso, era perdutamente innamorato della Ludovisi. Lavoravano insieme nello stesso tendone-ricovero.
Subito dopo che era caduto, senza più anima, un ufficiale presente aveva mormorato con un certo sgomento:
«Non ha fatto a tempo neppure a dire il suo nome.»
Tutti avevano compreso.
«Almeno chiamiamola subito, che sia lei la prima a salutarlo.»
L’aiutante maggiore si era avviato verso la casa araba.
La Ludovisi – l’amata – entrò, dette una fuggitiva occhiata al giovane sul pavimento, ebbe uno stridulo singhiozzo, voltò il viso, strinse il braccio della Cirié; in fretta uscì dalla baracca.
Intanto lo sfortunato uccisore, il tenente Cassuto Filippo, alzatosi in piedi, a testa china, quasi un recluso già abituato a supina ubbidienza, si accinse a seguire l’ufficiale incaricato di accompagnarlo nella stanzetta della fureria, poco più grande di una cabina balneare.
Gli ufficiali medici erano ormai tutti in divisa, come di giorno. Arrivarono anche le altre crocerossine.
Il capitano Trenta fece stendere l’ucciso sopra il suo lettino:
«A turno lo veglierete, finché ci daranno gli ordini» e si mise a confabulare con l’aiutante maggiore se era il caso di avvertire subito Barce, il Comando superiore di sanità o aspettare la mattina dopo. Insieme si avviarono verso il comando.
Gli altri ufficiali e le crocerossine rimasero nella baracca.
«La notte è andata. Come si fa a dormire vicino a uno che fino a un momento fa rideva e parlava con noi?»
«Che cotta aveva preso!»
Il gruppetto delle crocerossine se ne stava da un lato; sussurravano tra loro spaventate.
«Se ci facessimo fare il caffè?»
«All’altro che succederà?»
«Quasi niente, al massimo lo manderanno in prima linea, medico di battaglione.»
«Che dici!»
«Omicidio colposo.»
«Peggio. Grave disavvertenza con le armi. Un ufficiale.»
«Non esageriamo. Può capitare a tutti. Siamo in guerra. Ai Comandi hanno ben altro da pensare, con quel che si sta minacciando.»
«Vado io a svegliare i cucinieri e ordino il caffè per tutti» si interpose con una certa energica stizza il tenente Alfredo. «Non so ancora bene; dove dormono i cucinieri?»
«Qui subito dietro, proprio accanto alla cucina. C’è una sola tenda. Non puoi sbagliare.»
«Bene, vado. Quanti siamo? Meglio abbondare.»
Il tenente Alfredo da pochi giorni era stato trasferito a quell’ospedale. Veniva dal fronte, aveva passato molti mesi in prima linea, in Marmarica, per quasi tutto l’assedio di Tobruk, alla battaglia di Passo Halfaya. Era ancora carico di visioni, giovani che muoiono, sete, acutissime nostalgie per l’Italia. Aveva la certezza che sarebbe morto in Libia, in un qualche punto di uno degli sterminati deserti. Ancora gravido, sudato, di quella vita dolorosa di soldato, non si trovava a suo agio in quell’ospedale, tutto composto da ufficiali che alla guerra, quella vera, non c’erano mai stati, e, appena poteva, fuggiva dai loro discorsi, dalla loro presenza. Per questo si era perentoriamente offerto di occuparsi lui del caffè, svegliare i cucinieri, e starsene con loro finché fosse versato fumante nel bricco.
Respirò con liberazione l’aria notturna del Gebel, profumata dai tanti boschetti, dalle svariate erbe e pianticelle che ogni giorno col fuoco del sole si nascondono tra le mani il capino e poi ogni notte, per la benedetta rugiada, riaprono felici tutte se stesse.
Il tenente Alfredo alzò il telo della tenda.
«Svegliatevi, sono un tenente medico. È successo qualcosa.»
Erano in quattro. Dormivano come sogliono i giovani, beatamente.
Alfredo dovette ripetere con voce più concitata:
«Avanti. Svegliatevi.» Dentro la tenda penetrarono i raggi della luna.
Uno dopo l’altro aprirono gli occhi, lo sguardo confuso e interrogativo.
«È morto il tenente Cassuto.»
I quattro soldati non dettero segno né di emozione né di curiosità.
Il tenente Alfredo si introdusse un poco di più dentro la tenda e con piglio più autoritario:
«Dovete alzarvi a fare il caffè. Per quindici, venti persone. Anche per voi» aggiunse. «Lo aspettano; anche per il capitano. Siete della mensa ufficiali, no?»
I soldati si rimuginarono cominciando ad ubbidire. Il ...