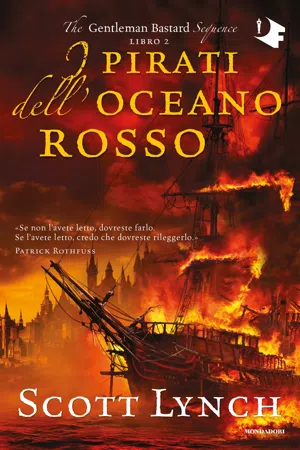1
Il gioco era la Giostra dell’Azzardo, la posta era grosso modo la metà di tutte le ricchezze che possedevano al mondo e la semplice verità era che Locke Lamora e Jean Tannen se le stavano prendendo come un paio di tappeti impolverati.
«Ultima offerta per la quinta mano» annunciò il valletto in giacca di velluto dal suo podio, di fianco al tavolo rotondo.
«I signori decidono di prendere nuove carte?»
«No, no… I signori decidono di conferire» rispose Locke, chinandosi verso sinistra e avvicinando la bocca all’orecchio di Jean. Ridusse la voce a un sussurro. «Com’è la tua mano?»
«Arido deserto» mormorò Jean, portandosi la mano destra sopra la bocca con studiata indifferenza. «E la tua?»
«Terra desolata di amara delusione.»
«Merda.»
«Abbiamo forse trascurato le nostre preghiere, questa settimana? Uno di noi ha scorreggiato in un tempio, o che?»
«Pensavo che la previsione di perdere facesse parte del piano.»
«Infatti. Però speravo che saremmo riusciti a batterci un po’ meglio di così.»
Il valletto tossì nella mano sinistra, contegnoso: l’equivalente, per il tavolo delle carte, di uno scappellotto sulla nuca a Locke e Jean. Locke si scostò dall’amico, picchiettò lievemente le dita sulle carte appoggiate alla superficie laccata del tavolo e si esibì nel miglior sorriso “so-quel-che-faccio” che riuscisse a evocare dal suo arsenale facciale. Sospirò tra sé, guardando la considerevole pila di gettoni di legno sul punto di compiere il breve viaggio dal centro del tavolo al mucchietto del suo avversario.
«Siamo, naturalmente, pronti a incontrare il nostro destino con eroico stoicismo, degno della menzione di storici e poeti» annunciò.
Il mazziere annuì. «Le signore e i signori declinano l’ultima offerta. La casa chiama le ultime mani.»
Vi fu una frenesia di mescolamenti e scarti quando i giocatori composero le ultime mani e le posarono, a faccia in giù, di fronte a sé sul tavolo.
«Benissimo» disse il mazziere. «Voltate e scoprite.»
I sessanta o settanta più ricchi perdigiorno di Tal Verrar che avevano affollato la stanza dietro di loro per osservare lo svolgersi di ogni piega dell’umiliazione di Locke e Jean, in quel momento si chinarono in avanti come un sol uomo, ansiosi di vedere quanto si sarebbero trovati in imbarazzo questa volta.
2
Tal Verrar, la Rosa degli Dei, all’estremo margine occidentale di quello che il popolo Therin chiama il mondo civile. Potendo star sospesi nell’aria un migliaio di metri sopra le torri più alte di Tal Verrar, o librarsi lassù in pigri cerchi come le nazioni di gabbiani che infestano le fenditure e i tetti della città, si vedrebbe perché le sue vaste isole scure hanno conferito a quel luogo il suo antico nomignolo. Esse vorticano dal cuore della città verso l’esterno, una serie di mezzelune via via più grandi, come i petali stilizzati di una rosa nel mosaico di un artista.
Non sono naturali com’è naturale la terraferma che si profila qualche miglio a nordest. La terraferma si screpola al vento e alle intemperie, rivelando la sua età; le isole di Tal Verrar sono incorrotte, probabilmente incorruttibili… Sono fatte del vetro nero degli Avi, in quantità inimmaginabili, disposto in falde infinite e attraversato da una miriade di passaggi, rivestito da strati di pietra e terra da cui sorge una città di uomini e di donne.
Questa Rosa degli Dei è circondata da una barriera artificiale, un cerchio spezzato di tre miglia di diametro, ombre sotto le onde ombrose. Da tale muraglia nascosta, l’impetuoso Mar dell’Ottone viene placato per lasciar passare vascelli battenti bandiere di cento regni e domini. I loro alberi e pennoni si levano in una foresta, bianca di vele serrate, ben al di sotto dei vostri piedi.
Potendo volgere lo sguardo all’isola occidentale della città, si vedrebbe che le sue superfici interne sono pareti nere a strapiombo, tuffate per decine di metri tra le onde del porto che dolcemente le lambiscono, dove un reticolo di pontili di legno si aggrappa alla base delle scogliere. Il lato dell’isola esposto al mare aperto, comunque, è disposto in strati per tutta la sua estensione. Sei ampi ripiani rocciosi sono collocati uno sopra l’altro, tutti sostenuti, a eccezione del più alto, da lisce scarpate di una quindicina di metri.
Il distretto più meridionale di quest’isola si chiama Gradini d’Oro; i suoi sei livelli sono gremiti di taverne, covi di giocatori di dadi, bordelli e arene di combattimento. I Gradini d’Oro sono noti come la capitale del gioco d’azzardo delle città-stato Therin, un luogo in cui uomini e donne possono perdere denaro su qualunque cosa, dai vizi più veniali ai crimini più efferati. Le autorità di Tal Verrar, in un magnanimo gesto di ospitalità, hanno decretato che nessuno straniero sui Gradini d’Oro può essere ridotto in schiavitù. Di conseguenza, in pochi luoghi a ovest di Camorr un forestiero può prendersi sonore sbronze e addormentarsi in vicoli e giardini con più sicurezza.
Sui Gradini d’Oro vige una rigida stratificazione: man mano che si sale di livello, la qualità degli esercizi aumenta, come pure la stazza, il numero e la veemenza delle guardie alle porte. A cingere i Gradini d’Oro vi è una dozzina di palazzi barocchi di antica pietra e legno di sorbo nero, incastonati tra lo sfarzo umido e verde di giardini ben curati e foreste in miniatura.
Sono le “case da gioco eccellenti” circoli esclusivi in cui uomini e donne facoltosi possono giocare d’azzardo con lo stile confacente alle loro lettere di credito. Da secoli queste case sono centri di potere in cui nobili, burocrati, mercanti, capitani di navi, legati e spie si riuniscono per giocarsi fortune, tanto personali quanto politiche.
In queste case si trova ogni possibile piacevolezza. Gli ospiti importanti salgono su cabine mobili ai pontili riservati, alla base delle scarpate del porto interno, e vengono trasportati in alto tramite lucenti motori ad acqua di ottone, evitando così le strette, tortuose e affollatissime rampe che salgono ai cinque Gradini più bassi, dal lato che si affaccia sul mare. C’è persino un campo da duello pubblico: un’ampia distesa d’erba ben curata nel centro esatto del piano più alto, in maniera tale che i più saldi di nervi non siano avvantaggiati quando qualcuno perde il sangue freddo.
Le case eccellenti sono sacrosante. Consuetudini più antiche e salde della legge proibiscono a soldati o poliziotti di mettervi piede, salvo per contrastare i crimini più atroci. Esse sono l’invidia di un intero continente: in nessun circolo straniero, per quanto lussuoso o esclusivo, si può davvero ritrovare la particolare atmosfera di un’autentica casa da gioco verrariana. E tutte, indistintamente, sfigurano al cospetto di Peccapicco.
Alta più di quarantacinque metri, la torre di Peccapicco si protende verso il cielo all’estremità meridionale del livello più alto dei Gradini, che è già quasi ottanta metri sopra il porto. Peccapicco è una torre di Vetrantico, splendente di una nera lucentezza perlacea. Un’ampia balconata adorna di lanterne alchemiche cinge tutti i suoi nove piani. Di notte, Peccapicco è una costellazione di luci scarlatte e blu crepuscolare, i colori araldici di Tal Verrar.
Peccapicco è la casa da gioco più esclusiva, più famigerata e più sorvegliata del mondo, aperta dal tramonto all’alba a chi sia sufficientemente potente, ricco o bello da riuscire a superare il capriccioso esame dei guardaportone. Salendo, ciascun piano supera quello inferiore per lusso, esclusività e livello di azzardo dei giochi consentiti. L’accesso a ogni piano superiore si guadagna col buon credito, il comportamento gradevole e l’impeccabilità nel giocare. Tra gli aspiranti, c’è chi spende anni di vita e migliaia di solari cercando di attirare l’attenzione del signore di Peccapicco, la cui salda e inflessibile posizione lo ha reso l’arbitro più potente dell’approvazione sociale nella storia della città.
Il codice di comportamento a Peccapicco non è scritto, ma è rigido come un culto religioso. Molto semplicemente, incontrovertibilmente, venire sorpresi a barare qui significa morte. Se l’Arconte di Tal Verrar in persona fosse trovato con una carta nella manica, non potrebbe appellarsi neppure agli stessi dei per sfuggire alle conseguenze. A intervalli di qualche mese, i sorveglianti della torre scoprono alcune aspiranti eccezioni alla regola, e un’altra persona muore in silenzio di overdose alchemica nella sua cabina mobile, o “scivola” tragicamente dalla balconata nove piani sopra i duri sassi piatti del cortile di Peccapicco.
A Locke Lamora e Jean Tannen sono occorsi due anni e un assortimento completamente rinnovato di false identità per salire, a forza di barare con prudenza, fino al quinto piano.
Stanno in effetti barando proprio in questo momento, facendo di tutto per tenersi al passo con avversari che non hanno nessun bisogno di fare altrettanto.
3
«Le signore scoprono una serie di picchi e una serie di sciabole, coronate dal sigillo del sole» annunciò il valletto. «I signori scoprono una serie di calici e una mano mista, coronata dal cinque di calici. La quinta mano va alle signore.»
Locke si morse l’interno della guancia mentre un’onda di applausi increspava l’aria calda della stanza. Fino a quel momento, le signore si erano aggiudicate quattro mani su cinque e la folla si era a malapena degnata di notare l’unica vittoria di Locke e Jean.
«Be’, accidenti» esclamò Jean, con sorpresa finta ma convincente.
Locke si rivolse all’avversaria alla sua destra. Maracosa Durenna era una donna snella, di carnagione scura, prossima ai quarant’anni, con folti capelli color fumo di petrolio e diverse cicatrici visibili sul collo e sugli avambracci. Nella mano destra aveva un sottile sigaro nero avvolto nel filo d’oro, e sul viso un sorriso contenuto, a labbra strette, di soddisfazione distaccata. Era evidente che il gioco non le richiedeva sforzi estremi.
Il valletto trasferì rapidamente la piccola pila di gettoni di legno perduti da Locke e Jean al lato del tavolo occupato dalle signore, con un lungo frustino; lo stesso che poi usò per spazzar via dal tavolo tutte le carte e riprenderle in mano. Ai giocatori era severamente vietato toccare le carte dopo che il valletto aveva chiamato la scopertura.
«Bene, Madama Durenna,» disse Locke «le mie congratulazioni per lo stato sempre più pingue delle vostre finanze. Parrebbe che il vostro portamonete sia l’unica cosa che cresce più in fretta degli incombenti postumi della mia sbornia.» Locke fece rotolare un gettone sulle nocche della mano destra. Quel dischetto di legno valeva cinque solari, pressappoco otto mesi di paga per un comune operaio.
«Le mie condoglianze per un giro di carte particolarmente sfortunato, Mastro Kosta.» Madama Durenna aspirò una lunga tirata dal sigaro, poi esalò lentamente un filo di fumo che rimase sospeso nell’aria tra Locke e Jean, abbastanza distante da non costituire un affronto diretto. Locke era arrivato a capire che il fumo del sigaro era il suo strat péti, il suo “giochino”: un vezzo apparentemente civile, studiato per distrarre o irritare gli avversari al tavolo da gioco e indurli in errore. Jean aveva progettato di usare i propri sigari allo stesso scopo, ma Durenna aveva una mira migliore.
«Nessun giro di carte si può considerare realmente sfortunato, alla presenza di una coppia di avversarie tanto amabili» ribatté Locke.
«Riesco quasi ad ammirare un uomo capace di mantenersi tanto fascinosamente insincero mentre viene dissanguato di tutto il suo argento» disse la compagna di Durenna, seduta alla sua destra, tra lei e il mazziere.
Izmila Corvaleur aveva una stazz...