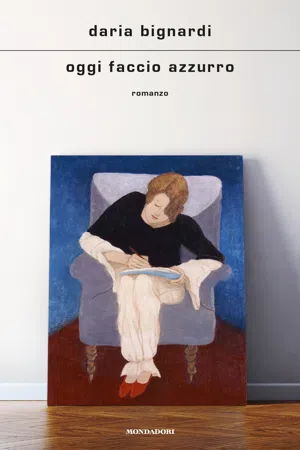![]()
Per E.S.
Metto solo le iniziali così non ti riconoscono.
![]()
![]()
Ho perso – per colpa mia – il mio grande amore.
«Deve trovare un colpevole e trova se stessa» dice la dottoressa Anna Del Fante pulendo le lenti degli occhiali rossi con la sciarpa azzurra.
Vengo da lei due volte alla settimana. Non le parlo dei pomeriggi passati a calcolare l’ora migliore per buttarmi dal balcone.
Preferirei farlo di notte, ma se non morissi e rimanessi agonizzante nel cortile? Abito al secondo piano, non al sesto. Forse di mattina è meglio. Le cinque del mattino sono un buon compromesso: silenzio, buio, ma il portinaio già alzato per portare i bidoni della spazzatura in strada si occuperà di smaltire anche il mio corpo, in tempo per risparmiarne la vista ai bambini che escono per andare a scuola.
«Buttaci lui dal balcone» spunta la Voce quando resto troppe ore sul divano a osservare la magnolia grandiflora del cortile. «Anche io volevo morire quando Vasilij se n’è andato. Non posso pensare che cent’anni dopo siamo ancora messe così.»
La Voce è comparsa il tredici di agosto, nel mezzo della mia prima estate senza Doug.
![]()
L’estate è un pozzo quando si sta male.
«Quando si viene violentate o abbandonate brutalmente come è successo a lei, prima si rimuove, poi ci si sente in colpa, e solo dopo qualche tempo si inizia a elaborare il lutto» aveva detto la dottoressa. «Capire di non essere amati da chi si ama è uno shock. Lei sta vivendo il momento peggiore, quello del senso di colpa. Vedrà che arriveranno anche la rabbia e il perdono.»
Anna Del Fante sa di cosa parla. Suo marito è morto investito da un’auto un anno fa. Me l’ha detto alla fine della prima seduta: «Glielo racconto perché sappia che il dolore ha dei tempi. Anche se il suo lutto è peggiore del mio: mio marito non ha scelto di abbandonarmi».
Anna Del Fante ha la mia età, ma si veste da anziana. Col pensiero le ho cambiato stile come quando lavoravo per le riviste di moda: starebbe bene con un taglio corto di Pier Moroni con collo scoperto e ciuffo mosso, via quegli occhialetti rossi da farmacia, via quei camicioni da mercato; camicie di Equipment, pantaloni di Biani, mocassini.
È alta, di giorno può fare a meno dei tacchi, anche se è un po’ larga di fianchi.
La Voce non sopporta Anna Del Fante. Credo che sia gelosa di lei.
Dice che è pasticciona e poco professionale: «Io Sigmund Freud l’ho conosciuto, bellezza, a Vienna, in Berggasse 19. Altro che questa qui».
![]()
Doug era un moralista, anche se la sua morale si applicava a tutti tranne che a se stesso. Cosa che rivendicava: «Meglio predicare bene anche se razzola male» diceva.
Gli piacevano i modi di dire italiani e li storpiava anche se vive qui da più di vent’anni.
La Voce gongola: «Anche Vasilij adorava i proverbi e i modi di dire, come tutti i russi. E anche lui dopo quindici anni in Germania li sbagliava ancora. Il suo preferito era Gestern hat er blau gemacht, Ieri ha fatto azzurro».
«Cosa vuol dire?» chiedo.
«È un modo di dire tedesco che viene dal Medioevo, quando gli artigiani vedevano il cielo solo nel giorno in cui non lavoravano. A Vasilij interessava l’effetto psichico dei colori. Ma che ne sai tu…»
Ogni tanto la Voce mi maltratta. I primi tempi ci restavo male, ora non più. Sostiene che sono viziata perché sono bella, mentre lei dice di essere stata bruttina.
Io sono nata a Comacchio e mi hanno chiamata Galla, come l’imperatrice romana Galla Placidia, quella del Mausoleo di Ravenna. A scuola mi prendevano in giro per quel nome assurdo e mi chiamavano Gialla per il colorito o Ragnetto per la magrezza. Ho provato a spiegare alla Voce che fino ai tredici anni ero un ragnetto magro e pallido, e che ci si sente per tutta la vita come si era da bambini. Mi sono sempre pensata Gialla e Ragnetto piuttosto che Galla l’imperatrice.
Ma la Voce non sente ragioni: per lei resto una bellezza, l’ex fotomodella sciocca. Chissà perché si occupa di me, se mi disprezza tanto?
![]()
La madre di Doug lavora in un negozio di abbigliamento sportivo. Lei sì che è bella, con un viso equino come quello di Doug.
Doug coi suoi genitori ha un rapporto cordiale e non li sente spesso. Diceva che ero io la sua famiglia e che non ricordava niente della sua infanzia tranne i pranzi del Ringraziamento con suo padre e i barbecue del quattro di luglio coi fidanzati di sua madre. Sua madre l’ho conosciuta che aveva la mia età di adesso e il petto sontuoso che io non avrò mai.
Quando Doug le ha detto del divorzio mi ha chiamato dall’America.
«Take your time, Gal» ha detto. «No pain, no gain.»
Quel giorno stavo malissimo e ho fatto l’errore di chiederle perché secondo lei Doug mi aveva lasciata.
«You’re so European» aveva risposto. «You’re such a difficult person.»
Mi ero offesa. Difficile io?
Poteva dirmi qualcosa di comprensivo, non so, che Doug non sapeva cosa fosse una famiglia visto che lei e suo padre non avevano mai vissuto insieme, invece aveva dato tutta la colpa a me, come una suocera degli anni Cinquanta.
Che poi, anch’io non ho mai visto i miei genitori insieme, però il senso della famiglia ce l’ho.
Volevo invecchiare con Doug, come le mie zie che condividono coi mariti sessant’anni di ricordi. Non riesco a capire come – dopo vent’anni in cui hai diviso tutto – si possa rinunciare a invecchiare insieme.
«Sei proprio tonta» mi sfotte la Voce. «Quelli non solo non vogliono invecchiare, ma neanche ricordare. Perché credi che cambino donna, che la scelgano più giovane, possibilmente una che li porti in palmo di mano e non gli rompa le scatole? Secondo te quella poverina di Nina von Andreevskij poteva permettersi di criticare il grande Vasilij Kandinskij?»
![]()
Doug era appena arrivato a Milano quando ci siamo incontrati. In agenzia mi avevano chiesto il favore di posare gratis per quel fotografo americano senza un soldo che doveva farsi un book.
Avevo venticinque anni, e invece che l’illustratrice – quello per cui avevo studiato – per puro caso da sette anni facevo la modella.
Era il periodo in cui andavo a ruba, per il taglio orientale degli occhi e il pallore del viso. Sono le caratteristiche della talassemia ereditata da mia madre, ma negli anni Novanta furono la mia fortuna.
«Scommetto che non ti ha mai ringraziata. Pensi che Vasilij mi sia stato grato per averlo amato, sostenuto e mantenuto per quattordici anni?» gracchia la Voce mentre piango sul divano. «Anche io l’ho incontrato a venticinque anni, sai bellezza? E lui ne aveva undici più di me.»
«In amore non si ringrazia» rispondo. Doug posso criticarlo solo io.
«Dove l’hai letto, nei Baci Perugina?» mi sfotte la Voce, ridendo soddisfatta. Si compiace quando dimostra di conoscere i nostri modi di dire.
![]()
La mia è una talassemia asintomatica, a parte un po’ di stanchezza e la pipì color caffè.
Mia madre invece è sempre stata TDT, trasfusione dipendente.
Era contenta quando le ho detto che sposavo Doug, perché in America la talassemia non esiste: noi talassemici non possiamo rischiare di far figli con un talassemico perché potrebbero nascere col morbo di Cooley.
Per fortuna mia madre è morta e non sa che Doug mi ha lasciato. Per lei ogni problema era colpa mia, e stavolta avrebbe avuto ragione.
Tutte le banalità che si dicono sul divorzio – quando è cruento come il mio – sono vere: è peggio di un lutto, è una ferita straziante, peggio di una malattia.
Alle malattie sono abituata, ma questa è un’amputazione violenta e senza anestesia.
Pensi: “Se la persona che amo mi rifiuta vuol dire che non valgo proprio niente”.
Se poi lo fa come Doug, all’improvviso e senza spiegazioni, ti senti un insetto schiacciato con la scarpa e gettato dalla finestra.
Forse è per quello che ho così tanta voglia di volare dal balcone.
Se proprio ci si deve separare servirebbe un rito di passaggio, come Marina Abramović e Ulay che hanno camminato l’una verso l’altro per novanta giorni sulla Muraglia cinese.
A me sarebbe bastato un periodo di pianti, spiegazioni, liti, tira e molla, come fanno tutti. Invece Doug si è tenuto tutto dentro, ha deciso da solo e me l’ha comunicato all’improvviso, dopo più di vent’anni insieme.
Rifiutandosi di parlarne mi ha inchiodato al ruolo della vittima. Solo il carnefice può liberarti, spiegarti il perché del male che ti ha fatto: me l’ha detto una ragazza che studia Criminologia, una del coro.
Da sei mesi canto in un coro di detenuti tossicodipendenti insieme ad altre volontarie. Vado in carcere due volte alla settimana. Anche io devo disintossicarmi.
«Col tempo saprà trasformare questo dolore» dice Anna Del Fante.
«E la paghi pure quella scema di strizzacervelli?» commenta la Voce.
Credo che l’affetto di Anna Del Fante per me la irriti, non fa che sparlare di lei.
«Non capisci che una psicanalista non deve provare affetto? Mica per niente si dice “affetto da una malattia”: affetto dalla tubercolosi, affetto dalla tisi. L’analista non deve affezionarsi, verboten!»
![]()
Da quando Doug mi ha lasciata sto bene solo dentro.
In carcere, invece che una donna lasciata dal marito, sono un’artista del coro. Il maestro ci chiama così quando vuole attirare la nostra attenzione: a volte durante le prove chiacchieriamo come a scuola e lo prendiamo in giro. Se esageriamo alza le braccia e ci richiama: «Artisti del coro!».
I detenuti che frequentano il coro sono una quarantina, noi volontarie dieci, poi ci sono tre operatrici della Asst e la direttrice dell’équipe. Le voci femminili sono fondamentali nel coro.
Una volontaria fa la veterinaria, due le insegnanti, una l’avvocata, una l’infermiera. Poi ci sono le quattro studentesse che vogliono specializzarsi in Criminologia.
Io sono l’unica che non lavora.
«Ecco il problema» tuona la Voce. «Quando ero depressa, anche se non dipingevo, l’arte mi scorreva dentro come un fiume carsico. Come pensi di uscirne se resti a disperarti sul divano? Riprendi a disegnare, vendi vestiti, fai qualcosa! Oggi avete tutte quegli aggeggi, come si chiamano, i fashion blog, Instagram. Svegliati, bellezza! È il 2019: una donna deve pensare prima di tutto al suo lavoro.»
![]()
Il maestro del coro abita nel nostro palazzo, al piano di sotto. Ci siamo conosciuti una sera che si è allagato il bagnetto della lavatrice e lui è salito a suonare. Non mi ero accorta di niente, Doug era fuori, mi ero spaventata a sentire il campanello a quell’ora, e poi cos’aveva quello da sorridere.
Mi aveva mostrato sul telefono le fotografie del suo muro fradicio, persino il letto si era bagnato, poi mi aveva aiutato a trovare il rubinetto per chiudere l’acqua e si era scusato dell’orario, del fastidio, di tutto.
Mi ero agitata, sembrava un disastro irrimediabile e lui era troppo gentile.
«Col tempo si asciuga, poi si ridipinge, tutto si sistema, stia tranquilla» mi aveva consolato.
Dopo l’allagamento gli avevo dato la delega per le riunioni di condominio a cui io e Doug non andavamo mai, e quando lo incrociavo in ascensore o sulle scale della cantina facevamo due chiacchiere.
Mi aveva raccontato di essere vicepreside in una scuola elementare. «Ma la mia passione è il canto» aveva detto, spiegando che da dieci anni dirigeva un coro a San Vittore.
Non gli ho detto che io per dieci anni ho fatto la modella.
Da ragazza disegnavo. Ho fatto il liceo artistico, poi sono capitate le foto.
Quando ho smesso con le fotografie per anni ho fatto la stylist per le riviste, poi le cose sono andate male. Sono quasi due anni che non lavoro più.
«“L’artista non è libero nella vita ma soltanto nell’arte” diceva Vasilij, trova la tua forma d’arte e smettila di lagnarti, dannazione!» si arrabbia la Voce.
«Ma io non sono un’artista!» rispondo.
«Tu sei tu, accidenti. Basta e avanza» grida.
![]()
Ho rivisto il maestro al supermercato dei pachistani, davanti al banco dei latticini, un pomeriggio di febbraio.
Di punto in bianco mi ha chiesto di entrare nel coro delle volontarie, a San Vittore, com...