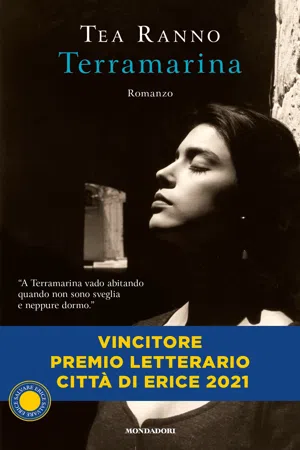Visto da lassù, dal colmo della collina, il paese pareva un grumo di case adagiato sulla mano di Dio, così le venne da pensare. Altri lo dicevano presepe, e potevano anche aver ragione, ma presepe solo col buio, si disse, alla luce dei lampioni che dava ai muri un colore di biscotto e nascondeva le brutture della modernità.
Era la vigilia di Natale e si gelava. Pure piovigginava adesso e lei era uscita senza ombrello, senza cappotto; all’ultimo momento aveva preso uno scialle e in quello s’era avvolta, come le femmine antiche che spariscono tra il nero delle frange. Non voleva essere riconosciuta, coinvolta in cene e riunioni di famiglia, feste, abbracci, musica di ciaramelle, i regali nelle carte lucenti, gli auguri auguri auguri che rinnovano il rito dell’amurusanza, vera o solo ostentata perché è Natale e così dev’essere. E neppure l’odore d’incenso della messa di mezzanotte. Niente voleva!
Perciò aveva camminato fin lassù inerpicandosi per i vicoli ripidissimi, scansando di proposito le strade dei negozi, la folla degli ultimi acquisti per ritocchi alle tavole che avrebbero dovuto sfavillare. Né luci né sfarzo per lei, solo quel panorama bello da levare il fiato, quello sgranellarsi di case lungo i fianchi della collina e il mare nero in fondo, la costa sparsa di luci come uno scampolo di metropoli che metropoli non era, ma ferrame d’industria che il buio – trafitto dalle capocchie blu, rubino, smeraldo e oro – trasfigurava in terra di fiaba.
Agata si strinse nello scialle. La tramontana le sbatteva in faccia aghi di pioggia. Sarebbe dovuta rincasare, e invece restava lì, a fissare la lontana provinciale, la lunga fila di macchine in risalita dei tornanti: tutti a casa rientravano, pure dal Continente, pure dai pizzi più lontani di Sicilia, ché Natale è festa che non ammette solitudini.
“Guarda che ti vengo a prendere con la forza” le aveva detto Toni Scianna, l’amico suo più caro, un tempo infatuato di lei e adesso innamorato perso di Violante, la moglie ragazza che l’aveva reso da poco, per la seconda volta, padre. “Siamo tutti a casa mia. Non può mancare giusto lei, sindaca.”
Sindaca... La chiamava così quando voleva dare tono di ufficialità a un discorso o ripristinare le distanze fasulle con cui in Municipio lavoravano gomito a gomito, lei appunto in qualità di sindaca e lui in quella di assessore ai Lavori pubblici, nonché suo vice, uomo di cui si fidava talmente tanto da potergli mettere nelle mani, in caso di necessità, la sua stessa vita.
“Non risponde?” aveva incalzato lui.
“Faremo festa domani, professore” aveva detto stancamente.
“Pure stasera, sindaca!” Un ordine, più che altro.
Aveva scosso la testa: “Voglio stare sola, Toni”.
“Ma perché?” L’aveva chiesto con rabbia.
Non gli aveva risposto. Che avrebbe dovuto dirgli? Mi manca Andrea? Non posso vivere senza di lui?
Scema, sarebbe parsa. Patetica.
Guardò verso la casa dell’amico suo. Sfavillava come un albero di Natale. Una ridondanza che il vecchio Scianna avrebbe aborrito e che il nuovo, invece, guardava con gli stessi occhi estatici del figlio Francesco, un frugolo di appena due anni che già speditamente camminava e parlava.
Da quando aveva sposato Violante, Toni era diventato un altro: dell’insegnante di latino e greco un poco saccente, femminaro, di nascosto poeta, che un tempo aveva interloquito con Dante – e ultimamente con Dio – era rimasto molto poco. Adesso pareva in perenne stato d’ebbrezza, e quando lei glielo faceva notare, lui allargava le braccia e: “Vero è” ammetteva, “Violante mi scimunisce. Ha una tale carica di vita che accanto a lei ho riguadagnato i miei vent’anni e i quindici, pure i dieci, e certe volte mi pare di essere tornato piccolo, quando mi faceva contento già solo un pesciolino di zucchero”.
Scosse la testa infastidita. “Sei gelosa della sua felicità?” si chiese. E di più si sentì stupida. E triste. E sconsolata. E sola in quello scuro e in quel silenzio, in quella bellezza piovigginosa che rigava le luci lontane e aggiungeva tristezza.
Ebbe voglia di piangere, ma le lacrime non vennero.
L’orologio della Torre cominciò a rintoccare. Otto colpi che l’aria cristallina rese più nitidi.
“Alle otto a casa mia” aveva detto Toni.
E infatti, puntualissime, ecco due figure bussare alla sua porta. Persino da lassù la riconobbe Lisabetta, per via dei capelli crespi che il vento agitava quasi fossero i serpenti vivi di una criniera di Gorgone. Per un istante la guardò con gli occhi degli altri quella femmina capace, coi suoi intrugli d’erbe, di risuscitare addirittura i morti, così dicevano in paese; ma invece di averne timore, o riverenziale rispetto, di più l’ammirò. Al suo braccio c’era Peppino Grimaldi, il medico di cui pure la più velenosa delle lingue non avrebbe potuto che tessere lodi.
All’inizio, quando Grimaldi e Lisabetta si erano fidanzati, la gente s’era confusa: ma come, il dottore che dà confidenza alla majara? L’uomo di scienza che avalla gli intrugli stregoneschi?
E invece si erano dovuti ricredere, perché il dottore e la majara si erano rivelati una coppia formidabile pure nell’esercizio della professione, e là dove non riusciva lei coi suoi rimedi, ecco che subentrava lui coi suoi farmaci, e mai malati trovarono più in fretta soluzione definitiva ai propri acciacchi.
Anche Lisabetta aveva insistito perché quella sera lei fosse della combriccola: “Soru, non ti posso sapere sola”.
Soru, sorella, così si chiamavano tra loro perché davvero l’una era diventata per l’altra – entrambe figlie uniche – la sorella che non aveva avuto.
“Ho bisogno di fare quattro conti” aveva detto.
“Mizzica, giusto la vigilia di Natale? Non se ne parla.”
“Per favore, Lisa, capiscimi...” Nel dirlo la voce le si era incrinata e l’altra s’era dovuta arrendere.
«Andrea, dove sei?» mormorò spingendo gli occhi verso il mare lontano.
Le rispose uno straccio di nenia suonata da musicanti di passaggio che di più accrebbe la desolazione.
Spostò lo sguardo sulla caserma. Chiusa e scura, senza neppure un vezzo a ricordare che era Natale e bisognava essere più buoni. Anzi, felici. Non è così, signor maresciallo?
Un groppo di pianto le chiuse la gola. Si levò dalla testa lo scialle perché il vento le portasse via i pensieri. Di tutto voleva scordarsi: d’essere la sindaca di quel paese che stava operando un cambiamento anche “a colpi di poesia” – dunque insufflando cultura soprattutto nei giovani –, e la Tabbacchera che ogni mattina, da quattr’anni, s’alzava dal letto e non smetteva di pensare al marito morto, quel Costanzo Di Dio a cui sulla tomba aveva giurato “amore a mai finire”, e mai era parola irrevocabile.
Invece s’era innamorata del maresciallo, piano piano: un giorno un cenno di saluto, un giorno la gentilezza d’un sorriso, un giorno la richiesta d’un consiglio in una questione che lui, nuovo e per di più continentale, non riusciva a sbrogliare, poi il regalo di un libro: “Lo deve leggere, signora. Le piacerà”, ed erano diventati Andrea e Agata: sparito il maresciallo, sparita la Tabbacchera, se non nei casi in cui volevano scherzare, o quando la sindaca si rivolgeva in via ufficiale al maresciallo e insieme agivano per combattere il malaffare che infestava quella terra come una gramigna. Lui accanto a lei, discreto, disponibile, garbato, mai una parola di troppo, mai un gesto fuori luogo, e però la vampa del desiderio c’era e lei la sentiva, la percepiva in ogni gesto trattenuto, in ogni frase bruscamente spezzata. La sapeva vedova, Andrea Locatelli, e la rispettava.
Nel tempo, avevano preso l’abitudine di mandarsi brevi SMS, perlopiù versi di poesie a loro care. Aveva iniziato lui: “Non domandarci la formula che mondi possa aprirti...”. Lei subito, in risposta: “... sì qualche storta sillaba e secca come un ramo...”.
Un gioco bellissimo che li aveva avvicinati ancora di più, e che aveva dato l’avvio a uno scambio di e-mail in cui ognuno aveva preso a raccontarsi all’altro.
Così lei aveva saputo dell’infanzia di lui a Torino, delle idee di giustizia che aveva succhiato insieme al latte di sua madre, un magistrato di ferro che gli aveva messo in filastrocca i Principi Fondamentali della Costituzione e gli aveva insegnato che la legge sta al di sopra di tutto.
“Avrei potuto non diventare sbirro?” le aveva scritto un giorno.
Lei gli aveva detto di un padre amatissimo che s’era fatto madre quando la madre era venuta a mancare.
Ed erano andati avanti così.
Finché un giorno erano finiti uno addosso all’altra e il bacio lungo che s’erano dati l’aveva stordita.
“Ti amo, Agata” aveva mormorato lui.
Pure lei l’amava, che non lo sapeva? Ma era stata così scema da irrigidirsi, da prendere le distanze per ribadire dentro di sé la fedeltà al marito morto: se il cuore sbattoliava come una lodoletta in gabbia, pazienza, il corpo doveva ubbidirle.
E il corpo le aveva ubbidito: legnoso e sempre all’erta, aveva creato tra loro un imbarazzo tale da contaminare il tempo a venire, per cui avevano preso a trattarsi con la trepida gentilezza di chi non vuole infrangere un cristallo e usa ogni riguardo per riuscirci. Una cautela che aveva raggelato l’intesa, la confidenza.
E allora lui se n’era andato. Così. Da un giorno all’altro. Aveva chiesto di tornare nella sua Torino e l’avevano accontentato.
“Stop. Fine di una storia” s’era detta Agata pensando che fosse la soluzione migliore: lei da sola, fedele a Costanzo, lui a farsi una vita tra la gente sua.
E invece era subentrato lo strazio, un dolore fatto di mancanza e desiderio, di parole non più condivise, dell’attesa che lui venisse e le parlasse, di mani che nella stretta del buongiorno o della buonasera si dicessero la gioia d’incontrarsi, il caffè di mezza mattina da prendere insieme in Municipio con un pretesto, gli occhi negli occhi a confidarsi quello che le parole non avrebbero potuto.
Ricordi che acuirono il dolore: un canazzo infisse i denti nella polpa tenera di quel suo cuore che aveva smesso corazze e difese e ora palpitava come un uccello vivo in bocca appunto al cane.
“Basta!” si disse.
Voltò le spalle al panorama e imboccò la discesa.
E se la salita era stata faticosa, “a scendere tutti i santi aiutano” diceva suo padre.
Invece non fu così. La pioggia s’era trasformata in un nevischio che rendeva scivolosa la strada, e dovette procedere con cautela, rasentando i muri, appoggiandosi a ogni gradino come fanno i vecchi.
Vista così, titubante nel passo e avvolta nello scialle, nessuno avrebbe immaginato che quella vecchia fosse la Tabbacchera magnifica su cui non c’era occhio maschio che non si posasse con desiderio. Alta, slanciata, gran petto palombino, fianchi tondi, occhi del più acceso azzurro, incarnato di pupa e capelli neri a onde lunghe sulle spalle, era davvero bellissima. Subito dopo la morte di Costanzo i pretendenti erano piombati sopra di lei come falchi su un agnello, ma là dove avevano pensato di trovare morbidezza, s’erano imbattuti in una sostanza di carrarmato: inaccessibile la Tabbacchera, blindata in quella sua vedovanza che non ammetteva intrusioni.
I maligni dicevano di lei che giocasse di ritocco: tanta perfezione a trentasett’anni suonati?
“E come ve la spiegate una cosa così?” andava chiedendo la nuova giornalaia, una siracusana petulante come una cocorita.
“Saranno le erbe della majara” rispondeva il meccanico, pure lui forestiero e dunque privo di devozione verso quella donna che fin troppi amavano.
“E vi pare che la majara non se li metterebbe pure sulla faccia sua gli inguacchi suoi?” replicava. “Lei sì che lo porta scritto ...