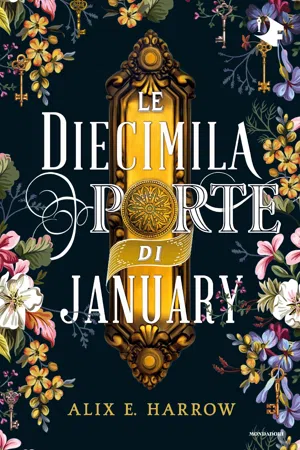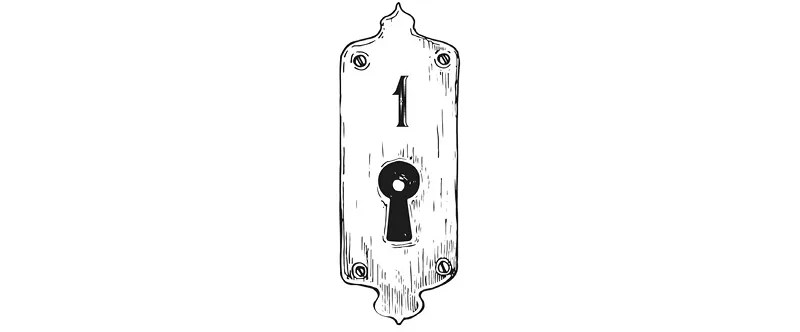Quando avevo sette anni, trovai una porta. Forse dovrei usare la maiuscola, così capirete che non sto parlando di una porta da giardino o di una porta normale che si apre invariabilmente su una cucina con le piastrelle bianche o un armadio a muro.
Quando avevo sette anni, trovai una Porta. Ecco, guardate con che orgoglio la parola si staglia sulla pagina adesso: la P è una chiave nera che conduce verso un nulla bianco. Quando osservate quella parola, immagino che un vago formicolio di familiarità vi faccia rizzare i peli sulla nuca. Non sapete assolutamente niente di me; non potete vedermi seduta a questa scrivania in legno giallo, con la brezza dolce e salata insieme che sfoglia le pagine come una lettrice in cerca del segnalibro. E non potete vedere le cicatrici che si annodano e si attorcigliano sulla mia pelle. Non conoscete nemmeno il mio nome (January Scaller; ecco, ora sapete qualcosa su di me e io mi sono rovinata la premessa da sola).
Però capite cosa intendo quando leggete la parola Porta. Forse anche voi ne avete vista una, tutta marcia, mezza socchiusa in una vecchia chiesa, oppure ben oliata e scintillante in un muro di mattoni. E magari, se siete una di quelle persone fantasiose i cui piedi corrono spontaneamente verso luoghi inaspettati, ne avete anche varcata una, per poi ritrovarvi appunto in un luogo inaspettato.
O forse non avete mai nemmeno scorto una Porta del genere in tutta la vita. Non ce ne sono più così tante come una volta.
Ma sapete comunque come sono le Porte, no? Perché ci sono diecimila storie su diecimila Porte, e noi le conosciamo bene quanto i nostri nomi. Porte che conducono alla Terra delle fate, al Valhalla, ad Atlantide e a Lemuria, al Paradiso e all’Inferno, in tutte le direzioni verso cui una bussola non potrebbe mai guidarvi, verso l’altrove. Mio padre, che è un vero studioso e non una semplice ragazzina con una penna e una serie di cose da dire, lo spiega molto meglio: “Se trattiamo le storie come siti archeologici e rimuoviamo con grande cura la polvere dai vari strati che le rivestono, scopriamo che a un certo livello c’è sempre una porta. Un punto che separa il qui e il lì, noi e loro, l’ordinario e il magico. Ed è proprio nei momenti in cui le porte si aprono e in cui le cose fluiscono tra i mondi che nascono le storie”.
Mio padre non usava mai la maiuscola per le porte. Ma forse gli studiosi non utilizzano le maiuscole soltanto in base alle forme che queste creano sulla carta.
Era l’estate del 1901, anche se all’epoca quella sequenza di quattro cifre sulla pagina non significava molto per me. Adesso lo vedo come un anno sbruffone e pieno di sé, tutto scintillante per le promesse placcate in oro del secolo appena iniziato. Un anno che si era liberato della confusione e del trambusto dell’Ottocento, di tutte quelle guerre e rivoluzioni e incertezze, dei crescenti malesseri dell’impero britannico; adesso non c’erano altro che speranza e prosperità ovunque si guardasse. Il signor J.P. Morgan era da poco divenuto l’uomo più ricco del mondo e di ogni epoca; la regina Vittoria era finalmente spirata e aveva lasciato il vasto impero a quel suo figlio dall’aspetto regale; in Cina i rivoltosi Boxer erano stati domati e Cuba era stata ben sistemata sotto l’ala civilizzata dell’America. La ragione e la razionalità regnavano supreme, non c’era spazio per la magia e il mistero.
E non c’era spazio, si scoprì, neanche per le ragazzine che vagavano fino ai margini delle mappe e dicevano la verità sulle cose folli e impossibili che trovavano laggiù.
La trovai sul malandato confine occidentale del Kentucky, proprio nel punto in cui lo stato infila l’alluce nel Mississippi. Non è il genere di posto in cui ci si aspetterebbe di trovare qualcosa di misterioso, o anche solo lontanamente interessante: è un luogo piatto e dall’aria trasandata, popolato da gente ugualmente piatta e dall’aria ugualmente trasandata. Il sole vi splende due volte più caldo e tre volte più luminoso che nel resto del paese anche negli ultimissimi giorni di agosto e tutto è umido e appiccicoso come i residui di sapone sulla pelle quando si usa la vasca dopo tutti gli altri.
Ma le Porte, come i sospettati di omicidio nei gialli da quattro soldi, si trovano spesso dove meno ce lo si aspetta.
Ero nel Kentucky soltanto perché il signor Locke mi aveva portata con sé durante uno dei suoi viaggi d’affari. Aveva detto che era “un vero regalo” e “un’opportunità per vedere come si fanno le cose”, ma in realtà era perché la mia bambinaia barcollava sull’orlo dell’isteria e solo nel mese precedente aveva minacciato di andarsene almeno quattro volte. All’epoca ero una bambina difficile.
O forse era perché il signor Locke stava cercando di tirarmi su di morale. La settimana prima era arrivata una cartolina di mio padre. C’era la foto di una ragazza dalla pelle scura con un cappello a punta dorato e un’espressione seccata, con le parole AUTENTICO COSTUME BIRMANO stampigliate a fianco. Sul retro c’erano tre righe in elegante inchiostro marrone: “Prolungo il soggiorno, torno in ottobre. Ti penso. JS”. Il signor Locke le aveva lette da sopra la mia spalla e mi aveva dato un goffo colpetto sul braccio, come per dirmi di andare avanti a testa alta.
Una settimana dopo ero compressa in quella bara di velluto e pannelli in legno che era la cuccetta di un vagone letto Pullman, a leggere The Rover Boys in the Jungle mentre il signor Locke studiava la sezione Affari del “Times” e il signor Stirling fissava il vuoto con l’imperturbabilità professionale di un valletto.
Meglio che introduca il signor Locke come si conviene: non sopporterebbe di fare il suo ingresso in una storia in un modo così casuale, di traverso. Permettetemi allora di presentarvi il signor William Cornelius Locke, fattosi da sé, quasi milionario ma non ancora, presidente della W.C. Locke & Co., proprietario di nientemeno che tre residenze signorili lungo la costa orientale, paladino delle virtù dell’Ordine e del Decoro (parole per cui certamente preferirebbe usare le maiuscole: vedete quella D, come un arco nero teso sulla pagina in difesa delle buone maniere?) e presidente della Società Archeologica del New England, una specie di club per uomini ricchi e potenti che si dedicavano al collezionismo amatoriale. Dico “amatoriale” solo perché per gli uomini abbienti era più elegante riferirsi ai propri hobby senza dar loro importanza, così, con un piccolo gesto delle dita, come se ammettere di occuparsi di qualcosa che non fosse il far soldi potesse infangare la loro reputazione.
In realtà a volte sospettavo che tutti gli affari di Locke fossero condotti specificamente per alimentare il suo hobby del collezionismo. La sua casa nel Vermont – quella in cui abitavamo sul serio, al contrario delle altre due strutture immacolate che servivano soprattutto a rimarcare la sua importanza agli occhi del mondo – pareva un enorme museo Smithsonian privato, così stracolmo da sembrare costruito con gli artefatti da collezione, invece che in malta e mattoni. L’organizzazione non era granché: le statuette in pietra calcarea di donne dai fianchi larghi facevano compagnia ai paraventi indonesiani con incisioni delicate come pizzo, mentre le punte di freccia in ossidiana condividevano la vetrinetta con il braccio imbalsamato di un guerriero Edo (odiavo quel braccio, ma non riuscivo a smettere di guardarlo e di chiedermi che aspetto dovesse avere avuto quand’era vivo e pieno di muscoli, e come si sarebbe sentito il suo proprietario se avesse saputo che in America una ragazzina avrebbe osservato la sua carne incartapecorita senza nemmeno conoscere il suo nome).
Mio padre era uno degli agenti operativi del signor Locke, assunto quando io non ero che un fagottino grande come una melanzana avvolto in un vecchio cappotto da viaggio. «Tua madre era appena morta, sai, una situazione molto triste» amava recitarmi il signor Locke, «e tuo padre, un tizio che sembrava uno spaventapasseri, con la carnagione di uno strano colore e, Dio lo aiuti, dei tatuaggi lungo tutte le braccia, era lì, nel bel mezzo del nulla, con una neonata in braccio. Mi sono detto: Cornelius, ecco un uomo che ha bisogno di un po’ di beneficenza!»
Mio padre era stato assunto prima ancora che calasse il sole. Adesso vagabondava per il mondo a raccogliere oggetti “di un valore singolare e unico” e a spedirli al signor Locke perché lui potesse metterli nelle vetrine con le targhette in bronzo e gridarmi contro quando li toccavo, ci giocavo o rubavo le monete azteche per ricreare le scene de L’isola del tesoro. E io me ne stavo nella mia cameretta grigia a Villa Locke, tormentavo le bambinaie che il signor Locke assumeva per educarmi e aspettavo che mio padre tornasse a casa.
A sette anni avevo passato molto più tempo con il signor Locke che con il mio vero padre, e gli volevo bene, per quanto fosse possibile volerne a qualcuno che era così a suo agio in un completo a tre pezzi.
Com’era sua abitudine, il signor Locke aveva prenotato delle stanze nel posto più elegante possibile; nel Kentucky significava un immenso albergo in legno di pino sulla riva del Mississippi, chiaramente costruito da qualcuno che voleva aprire un grand hotel ma non ne aveva mai visto uno dal vivo. C’erano carta da parati a strisce come quelle delle caramelle e lampadari elettrici, ma dalle assi del pavimento saliva un odore acido di pesce gatto.
Il signor Locke rivolse un cenno al direttore, come per scacciare una mosca; gli disse: «Tenga d’occhio la ragazzina, da bravo» e fece il suo ingresso trionfale nella hall con il signor Stirling che lo seguiva passo passo come un cagnolone in forma d’uomo. Locke salutò un tizio con il papillon che aspettava seduto su uno dei divani a fiori. «Governatore Dockery, che piacere! Ho letto la sua ultima missiva con la massima attenzione, glielo assicuro… e come procede la sua collezione craniologica?»
Ah. Ecco perché eravamo venuti lì: il signor Locke doveva vedere uno dei suoi amici della Società Archeologica per una serata di bevute, sigari e vanterie. Facevano un raduno annuale della Società a Villa Locke ogni estate, una festa elegante seguita da un noioso incontro riservato ai membri a cui né a me né a mio padre era consentito partecipare; tuttavia, alcuni dei veri appassionati non riuscivano ad aspettare un anno intero e si cercavano a vicenda in qualunque posto riuscissero a darsi appuntamento.
Il direttore mi sorrise nel modo forzato e colmo di panico degli adulti senza figli e io ricambiai con un sorrisone a trentadue denti. «Vado fuori» gli dissi in tono sicuro. Lui forzò ulteriormente il sorriso, battendo le palpebre con aria incerta. La gente si mostra sempre incerta davanti a me: la mia pelle è di un rosso ramato, come se fosse completamente ricoperta di segatura di cedro, ma i miei occhi sono tondi e chiari e i miei vestiti sono costosi. Ero un animaletto viziato o una ragazza della servitù? Il povero direttore doveva offrirmi un tè o spedirmi in cucina con le donne di servizio? Ero quella che il signor Locke chiamava “una sorta di cosa nel mezzo”.
Feci cadere un grosso vaso di fiori, sospirai un «oh cielo» assolutamente non sincero e mi dileguai di soppiatto mentre il direttore imprecava e tamponava il disastro con il suo cappotto. Scappai fuori dalla porta (vedete che questa parola si infila anche nelle storie più banali? A volte mi sembra che ci siano porte nascoste nelle pieghe di ogni frase, con i punti come pomelli e i verbi come cardini).
Le strade non erano niente più che striature cotte dal sole che si incrociavano più volte prima di finire nel fiume fangoso, ma gli abitanti di Ninley, Kentucky, sembravano passeggiarvi come se si trattasse di vere strade di città. Mi fissavano e borbottavano quando li superavo.
Un portuale sfaccendato mi indicò e diede di gomito al suo amico. «Scommetto che è una piccola Chickasaw.» Il collega scosse la testa, menzionò la propria grande esperienza con le ragazze indiane e ipotizzò: «Forse è un’indiana dell’Ovest. O una mezzosangue».
Continuai a camminare. La gente faceva sempre supposizioni del genere, categorizzandomi in un modo o nell’altro, ma il signor Locke mi aveva assicurato che si sbagliavano tutti. Mi definiva “un esemplare assolutamente unico”. Una volta, dopo il commento di una delle donne di servizio, gli avevo chiesto se ero di colore, e lui aveva sbuffato. «Di un colore insolito, forse, ma certo non di colore.» Non sapevo che cosa rendesse una persona di colore o no, ma il modo in cui lo diceva mi rendeva felice di non esserlo.
Le supposizioni si facevano ancora peggiori quando c’era mio padre con me. Aveva la pelle più scura della mia, di un lucente rosso-nero, e gli occhi così bruni che anche la parte bianca aveva filamenti marroni. Se ci si aggiungevano i tatuaggi – spirali d’inchiostro che gli salivano da entrambi i polsi – il completo logoro, gli occhiali e l’accento misto… be’. La gente ci fissava.
Eppure avrei comunque voluto che fosse lì con me.
Ero così impegnata a camminare senza voltarmi a guardare tutte quelle facce bianche che andai a sbattere contro qualcuno. «Mi scusi, signora, io…» Una donna anziana, gobba e rugosa come una noce chiara, mi fulminò con lo sguardo. Era l’occhiataccia esperta di una nonna, destinata specificamente ai bambini che si muovevano troppo in fretta e la urtavano. «Mi scusi» ripetei.
Lei non rispose, ma nel suo sguardo qualcosa cambiò, come un abisso che si palesava. La bocca le si aprì, gli occhi velati si spalancarono come persiane a scatto. «Chi… ma chi diavolo sei?» mi sibilò contro. Immagino che alla gente non piacciano le cose “nel mezzo”.
Sarei dovuta tornare di corsa all’albergo che puzzava di pesce gatto, a rifugiarmi sotto l’ala sicura e danarosa del signor Locke, dove nessuna di quelle maledette persone poteva raggiungermi; sarebbe stata la cosa più appropriata da fare. Però, come lamentava spessissimo il signor Locke, a volte sapevo essere inappropriata, testarda e temeraria (una parola che ipotizzavo fosse poco lusinghiera, visto che si accompagnava alle altre).
Perciò scappai via.
Corsi finché i due stecchini che avevo per gambe non presero a tremare e il petto non cominciò a gonfiarmisi contro le eleganti cuciture del vestito. Corsi finché la strada non divenne un viottolo pieno di curve e i palazzi alle mie spalle non furono inghiottiti dal glicine e dal caprifoglio. Corsi e cercai di non pensare agli occhi della vecchia signora fissi sul mio viso, o a quanto sarei stata nei guai per essere sparita.
I miei piedi smisero di frullare soltanto quando si resero conto che la terra sotto di loro si era trasformata in zolle d’erba. Mi trovavo in un campo abbandonato e mai falciato, sotto un cielo così azzurro che mi ricordava le mattonelle di ceramica che mio ...