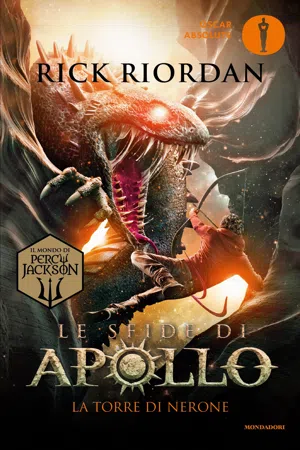Quando si passa dalle parti di Washington, è normale imbattersi in qualche serpente in vesti umane. Eppure mi preoccupai lo stesso quando un boa constrictor bicefalo salì sul nostro treno alla Union Station.
La creatura si era infilata in un elegante completo di seta blu, inanellando il corpo nelle maniche e nelle gambe dei pantaloni per creare un’approssimazione di arti umani. Le due teste sporgevano dal colletto della camicia come telescopi gemelli. Muovendosi con una notevole grazia per essere una specie di palloncino a forma di animale in versione extralarge, andò a sedersi al capo opposto della carrozza, rivolto verso di noi.
Gli altri passeggeri lo ignorarono. Senza dubbio la Foschia distorceva i loro sensi, e vedevano soltanto un pendolare come tanti.
Il serpente non fece mosse minacciose. Non ci degnò di un’occhiata.
Per quanto ne sapevo, era solo un comune mostro sottopagato che se ne tornava a casa. E tuttavia non potevo dare per scontato…
Bisbigliai a Meg: «Non voglio allarmarti, ma…».
«Ssst!» mi zittì. Prendeva molto sul serio le norme della carrozza silenzio. Da quando eravamo saliti, l’unico suono lo aveva emesso lei per zittirmi ogni volta che parlavo, starnutivo o mi schiarivo la gola.
«Ma c’è un mostro» insistetti.
Meg sollevò gli occhi dalla rivista omaggio della compagnia ferroviaria, inarcando un sopracciglio sopra la montatura incastonata di strass degli occhiali: “Dove?”.
Con il mento, indicai la creatura.
Mentre il treno si allontanava dalla stazione, la testa sinistra fissava distrattamente fuori dal finestrino. La destra faceva saettare la lingua biforcuta in una bottiglietta d’acqua, sorretta da quella che doveva passare per una mano, ma che in realtà era un pezzo attorcigliato del corpo.
«È un’anfisbena» bisbigliai, e per chiarezza aggiunsi: «Un serpente con una testa a ciascuna estremità».
Meg si accigliò, poi fece spallucce, cosa che interpretai come un: “Mi pare abbastanza calmo”. E tornò a leggere.
Soffocai l’impulso di ribattere. Soprattutto perché non avevo voglia di farmi zittire di nuovo.
Meg desiderava un viaggio tranquillo, e come darle torto? Nell’ultima settimana, avevamo combattuto un branco di centauri selvaggi in Kansas, affrontato un inferocito spirito della carestia a Springfield, nel Missouri (niente selfie, mi dispiace), ed eravamo sfuggiti a un paio di draghi azzurri del Kentucky, che ci avevano inseguito per diverse volte intorno all’ippodromo di Churchill Downs. Dopo tutto questo, un serpente bicefalo in giacca e cravatta forse non era motivo sufficiente per allarmarsi. Di certo, al momento non ci stava dando alcun fastidio.
Cercai di rilassarmi.
Meg teneva il viso sepolto nella rivista, tutta presa dalla lettura di un articolo sul giardinaggio urbano. Era diventata più alta negli ultimi mesi della nostra conoscenza, ma era ancora abbastanza piccola da poggiare comodamente le sneakers rosse sul sedile di fronte. Comodamente per lei, intendo, non per me e per gli altri passeggeri. Meg non si cambiava le scarpe dalla nostra ultima corsa all’ippodromo, ed erano sporche e puzzolenti come le chiappe di un cavallo.
Almeno aveva rinunciato all’inconfondibile scamiciato verde, ormai consunto, in favore di un paio di jeans a buon mercato e di una maglietta verde con la scritta UNICORNES IMPERANT, comprata al negozio di souvenir del Campo Giove. Con il caschetto lungo e un brufolone rosso sul mento, non somigliava più a una bambina dell’asilo. Dimostrava quasi la sua età: una ragazzina di prima media che stava entrando nel girone infernale noto come pubertà.
Un’osservazione, questa, che non avevo condiviso con Meg. Innanzitutto perché avevo già la mia acne di cui preoccuparmi. E poi perché, in qualità di mia padrona, Meg poteva letteralmente ordinarmi di saltare fuori dal finestrino e io sarei stato costretto a obbedirle.
Il treno avanzava lungo le periferie di Washington. Il sole del tardo pomeriggio tremolava fra gli edifici come la lampada di un vecchio proiettore cinematografico. Era un momento magnifico del giorno, quello in cui un dio del sole avrebbe dovuto concludere il proprio lavoro, parcheggiare il carro nelle vecchie stalle e rilassarsi con i piedi sul divano, un calice di nettare, una decina di ninfe adoranti e una nuova stagione di Le vere dee dell’Olimpo da guardare fino allo sfinimento.
Non per me, però. A me toccavano un sedile cigolante su un treno delle ferrovie nazionali e ore di Le scarpe puzzolenti di Meg da guardare fino allo sfinimento.
Sul lato opposto della carrozza, l’anfisbena continuava a non fare mosse minacciose… a meno di non considerare come un atto di aggressione il bere acqua da una bottiglietta non riutilizzabile.
Allora perché mi sentivo formicolare i capelli sulla nuca?
Non riuscivo a regolare il respiro. Seduto nel posto accanto al finestrino, mi pareva di essere in trappola.
Forse ero soltanto nervoso per quello che ci aspettava a New York. Dopo sei mesi trascorsi in quel miserabile corpo mortale, mi stavo avvicinando alla resa dei conti.
Io e Meg avevamo attraversato a spizzichi e bocconi tutti gli Stati Uniti, andata e ritorno. Avevamo liberato antichi Oracoli, sconfitto legioni di mostri e sofferto gli orrori inenarrabili del sistema nazionale dei trasporti. Finalmente, dopo molte tragedie, avevamo trionfato su due dei malvagi imperatori del Triumvirato – Commodo e Caligola – al Campo Giove.
Ma il peggio doveva ancora venire.
Eravamo diretti là dove tutti i nostri guai avevano avuto inizio: a Manhattan, il quartier generale di Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico, il violento patrigno di Meg, nonché il suonatore di lira che meno apprezzavo al mondo. E se anche avessimo trovato il modo di sconfiggerlo, una minaccia ancora più potente era in agguato sullo sfondo: il mio acerrimo nemico, Pitone, che aveva preso residenza presso il sacro Oracolo di Delfi, quasi fosse un alloggio a tariffa ridotta su Airbnb.
Nel giro di pochi giorni, o avrei sconfitto questi nemici e riconquistato il ruolo divino di Apollo (sempre che mio padre Zeus me lo avesse concesso), o sarei morto nel tentativo di riuscirci. In un modo o nell’altro, il mio tempo come Lester Papadopoulos stava volgendo al termine.
Forse il motivo per cui mi sentivo così agitato non era poi un mistero…
Cercai di concentrarmi sul bellissimo tramonto, tentando di non pensare ossessivamente all’assurda lista di cose da fare né al serpente bicefalo sulla fila numero sedici.
Arrivai fino a Philadelphia senza avere un crollo di nervi. Ma mentre uscivamo dalla stazione sulla Trentesima Strada, due cose mi furono chiare: 1) l’anfisbena non intendeva scendere, e questo significava che probabilmente non era un pendolare; 2) il mio radar del pericolo tintinnava a più non posso.
Mi sentivo seguito. Stavo provando lo stesso formicolio sulla pelle di quando giocavo a nascondino nel bosco con Artemide e le sue Cacciatrici, un attimo prima che saltassero fuori dai cespugli e mi crivellassero di frecce. Questo però accadeva ai tempi in cui io e mia sorella eravamo giovani divinità che potevano ancora godersi svaghi così semplici.
Azzardai un’occhiata all’anfisbena, e per poco non mi venne un colpo. La creatura mi fissava, con i quattro occhi gialli immobili e… sbaglio o stavano cominciando a luccicare maligni? Oh no, no, no! Gli occhi luccicanti non sono mai un buon segno.
«Fammi passare» dissi a Meg.
«Ssst.»
«Ma quella creatura… Devo andare a controllare. Ha gli occhi che luccicano!»
Meg la scrutò di sottecchi. «No, non luccicano maligni. Brillano normalmente. E poi, se ne sta seduta lì tutta tranquilla.»
«Se ne sta seduta lì in modo sospetto!»
Il passeggero seduto dietro di noi sibilò: «Ssst!».
Meg mi scoccò un’occhiataccia, sollevando un sopracciglio, della serie: “Te l’avevo detto”.
Con un cenno allarmato, indicai il corridoio.
Meg alzò gli occhi al cielo, si districò dalla posizione stile amaca che aveva assunto e mi fece passare. «Non metterti a combattere per primo» mi ordinò.
Fantastico. Ora mi toccava aspettare che fosse il mostro ad attaccare, prima di difendermi.
Restai per un attimo immobile nel corridoio, il tempo di far riaffluire il sangue nelle gambe intorpidite. Chiunque abbia inventato il sistema circolatorio umano ha fatto un pessimo lavoro.
L’anfisbena non si era mossa. Continuava a fissarmi. Sembrava in una specie di trance. Forse stava raccogliendo le energie per un attacco massiccio. Facevano così le anfisbene?
Frugai nella memoria alla ricerca di informazioni sulla creatura, ma non trovai molto. Lo scrittore romano Plinio il Vecchio dichiarava che indossare un cucciolo di anfisbena vivo intorno al collo assicurava una gravidanza salutare. (Informazione inutile.) Indossare la pelle del serpente invece rendeva più attraenti agli occhi di potenziali partner. (Mmm… Inutile pure questa.) Le due teste potevano sputare veleno. Ah-ah! Ecco! Il mostro stava raccogliendo le forze per un supergetto di vomito velenoso e bicefalo fino in fondo alla carrozza!
Che fare…?
Nonostante le occasionali esplosioni di energia e abilità divine, non potevo contarci ogni volta che ne avevo bisogno. La maggior parte del tempo, ero ancora un misero diciassettenne.
Potevo recuperare l’arco e la faretra dalla cappelliera. Sarebbe stato carino essere armati. Così però avrei dichiarato le mie intenzioni ostili. Meg probabilmente mi avrebbe detto che stavo esagerando. (Scusa, Meg, ma quegli occhi luccicavano maligni, non brillavano normalmente.)
Ah, perché non avevo con me un’arma più piccola, che so, un pugnale nascosto nella maglietta? Perché non ero il dio dei pugnali?
Decisi di avanzare nel corridoio come se volessi soltanto andare al bagno. Se l’anfisbena avesse attaccato, avrei urlato. E magari Meg avrebbe messo giù quell’interessantissima rivista, giusto il tempo necessario per venire a salvarmi. Almeno così avrei forzato lo scontro inevitabile. Se invece il serpente non avesse fatto una mossa, be’, allora forse era davvero innocuo. E io sarei davvero andato al bagno, perché in effetti mi scappava.
Con le gambe ancora intorpidite, inciampai, cosa che non contribuì molto all’approccio “finto rilassato”. Per un attimo pensai di fischiettare, ma poi ricordai la faccenda della carrozza silenzio.
Mancavano quattro file al mostro. Il cuore mi martellava nel petto. Quegli occhi luccicavano maligni eccome, e mi fissavano, non c’era dubbio. L’anfisbena era di un’immobilità innaturale, perfino per un rettile.
Due file. Con la mascella tremante e la faccia sudata mi era difficile apparire disinvolto.
Il completo sartoriale dell’anfisbena sembrava costoso e di buona fattura. Probabilmente, essendo un serpente gigante, non poteva indossare abiti prêt-à-porter. Certo, quella pelle lucida a squame giallo-brune non pareva il genere di capo che si sceglierebbe di indossare per apparire più attraenti su una app di incontri, a meno di non voler uscire con un boa constrictor.
Quando l’anfisbena si mosse, pensavo di essere pronto.
Mi sbagliavo. La creatura si slanciò in avanti a una velocità incredibile, prendendomi il polso al cappio con il finto braccio sinistro. Ero troppo sorpreso perfino per strillare. Se avesse voluto uccidermi, sarei morto.
Invece si limitò a stringere la presa, bloccandomi sul posto e aggrappandosi a me come se stesse annegando. Parlò in un basso sibilo stereo che mi risuonò fin nel midollo:
«La via segreta al trono troveranno
Col...