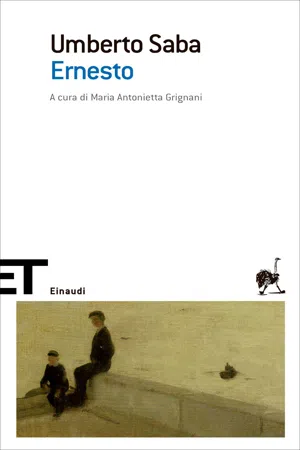![]()
Il giorno dopo Ernesto trovò una novità in ufficio. Seduto alla parte opposta della sua scrivania, voltando le spalle alla finestra, stava un altro ragazzo, piú giovane di lui. Ernesto capí subito di cosa si trattava. «È – si disse – un concorrente».
I praticanti di commercio erano, allora, molto ricercati nella Piazza di Trieste e, probabilmente, di tutto il mondo-paese. Rendessero molto o poco, non costavano, in cambio, per qualche tempo, nulla. Cosí si poteva leggere ogni giorno nel «Piccolo» o in qualche altro giornale cittadino («Il Lavoratore» escluso) nella rubrica a pagamento intitolata «Domande e offerte d’impiego» un «annuncio economico» cosí concepito:
«Praticante senza paga con bella calligrafia cerca seria Ditta in... Indispensabile conoscenza lingua tedesca. Rivolgersi per informazioni ecc.».
II garzonato durava da sei mesi a un anno. Durante questo tempo, il giovane non percepiva nulla; dopo (se non veniva prima licenziato o, avendo trovato qualcosa di meglio, non si licenziava da sé) «entrava – come si diceva – in paga»: dieci corone al mese. Il nuovo ragazzo, che Ernesto vide seduto alla sua stessa scrivania, doveva provenire da uno di quelli «annunci economici», ed il signor Wilder averlo scelto, tra un numeroso stuolo di aspiranti, forse il pomeriggio del giorno precedente, o durante una delle sue assenze dall’ufficio.
Ernesto non amava il suo principale, ma nemmeno – malgrado i dispetti e i disegni caricaturali – lo odiava. Con questi, gli era, per quanto riguardava il lavoro, fedele. Il signor Wilder gli rappresentava una figura famigliare, un pò comica e non eccessivamente interessante; ma nulla di peggio. Il lettore ricorderà forse che, la sera prima, mentre si accingeva a bere alla disgraziata fontanella, era stato sorpreso da una specie di nostalgia della sua presenza, dal desiderio, o quasi, di vederlo. Era insomma, per Ernesto, qualcosa come un oggetto, che si ha sempre sotto gli occhi, di cui la vista può, in certi momenti, perfino rassicurare; far abortire – se del caso – una crisi d’angoscia. Per conto suo, il signor Wilder non gli aveva mai dimostrata una particolare antipatia; gli aveva perfino regalato, con piú o meno opportunità, un bastone col pomo d’argento; e il mensile (che Ernesto, se non altro per le sue gambe, aveva la coscienza di guadagnarsi) era un pò piú elevato di quanto comportasse l’uso da una parte e la parsimonia del principale dall’altra. Tanto piú il ragazzo restò male quando capí che, senza alcun preavviso, questi gli aveva messo contro un concorrente. Si sentí tradito; vittima «innocente» della cosa che temeva piú di tutte (Ernesto era cane, non gatto). Tuttavia, prima di incolpare in pieno il signor Wilder, volle essere ben sicuro sulla vera natura del nuovo venuto.
«Lei chi è?» gli chiese.
L’altro ragazzo si alzò, prima di rispondergli, in piedi.
«Eccomi capoufficio» pensò Ernesto, che nutriva, in segreto, due aspirazioni, un pò contrastanti fra loro, e di cui la vita non doveva realizzare né l’una né l’altra. Sebbene la carriera dell’impiegato non gli piacesse affatto, gli fosse addirittura contraria, aspirava (il cuore umano ha di questi misteri) a diventare capoufficio in una ditta importante della città, preferibilmente (ma questo era forse un ricordo del suo album di francobolli) di una che commerciasse in generi coloniali; e celebre concertista di violino. Delle due preferiva, va da sé, la seconda: la vita di un concertista – con i viaggi, gli applausi, e il delirio della folla – gli sembrava un paradiso in terra. Ma, in fondo al cuore, ci credeva poco o nulla. Non era del tutto pazzo; e capiva che, a parte l’età relativamente tarda nella quale aveva iniziato lo studio dell’istrumento, era difficile per chi non sapeva, dopo due anni, accordare bene il proprio violino (c’era sempre qualche corda che «calava» o «cresceva» un poco) diventare un emulo del celebre concertista boemo, di cui tutti i giornali lodavano la perfetta intonazione.
«Sono il nuovo praticante» gli rispose il ragazzo in piedi. «Il signor Wilder mi ha assunto ieri, e ordinato di presentarmi questa mattina. Mi ha detto anche di sedermi su questa sedia, a questo scrittoio».
Ernesto lo guardava esterrefatto: piú lo guardava piú gli riusciva antipatico. Aveva i capelli di un biondo slavato, il volto triangolare, gli occhi grigi che sfuggivano di qua e di là, come topi presi in trappola. Inoltre, anche a distanza, mandava un odore di selvatico. Se Ernesto fosse stato piú esperto fisionomista, avrebbe capito subito che aveva da fare con una di quelle persone destinate a «vincere nella vita»; a diventare cioè, davvero e non in sogno, e per di piú con loro piena soddisfazione, capouffici a quarant’anni.
«Si sieda» gli ordinò. E, dopo di avergli detto il proprio, s’informò del suo nome. Il nome di battesimo era Stefano; il cognome denunciava un’origine slava.
«Che ragazzo!» pensò, e non per quell’origine, Ernesto; che era un buon italiano, ma non oltre: era – come si direbbe oggi – un patriotta e non un nazionalista. Per di piú era anche socialista; e, forse per l’influenza della sua «seconda madre», non nutriva, come i concittadini del suo ceto (suo cugino per esempio) odio alcuno contro gli slavi. Il ragazzo gli era antipatico per altre ragioni. Il nuovo venuto sedette pronto, e soddisfece a tutte le domande di Ernesto, senza però mettere nelle risposte alcun calore, e senza guardare mai il suo interlocutore, o solo di sfuggita. Poi, per darsi un contegno (era pur sempre, simpatico o no, un ragazzo, ed un ragazzo che si presentava il primo giorno ad un impiego) mise ordine in quella parte della scrivania destinata a lui: la penna e le matite da un lato, il calamaio in mezzo, e la carta da scrivere, aggiustata secondo grandezza, folio su folio, dall’altro. (Forse anche quell’abbondanza di oggetti di cancelleria lo impressionava). Evidentemente, era imbarazzato, non solo dei propri occhi, ma anche delle proprie mani, e non sapeva che contegno prendere di fronte ad Ernesto. Era davvero un superiore? E se fosse stato un parente del signor Wilder, o comunque un suo protetto? La sua nativa prudenza gli consigliò il contegno piú rispettoso – quello che in nessun caso poteva nuocergli – verso un ragazzo che aveva, circa, la sua età, e col quale il «tu» e il parlar subito male del padrone, sarebbero state cose piú che naturali. Anche Ernesto, dopo di averlo interrogato sui suoi studi, sulla sua conoscenza, o meno, della lingua tedesca, non sapeva cosa dirgli. Poi, avuta la conferma che era stato proprio il signor Wilder a dirgli, il giorno prima, di sedere a quel posto (cosí che egli, Ernesto, lo avrebbe avuto sempre di faccia) ebbe un’idea luminosa. Pensò di insegnargli come si fa funzionare il copialettere; era – ed Ernesto lo sapeva – il primo lavoro nel quale venivano ammaestrati i praticanti. Il signor Wilder, di solito cosí puntuale, si faceva, quella mattina, attendere.
Quando finalmente arrivò, chiamò subito nel suo studio Ernesto. «Ho assunto – gli disse – un nuovo praticante. Sie werden sehen – e continuò, per quasi tutto il colloquio, a parlargli in tedesco – Lei vedrà come presto e bene saprò tirarlo su; insegnargli, come prima cosa, ad essere ordinato». C’era nelle sue parole, un sottaciuto rimprovero per il disordinato, per lui Ernesto. Pareva che il principale avesse dimenticata del tutto la simpatia che aveva sempre dimostrata, sotto sotto, al «verfluchte Kerl». Forse anche gli erano nati dei tardi sospetti sull’uso eccessivo della naftalina, sulle macchie inspiegabili nelle lettere di cinque pagine, sui monelli che entravano, non chiamati, dalla porta di Ernesto, ed uscivano, gridando e rincorrendosi, dalla sua, sulle lampade che scoppiavano a catena, sui guanti color giallo canarino, ecc. ecc.; ed aveva trovato il modo di vendicarsi del colpevole di tanti malanni, senza licenziarlo del tutto, tanto piú che gli era utile per la corrispondenza italiana e, diffidente per natura, o per malattia, non gli erano mai nati dei dubbi sull’onestà di Ernesto. Divise il lavoro fra i due ragazzi: la divisione fu fatta, almeno sul piano teorico, in modo che ad Ernesto – una volta istruito il praticante – sarebbe rimasto ben poco da fare... Gli lasciò, in pratica, la corrispondenza italiana, la riscossione delle fatture, e la sorveglianza sui braccianti, di cui volentieri Ernesto si sarebbe, causa l’uomo, scaricato sul nuovo venuto... «Altro che capoufficio! – pensò. – È un licenziamento bello e buono. Solo – Dio sa perché – il signor Wilder vuole che sia io stesso a licenziarmi».
Ernesto era – il lettore se ne sarà accorto fin troppo – uno stupidino. Ma aveva anche delle buone qualità. Gli riusciva difficile, per esempio, mentire, e – cosa ancora piú dannosa nella vita pratica – non poteva, già alla sua età, accettare un valore (lo stipendio, in questo caso, del signor Wilder) senza avere il senso di rendere un controvalore. Si sarebbe, semplicemente, annoiato e trovato a disagio. Cosí il suo movimento istintivo fu quello di licenziarsi su due piedi, e lasciare al signor Wilder la cura d’istruire il nuovo praticante. Ma poi pensò a sua madre, ai suoi pianti, alle scene che avrebbe fatte per quell’autolicenziamento. Pensò anche che, forse, si era ingannato sulle vere intenzioni del signor Wilder. Se questi – pensò – avesse trovato il modo d’ingrandire la ditta, e il nuovo impiegato fosse necessario al lavoro aumentato? La sua assunzione non avrebbe avuto, in quest’eventualità, niente di punitivo per lui; il lavoro che il principale gli toglieva con una mano, avrebbe potuto darglielo con l’altra: forse anche dargliene troppo. Il commercio presentava, in quelli ultimi anni dell’Ottocento, un rischio maggiore che non ne rappresenti oggi (nel 1953); e i casi di fallimento, seguiti spesso da un colpo di revolver che il fallito (doloso o no) si tirava alle tempie o in bocca (raramente al cuore), erano, per cosí dire, all’ordine del giorno. Il signor Wilder era, negli affari (come in tutto il resto) molto cauto; inoltre (ma questo Ernesto non poteva saperlo) ossessionato dall’idea del fallimento; s’era perfino comperata, come misura precauzionale, una rivoltella, per il caso disgraziato che i suoi presentimenti dovessero avverarsi. Non si avverarono; e il signor Wilder – che non era, quale lo vedeva il sedicenne Ernesto, un vecchio – doveva ancora prender parte, in qualità di ufficiale della riserva (non combattente) alla prima guerra mondiale, lasciare Trieste dopo l’occupazione italiana (interpretata come un’offesa personale), assistere, nelle condizioni che si possono immaginare, alla seconda, e finire, già decrepito, in un’infornata di ebrei ungheresi, sollecitata prima, messa in atto poi dalla sua tanto amata Cermania, che vedeva in lui, allora piú che ottantenne, un pericoloso nemico del III Reich millenario... Questo era il destino della persona che stava adesso di fronte ad Ernesto, spartendo fra lui ed il nuovo praticante alcuni pacifici lavori; e non solo il suo... Non parlò né di licenziamenti, né di diminuzioni di stipendi; chiuse anzi il suo discorsetto (che ad Ernesto parve ugualmente punitivo) in lingua italiana, e con qualche parola quasi affettuosa. Ebbe anche, per un momento, la tentazione di confidare al ragazzo alcuni progetti d’ingrandimento, quali effettivamente meditava; ma, all’ultimo istante, gli parve piú prudente non tenerne ancora parola a nessuno, nemmeno al «fottuto monello», al «verfluchte Kerl».
Poco tempo dopo, Ernesto, di ritorno dal Portofranco, dove aveva sbrigate alcune pratiche doganali per conto del signor Wilder, sedeva sui sacchi di farina, sopra un carro, accanto all’uomo. Aveva quasi dimenticato il nuovo praticante, che, del resto, gli riusciva facile dominare. Era riuscito perfino a farsene una specie di servitoretto; quando gli avanzavano un pochi di soldi e la tentazione era troppo forte, lo mandava, di mezza mattina, o ad ore piú inverosimili, a comperare da un fornaio vicino, cliente del signor Wilder, che confezionava anche dolci, compensando col volume la qualità scadente del prodotto, quattro paste: le stesse che, un tempo, gli regalava l’uomo. Poi (sia detto a sua lode) le spartiva in parti uguali con Stefano, che si schermiva con complimenti, con finti rifiuti, che irritavano ogni volta Ernesto. Aveva lasciato, quando gli parlava, la lingua per il dialetto; e gli dava del «tu», accettando, con perfetta naturalezza, che il praticante, il quale aveva forse un anno meno di lui, lo trattasse col «lei», come un inferiore un superiore. Avrebbe trovato ugualmente naturale il contrario; ma, malgrado la docilità nei suoi confronti, non gli era simpatico, e cosí non aveva mai insistito in proposito.
L’uomo sedeva imbronciato, e ostentava di non vedere nemmeno il ragazzo. Ernesto invece si sentiva, quella mattina, particolarmente lieto e ben disposto. Guardava con ammirazione la gente che camminava indaffarata, affollando le vie di Trieste. Tutti parevano inseguire qualcosa di molto importante; le donne recavano al braccio una cesta o la borsa della spesa. In fondo alle vie per le quali passava il carro, si vedeva ora un lembo di mare, ora una collina, che sembrava, nella splendida luce estiva, piú vicina di quanto realmente fosse. «Trieste – si disse, per la prima volta, Ernesto, – è davvero una bella città, ed io ho fatto bene a nascervi». (Quasi avesse potuto scegliere...) Ma poi gli venne a mente che non aveva ancora veduta nessun’altra città; e ricordò l’invidia che provava al Ginnasio per un suo compagno di banco, piú fortunato di lui, che, durante le vacanze, faceva coi genitori dei lunghi viaggi, perfino dei viaggi all’estero; e, al ritorno in classe, raccontava meraviglie. Gli mancava insomma un termine di paragone; e non poteva quindi sapere se e quanto il suo giudizio favorevole su Trieste fosse esatto. Ogni giudizio infatti premette un confronto; ed era l’impossibilità nella quale si trovava Ernesto di fare questo confronto che lo rendeva poco convinto di essere – come invece era – nel vero.
L’uomo sedeva imbronciato perché, dal giorno nel quale Ernesto aveva fatto a pezzi la «siba», scelta con amorosa cura per dargli – cosí egli pretendeva – «un piccolo castigo» (in realtà per sfogare sul povero ragazzo quel tanto di sadismo che pare si accompagni sempre a questo genere di amori), Ernesto non gli aveva piú parlato, tranne che per ragioni di lavoro. Quando si recava al posteggio per chiamare un bracciante, sceglieva sempre lui: ma questo era tutto. «Tutti i muli – pensava tra sé l’uomo – i sè compagni; dopo una o due volte i se stufa; se no ti li lassi ti, i te lassa lori per primi». Ma la sua ferita era piú profonda. Sentiva troppo bene che Ernesto rappresentava nella sua squallida esistenza un’avventura unica; e che, una volta perduto, non lo avrebbe potuto piú rimpiazzare, nemmeno con tutti i «muli» del mondo. Qualche volta il suo rancore amoroso si acuiva ad un rancore sociale. «Ernesto – pensava – se comporta mal con mi perché lui el sè un sior, e mi un povareto». Ma, su questo punto, si sbagliava. Il ragazzo, oltre che considerarsi egli stesso un povero, era poco sensibile alle disparità sociali; e forse non avrebbe fatto con un «signore» quello che invece aveva fatto con un bracciante avventizio.
«Trieste è bella – si ripeteva intanto Ernesto – e Diem (il suo compagno di banco, lo stesso che gli aveva messo, in terza Ginnasio, la voglia di indossare, dietro il suo esempio, un gilè) ha un bel vantare altre città: nessuna può essere bella come questa»... Ma, mentre vantava a sé medesimo la propria, si accorse di stare – come lo rimproverava spesso sua madre – un pò curvo della persona. «Sono cresciuto troppo presto» si confessò con rammarico. (Essere un pò alto di statura era considerato da lui un difetto; una delle ragioni della sua vantata «bruttezza»). E si rimise diritto; lamentando solo di non essere una mezza testa piú basso. Poi gli occhi color nocciola gli caddero sull’uomo, che portava il solito fazzoletto rosso in capo. A vederlo cosí imbronciato (a Ernesto era facile intuire le ragioni di quella tristezza; sebbene non ne sospettasse la componente sociale) sentí prima una certa soddisfazione: come un intimo compiacimento per il proprio «potere» sopra una persona che aveva tanti anni piú di lui e, al tempo stesso, una smentita alla sua fissazione di essere troppo «brutto» per poter essere amato; poi provò anche un senso di pena, quasi di colpa, per l’uomo. Infine, gli venne da ridere.
«El me par Alí Babà» gli disse.
L’uomo gli lanciò un’occhiata cattiva.
«No son – gli rispose – una baba (aveva scambiato un nome proprio con uno generico e, nelle sue condizioni, offensivo); e lei el dovessi saverlo».
Ernesto rise piú forte, quasi come il giorno del cono. Poi gli spiegò che Alí Babà era il personaggio di una fiaba venuta, come i Re Magi, dall’Oriente, e non aveva nulla da fare con le «babe». «El fazeva – gli disse – el suo mestier, e el portava anche lui qualcossa de rosso in testa».
Bisogna sapere che, quando Ernesto aveva tredici anni e sospirava il gilè, aveva passato la piú deliziosa estate della sua vita a leggere, sdraiato a pancia in giú sul letto di ottone, nell’unica stanza della casa che avesse il tetto spiovente, Le Mille e una Notte. Dimenticava in quella lettura perfino i bagni di mare, che tanto gli erano piaciuti. Proprio in quella felice estate il marito della sua balia gli aveva regalato Pimpo (il merlo); e la meraviglia che provava per gli usi e i costumi dell’uccello e quella destata in lui dalla lettura delle Mille e una Notte, si fondevano in una sola indimenticabile beatitudine. Soprattutto gli era piaciuta la storia di un ragazzo (adesso non ne ricordava già piú il nome) che ritrova suo padre mai, a sua memoria, conosciuto, in una città straniera, per le vie della quale usciva a spasso, accompagnato da uno schiavo. Il padre che, dopo molte avventure, faceva adesso il pasticcere (a Bagdad, a Bassora?) non riconobbe nemmeno lui il figlio, che aveva lasciato piccolo bambino; ma, attratto dalla voce del sangue, o dalla straordinaria bellezza del fanciullo, lo invitava nella sua bottega, a prendere, gratuitamente, un gelato; assicurandolo che nessun altro pasticcere ne confezionava di uguali e di piú squisiti. Il fanciullo aveva la proibizione piú assoluta di mangiare fuori di casa, o di parlare a chicchessia; e lo schiavo non voleva, a nessun costo, accettare l’invito. Ma le insistenze del pasticcere prima e del fanciullo poi, finirono con l’avere in lui partita vinta sulla paura del castigo, che inevitabilmente l’attendeva se l’infrazione si fosse scoperta. Il sorbetto era infatti cosí squisito che il fanciullo ne accettò un secondo. Poi – malgrado le recriminazioni dello schiavo che, per aver ceduto una volta, era ormai in sua balia – volle ritornarvi ogni giorno: anzi, non voleva altre mète alla sua passeggiata. Poi tutto – si capisce – si scopre (il fanciullo aveva mangiati una sera tanti gelati che non gli restava piú posto per la cena, e dovette confessare ogni cosa a sua madre); lo schiavo viene frustato a sangue, e i genitori del fanciullo, sempre innamorati l’uno dell’altro, si ritrovano per virtú di quei sorbetti e ricongiungono. Ernesto era rimasto colpito da un’esclamazione del fanciullo che doveva avere, nella favola, circa la sua età di allora. Come il pasticcere, sempre piú affascinato dalla bellezza dell’ospite, vuol passare dalle parole alle carezze, il fanciullo gli intima, ritraendosi: «Restate tranquillo al vostro posto. Accontentatevi di guardarmi e di servirmi». (Ernesto avrebbe dato qualunque cosa al mondo per essere, anche solo per cinque minuti, quel fanciullo). Poi la sera la signora Celestina, che, a vederlo cosí infervorato nella lettura, si impensieriva e irritava, gli dava qualche soldo, perché uscisse a fare un pò di moto, e prendesse pure un piccolo gelato all’aperto. Il giovanetto lo consumava al «Caffè de...