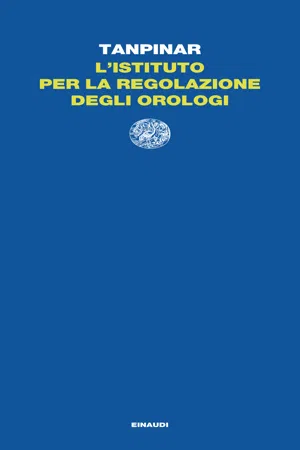![]()
![]()
İsmail lo Zoppo, al quale dopo un’aspra discussione con Pakize e le sue sorelle mi ero rassegnato a dare in sposa la mia figlia maggiore, Zehra, stava giocando a tavla al tavolo vicino al mio. Osservandone il volto cadente e giallastro, quel moncone di naso reso deforme dal vaiolo e gli occhi gonfi, pensavo alla sventura che mi stava rovinando quella bella mattina di primavera.
Se Zehra fosse vissuta in un’altra casa e l’avessero trattata meglio e con piú riguardo, di sicuro il suo unico pretendente non sarebbe potuto essere İsmail lo Zoppo. Nonostante i vestiti lisi e l’aspetto trasandato, era molto femminile, una bellezza fresca che faceva pensare a una giornata di primavera. Sfortunatamente, grazie all’impegno profuso in dodici anni, le mie due cognate – la melomane e la candidata al concorso di bellezza – erano riuscite a convincere la ragazza di essere brutta e sgraziata. All’inizio Pakize aveva timidamente cercato di cambiare l’atteggiamento delle sorelle nei confronti di mia figlia. Poi, quando a casa erano cominciati i problemi, anche lei aveva finito per prendersela con Zehra, come se fosse l’unica responsabile della nostra miseria.
La sera precedente la mia cognata piú grande aveva aggredito Zehra senza motivo; per occultare questa clamorosa ingiustizia Pakize, a sua volta e senza alcuna ragione, aveva fatto piangere mio figlio Ahmet. Zehra, che fino a quel momento di fronte ai torti subiti era rimasta zitta, non era riuscita a tollerare quelli nei confronti di Ahmet, e aveva litigato violentemente con sua madre. Quello che mi piaceva di piú in Zehra era che di tanto in tanto si risvegliava in lei qualcosa che dormiva nel profondo. Zehra sapeva e faceva cose che io ignoravo e non ero capace di fare. Sapeva ribellarsi all’ingiustizia. Purtroppo quella volta la sua reazione si era ritorta contro di me. Perché in situazioni simili Pakize utilizzava una sola tattica. Considerava le discussioni con gli altri una mera perdita di tempo e immediatamente e senza farsi troppi scrupoli passava ad attaccarmi con tutta la sua veemenza, come se fossi io il vero nemico. Era andata cosí anche quella volta. La lite era continuata fin nel cuore della notte. Alla fine aveva gettato il mio cuscino e la mia coperta sul divano. Pakize mi aveva cacciato dalla camera da letto.
A quei tempi, era l’unico aspetto della nostra relazione in cui Pakize si sbagliava. Pensava seriamente che cacciarmi dalla camera da letto fosse una punizione. In realtà, visto che nonostante i suoi trentacinque anni non aveva ancora imparato a dormire come si deve, preferivo di gran lunga stendermi sul divano dell’ingresso.
Pakize credeva a tal punto nell’efficacia di questa punizione che per non perderne i vantaggi aveva rifiutato per anni le mie insistenti richieste di avere camere separate.
– È impossibile, Dio mio! Io dormire in camera e mio marito sul divano? Non potrei stare tranquilla e nemmeno chiudere gli occhi sapendoti in un posto cosí scomodo…
In realtà era al suo fianco che non mi sentivo a mio agio. Mia moglie, che di giorno, quando non litigavamo o andavamo al cinema, era un modello di indolente pigrizia, dal momento in cui sprofondava nel mondo dei sogni si trasformava in una specie di acrobata: le braccia, le mani e le gambe sembravano moltiplicarsi vorticosamente, la sua forza si decuplicava e quando si girava sulla pancia come un ragno le venivano delle specie di attacchi epilettici che scatenavano una vasta gamma di movimenti, figure plastiche che facevano pensare a una danza oppure a rituali primitivi, e tutti i suoi organi moltiplicati mi stringevano e mi afferravano come in una morsa, mi avvinghiavano con strane composizioni, per poi allontanarsi sussultando brutalmente.
E se a questo caleidoscopio di movimenti aggiungete il ronfare, l’ansimare e i borbottii provocati dal suo disturbo alla tiroide, riuscirete a immaginare in che razza di festival trascorressero le mie notti.
Un’altra mania di Pakize era quella di svegliarmi per raccontarmi i suoi sogni quando erano ancora caldi. In quei momenti mi appariva chiaro come nel sonno riuscisse a ottenere le soddisfazioni che le mancavano nella vita diurna. Per questo motivo, anche se le nostre discussioni erano sempre molto aspre, ero ben felice di poter dormire in un letto separato.
Quella notte dormii sul divano. Quando tutti si furono addormentati, mia figlia mi si avvicinò pian piano. Mi disse che aveva deciso di sposare İsmail lo Zoppo. I suoi occhi erano gonfi di lacrime.
– Ormai non resisto piú. Porterò con me anche Ahmet. Forse si troverà meglio. La madre di İsmail viene domani. Passa a trovarmi tutti i giorni e mi chiede a che punto sono. Le dirò che ho deciso –. Se ne andò silenziosamente cosí come era venuta, soffocando i singhiozzi.
İsmail lo Zoppo era a due passi da me. Potevo vederlo in tutta la sua bruttezza, che insieme alla sua abiezione si insinuava sin nelle profondità piú recondite dell’animo umano. Possedeva tutte le caratteristiche negative descritte dalla frenologia. La sua fronte era cosí stretta che quasi non c’era. Lui però si piaceva. Le braccia erano lunghe e le dita rattrappite, i palmi delle mani larghi, ruvidi e rossi come ferite. Lo spessore del labbro inferiore e la tendenza degli occhi a sfuggire di lato tradivano il suo carattere crudele, indicavano che si trattava di uno stupido scroccone e di un impostore. Aveva una voce graffiante come una spazzola di metallo. Niente piú di quella voce rivelava che non aveva mai avuto rapporti con la civiltà. I denti giallastri e storti erano accavallati. Era un segno di sventura e di avarizia. Era innegabile che in lui ci fosse qualcosa che non andava. Povera Zehra, cosa avrebbe fatto con quel marito?
Pian piano cominciavo a sentirmi a disagio. Ormai desideravo solo alzarmi. In quel caffè dove aspettavo impaziente il dottor Ramiz, il mio futuro genero mi stava avvelenando l’esistenza.
Mentre giocava, la mascella e il labbro superiore vibravano come il meccanismo di un orologio e il pomo d’Adamo si muoveva freneticamente. Ma la cosa peggiore erano le mani. Quelle mani grandi con dita tozze e grassocce, apparentemente incapaci di un lavoro onesto, sembravano create per il crimine e per cose turpi che non si possono nemmeno nominare.
«Porterò con me anche Ahmet…» La frase di Zehra che la notte precedente avrebbe dovuto consolarmi adesso mi riempiva di terrore. Non una, ma due vittime avremmo sacrificato! Mi battei una mano sulla fronte. «Hayri İrdal, riprenditi! Non puoi occuparti di lui, è impossibile che tu ti possa occupare di quel bambino». Ma che ne sarebbe stato? Il suo destino non sarebbe cambiato, anzi, forse sarebbe peggiorato.
Un paio di volte cercai di alzarmi. Ma tornai a sedere, stregato dalle urla che lanciava il mio futuro genero. Che essere mostruoso, impregnato di malvagità. Quanto era brutto e rozzo. No, certamente non avrei dato mia figlia a quell’uomo. E con che spaventosa irruenza giocava! Il gioco non era un’attività alla quale partecipava con distacco, ma piuttosto con una forza che si impadroniva del suo corpo e lo scuoteva, lo faceva muovere come se volesse addentare, azzannare qualcosa. Il piede destro, che si intravedeva dalla calza strappata infilata nella scarpa, batteva sotto il tavolo come sul pedale di una macchina da cucire, il pomo d’Adamo andava su e giú in continuazione; come una morsa, le dita sembravano cercare qualcosa da afferrare, le labbra risucchiavano l’aria, la mascella vomitava quello che le labbra avevano risucchiato e il naso cercava di intimorire i presenti emettendo strani sibili.
«Spaventoso, mio caro signore, spaventoso! Spaventoso e stupido, è un idiota e un animale».
All’improvviso una mano mi si posò sulla spalla. Il dottor Ramiz disse, ridendo: – È ancora perso nei suoi pensieri? – Accanto a lui c’era un uomo di quarantadue o quarantatre anni, alto, i capelli biondo chiaro, ben vestito, di bell’aspetto e, per dirla tutta, decisamente affascinante.
Il dottor Ramiz mi presentò: – Ecco il mio amico Hayri Bey… Un uomo notevole. Non faccia caso al suo aspetto! – Poi, rivolgendosi a me, disse: – Un mio compagno di scuola, Halit il Regolatore –. E si lanciò nelle solite discussioni. Mentre parlava, puntava un posto libero a un tavolo poco lontano da noi.
Che strana creatura è l’uomo. In quell’istante pensavo che fosse quasi una disdetta che Halit il Regolatore si trovasse là. La presenza di quell’uomo mi impediva di ottenere dal dottor Ramiz un paio di lire in prestito. Come potevo sapere che l’uomo venuto al caffè con il dottor Ramiz avrebbe fatto la mia fortuna? Si trattava della salute dei miei figli, dell’avvenire di mia moglie e delle mie cognate.
«Che arrogante! – mi dicevo. – Non smette di guardare gli altri. Quasi li volesse comprare». La mia rabbia nei confronti dell’estraneo aumentava in modo esponenziale. Tuttavia il suo sguardo non aveva nulla di fastidioso. Non assomigliava a quelli che mi sentivo addosso da giorni. Non esprimeva disapprovazione, volontà di giudicare e nemmeno ironia. Semplicemente si limitava a guardare come avrebbe guardato qualunque altra cosa. Cercava di capire chi fossi, tutto qui.
Al momento di separarci – stavo per sedermi di nuovo e loro per passare al tavolo adocchiato dal dottor Ramiz –, quando ormai le mie speranze erano naufragate, secondo un’abitudine che aveva preso di recente il dottor Ramiz iniziò a battermi sulla spalla e ad accarezzarmi il mento e le guance, passando in rassegna i miei vestiti – negli ultimi tempi si comportavano tutti cosí con me, e nessuno mi avrebbe lasciato senza aver completato l’inventario del mio abbigliamento –, ma all’improvviso si bloccò e disse all’amico:
– Si lamentava del tuo orologio… Hayri Bey potrebbe dargli un’occhiata! Lui se ne intende…
Il dottor Ramiz, che invecchiando aveva la tendenza a parlare in libertà, continuò:
– Vedrà, è un uomo generoso e tollerante, non ha un negozio suo ma conosce gli orologi…
Poi si voltò verso di me e in tono cerimonioso disse:
– Venga, Hayri Bey. Prendiamoci un caffè.
Malgrado tutte le differenze di ricchezza, status, educazione e agiatezza che esistevano tra me e il suo vecchio compagno di scuola, per dimostrare ad Halit il Regolatore quanto mi stimasse, mi mise un braccio intorno alle spalle.
Negli ultimi cinque anni andava sempre cosí. I miei vecchi amici si sentivano in obbligo di mostrare che mi volevano bene nonostante i miei numerosi difetti. Tra loro il dottor Ramiz era il piú innocente. Dopo essersi seduto al tavolo libero, mentre si passava la lingua sui denti, il dottore cominciò a fare l’elenco delle mie virtú.
– Cosa non conosce Hayri Bey… L’alchimia, l’oniromanzia, la chiromanzia, l’aritmomanzia, la cleromanzia, la crittografia e la magia. È al corrente di tutto. Anche della scienza della medicina antica. Giusto ieri ha fatto una diagnosi, nemmeno io ci potevo credere.
Era vero, da cinque anni tiravo avanti ingannando le persone con il repertorio di Seyit Lütfullah.
Halit Bey lo ascoltava e allo stesso tempo mi osservava come se si stesse dicendo: «Appena avrò dei soldi, passerò da lui, adesso so dove trovarlo. Ma cosa ci guadagnerei?» Halit era il genere d’uomo che aveva questo tipo di approccio con le persone. Per questo il suo sguardo non infastidiva. Semplicemente vi abbassava al livello degli oggetti. D’un tratto mi chiese: – Veramente si intende di orologi?
Io non ero generoso, non conoscevo l’alchimia, la crittografia e la medicina antica; malgrado il berretto, i capelli precocemente imbiancati, la barba mal rasata e l’aspetto da derviscio, non facevo parte di nessuna confraternita sufi cosí come non capivo nulla di orologi. Ma ero abituato a mentire. Non avrei potuto gestire diversamente quella monetina falsa che chiamano vita. Erano gli uomini ad aver voluto che fossi cosí. Ero un bugiardo. Dovevo dire che mi intendevo di orologi? Bene, c’erano almeno trentacinque modi per dirlo. Che mi trovassi di fronte a Cemal Bey, a Selma Hanım, al dottor Ramiz, a Sabriye Hanım, ad Asaf Bey, lo dicevo a tutti ma a ciascuno in modo diverso. Osservai per un po’ Halit il Regolatore. No, decisamente qui dovevo agire in modo diretto. Dissi a bassa voce: – Mah, vediamo, diamoci un’occhiata!
Lui tirò fuori dalla tasca un piccolo orologio d’oro senza catenella e me lo depose al centro della mano. L’orologio era stato lavorato cosí bene che credetti di avere sul palmo un piccolo sole.
Mentre tenevo le dita strette intorno all’orologio temendo che potesse cadere, lui ripeteva: – Sono due mesi che non funziona. È un ricordo di mio padre. Per questo gli sono molto affezionato. Cosa potrebbe avere?
– Un difetto, – dissi, – e anche grosso. Certo che non funziona. Un orologio senza catenella è come un animale senza guinzaglio, come una donna senza matrimonio. Chi ama il suo orologio lo tiene legato a sé con una catenella.
Pronunciai quelle parole per sondare il mio interlocutore e anche per guadagnare un po’ di tempo.
Halit il Regolatore mi fissò attentamente: – Ha ragione! L’ho fatto cadere due volte.
– Peccato! – risposi. – Perché è un bell’esemplare. Piuttosto raro ai giorni nostri. Roba inglese. Metà del diciannovesimo secolo. Una piccola meraviglia.
L’orologio era veramente bello. Stavo quasi per dimenticarmi di İsmail e persino di mia figlia. Da anni, da quando avevo riparato l’orologio della moglie di Cemal Bey, non mi ero piú ritrovato per le mani un esemplare cosí ben fatto. Ero veramente emozionato.
– Qui non ho gli strumenti, forse con un coltellino.
Infilai la mano in tasca per cercarlo, ma la ritrassi come se mi fossi scottato. Il coltellino era da Ali Efendi al mercato maltese. Negli ultimi tempi eravamo ridotti cosí. A casa nostra, a parte le cose che appartenevano alle mie cognate, tutto quello di cui avevamo bisogno ci portava dritti al mercato delle pulci o a quello maltese. Oppure, invece dell’oggetto cercato, ci compariva di fronte il volto del mercante, la sua attenzione esasperante o il suo naso arricciato. A tavola, a letto, quando ci vestivamo, quando ci spogliavamo vivevamo costantemente con queste rappresentazioni davanti agli occhi. Ogni oggetto era legato a un addio la cui immagine non ci abbandonava mai.
Il dottor Ramiz aprí la borsa. Tirò fuori il suo coltellino. Dopo un istante, giusto il tempo di co...