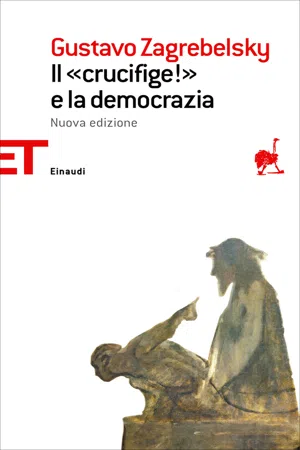![]()
1. Il «crucifige!» e la democrazia.
Si era dato un contrasto tra Pilato, il procuratore romano della Giudea, e il Sinedrio di Gerusalemme, la massima autorità ebraica. La posta in gioco era la vita di Gesú. Tra l’imposizione di una decisione unilaterale, la liberazione di Gesú con un atto d’imperio che al procuratore era certamente consentito, e la resa ai notabili del Sinedrio che chiedevano la conferma della condanna a morte che essi avevano già pronunciato, Pilato scelse un’altra possibilità e aprí una procedura «democratica», appellandosi al popolo.
La decisione finale fu presa nel crescendo impressionante di fanatismo popolare che Marco, tra tutti gli evangelisti, racconta nel modo piú vivido:
La moltitudine gridando cominciò a domandare che facesse come sempre aveva lor fatto [Allusione alla consuetudine, molto discussa in sede di critica storica, di liberare un condannato a morte in occasione della Pasqua, il cosiddetto «privilegium paschale»: «Or il governatore soleva ogni festa liberare un prigione alla moltitudine quale ella voleva» (Mt 27, 15)]. E Pilato rispose loro dicendo: Volete voi ch’io vi liberi il Re dei Giudei? Perciocché riconosceva bene che i principali sacerdoti glielo avevano messo nelle mani per invidia. Ma i principali sacerdoti incitarono la moltitudine a chiedere che piú tosto liberasse loro Barabba. E Pilato, rispondendo, da capo disse loro: Che volete adunque che io faccia di colui che voi chiamate il Re dei Giudei? Ed essi gridarono di nuovo: crocifiggilo. E Pilato disse loro: Ma pure, che male vi ha fatto? Ed essi vie piú gridavano: crocifiggilo!1 (Mc 15, 8-14).
Che cosa vedere in questo grido? A prima vista, un inconfutabile argomento contro la democrazia. Secondo verità e giustizia, il dilemma che i Vangeli dicono essere stato sottoposto al popolo – Gesú o Barabba – non avrebbe potuto consentire dubbi. Il popolo, infatti, non esitò. Ma la decisione che prese fu, scandalosamente, l’altra. In quest’episodio, da duemila anni, verità e giustizia testimoniano per l’appunto contro la democrazia.
Per allontanare lo scandalo di quel grido, noi possiamo soltanto rifiutare il contenuto di valore della scelta proposta alla folla: dobbiamo considerare equivalenti Gesú e Barabba e indifferente la scelta a favore della vita e della morte dell’uno o dell’altro.
È quanto ha fatto Hans Kelsen, nella sua riflessione sulla democrazia. In un breve paragrafo, dal titolo Gesú e la democrazia, che chiude uno dei suoi capolavori: Essenza e valore della democrazia del 19292, egli – dopo aver reso omaggio alle qualità letterarie del testo: «questa semplice storia, espressa con parole ingenue, è uno dei piú sublimi brani della letteratura mondiale» (il riferimento è ai capitoli 18 e 19 di Giovanni) – ricostruisce la narrazione del dialogo tra Gesú e Pilato sulla verità come uno scontro che, «senza averne l’intenzione, diviene un tragico simbolo dell’antagonismo tra assolutismo e relativismo». E prende cosí posizione tra i due, dal punto di vista della democrazia: «Pilato, poiché era un relativista scettico e non sapeva che cosa fosse la verità, la verità assoluta in cui quell’uomo credeva, agí in modo democratico – con assoluta coerenza – rimettendo la decisione del caso al voto del popolo. Per coloro che credono nel figlio di Dio e re dei Giudei come testimone della verità assoluta, questo plebiscito è certamente un serio argomento contro la democrazia. Noi scienziati della politica dobbiamo accettare questo argomento, ma solo a una condizione: di essere tanto sicuri della nostra verità politica da imporla, se necessario, con lacrime e sangue; di essere tanto sicuri della nostra verità quanto il Figlio di Dio era sicuro della propria».
In breve: la condanna popolare di Gesú è un argomento – un argomento definitivo – solo per chi è certo della verità. Solo a questa condizione – la conoscenza del vero e del falso, del bene e del male – il crucifige! della folla potrebbe assurgere a prova inconfutabile dell’insensatezza della democrazia. Il vero e il falso, il bene e il male non possono dipendere, infatti, dal numero e dalle opinioni. Ma se invece respingiamo quella pretesa conoscenza come la suprema tentazione del serpente (Gen 3, 5) – questa è la conclusione – la condanna popolare di Gesú non ci dice piú nulla sulla democrazia.
In questo modo, nell’etica politica si finisce per oscillare tra due estremi: dal dogma alla schepsi, dall’assolutismo al relativismo dei valori. La democrazia, inammissibile per lo spirito dogmatico, verrebbe giustificata solo in un contesto spirituale scettico e relativistico. Democrazia e schepsi si legherebbero cosí l’una all’altra, come la conseguenza alla sua necessaria premessa. Gesú, forte della sua verità, sarebbe il campione dell’anti-democrazia, cioè dell’autocrazia, mentre il personaggio positivo dal punto di vista democratico sarebbe Pilato.
Sono conclusioni che paiono difficilmente accettabili.
La tesi mia è diversa. Se si considera la condanna di Gesú attraverso l’insieme dei fattori che l’hanno determinata, appare con evidenza che tanto il dogma quanto la schepsi possono convivere con la democrazia ma, sia l’uno che l’altra, strumentalizzandola. Sia il dogmatico che lo scettico possono essere amici della democrazia, ma solo come falsi amici. Il dogmatico può accettare la democrazia solo se e fino a quando serve come forza, una forza indirizzata a imporre la verità. Lo scettico, a sua volta, poiché non crede in nulla, può tanto accettarla quanto ripudiarla. Se è davvero scettico, non troverà nessuna ragione per preferire la democrazia all’autocrazia. O meglio, troverà una ragione non nella fede in qualche principio, ma in una convenienza. Potrà cioè essere democratico, fino a quando lo sarà, non per idealismo ma per il realismo del proprio interesse, cioè per opportunismo.
Ecco abbozzate due mentalità, due forme di pensiero: del dogmatico e dell’opportunista. Tutte e due, in determinate circostanze, possono essere compatibili con la democrazia, anzi possono perfino abbracciarla con enfasi e cosí apparire addirittura ultra- o iper-democratiche. Ma la loro, in ogni caso, dietro le apparenze, non è un’adesione ma piuttosto un’adulazione interessata. Esse non servono la democrazia, ma se ne servono, se e fino a quando può servire.
A questi due modi di pensiero – opposti nel fondamento ma convergenti nella strumentalizzazione – una teoria della democrazia come fine e non solo come mezzo deve saperne contrapporre un altro, che non presuma di possedere la verità e la giustizia ma nemmeno ne consideri insensata la ricerca. È questo il pensiero della possibilità, che è proprio di coloro che rigettano tanto l’arroganza della verità posseduta quanto la rinuncia della realtà accettata. Il pensiero della possibilità contiene sempre e di nuovo l’apertura alla ricerca e il suo postulato è la strutturale plurivalenza di ogni situazione in cui ci si venga a trovare. La sua esigenza etica non è la verità o la giustizia assolute, come per lo spirito dogmatico, ma, tra tutte le possibilità, la ricerca orientata al meglio, un’esigenza che soltanto lo spirito radicalmente scettico potrebbe negare, in nome di una tentazione assolutistica rovesciata. Solo per il pensiero della possibilità, la democrazia, oltre che un mezzo, può anche essere un fine e perciò, oltre che servire, deve anche essere servita. Alla democrazia che assume come proprio questo atteggiamento dello spirito si addice il nome di democrazia critica.
2. Democrazia senza nemici?
Oggi, per la prima volta nella storia italiana, la democrazia è comunemente accettata, senza rilevanti eccezioni. Perfino l’ultimo partito che si richiamava all’ideologia sorta nel secolo scorso per l’appunto come reazione antidemocratica – il fascismo – ha ufficialmente tagliato le sue radici per approdare alla democrazia.
La «repubblica democratica» che, come sintesi e programma dell’intera Costituzione, campeggia nel suo primo articolo ha dunque vinto la propria battaglia? Al di là di tutte le differenze particolari che ci dividono, possiamo allora dire che c’è oggi un nucleo saldo di valori politici cui tutti aderiscono e grazie ai quali possiamo fidarci, gli uni degli altri? Sarà forse questo il terreno su cui è cresciuta la nazione italiana? Come altri parlano di patriottismo della Costituzione, cosí da noi si può parlare di patriottismo della democrazia?
Quando ci lasciamo andare all’ottimismo o ci prende il bisogno di rassicurazione, siamo tentati dalla risposta positiva. Sí, mai come ora la democrazia ha goduto di tanta buona salute. L’Italia è diventata una nazione democratica, non importa se per convinzione o, come dicono gli incontentabili, solo per assuefazione.
Eppure, avvertiamo una contraddizione. È come se un indebolimento accompagnasse l’estensione. Questa generale conversione coincide col manifestarsi di atteggiamenti antidemocratici di massa e col rifiorire, in forme rinnovate, per conformarsi alle caratteristiche e alle difficoltà del tempo presente e spesso con argomenti non trascurabili, di una letteratura che non risparmia le critiche alla democrazia e alle sue istituzioni fondamentali (in primo luogo al parlamento e ai partiti), svelandone l’aspirazione illusoria o «ideologica», la copertura di poteri e interessi oligarchici spesso spregevoli, la decadenza dello spirito pubblico, la spossatezza morale e, in ogni caso, l’inadeguatezza ad affrontare le sfide terribili dell’ultimo tempo del secolo scorso e di quello che ora viviamo. Sotto certi aspetti, c’è una riproposizione, spogliata dell’alone romantico e vitalistico che caratterizzava la letteratura della «crisi della civiltà» e rivestita piuttosto della forza fredda di argomenti di scienza politica e tecnologia sociale, di tesi e stati d’animo antidemocratici che ebbero corso dalla fine del XIX secolo fino a preparare il terreno e spianare la strada all’avvento dei regimi totalitari.
Il nostro tempo, insomma, non è quello della glorificazione, ma quello della critica della democrazia, una critica che ne ha spietatamente messi in luce i limiti, le opacità e le mistificazioni. Eppure tutti si proclamano democratici. La critica antidemocratica di un tempo aveva prodotto movimenti e partiti antidemocratici. Non si è forse troppo lontano dal vero se si osserva che ora (e per ora), a differenza di allora, non si sa opporre alla democrazia nessun’altra concezione, nessun altro ethos capaci di far breccia nella coscienza collettiva. La democrazia è l’ideologia del nostro tempo, forse non per convinzione né per assuefazione, ma per mancanza di alternative.
Se poi guardiamo le cose piú da vicino, senza farci impressionare dalle formule e dalle dichiarazioni di fede, ci rendiamo facilmente conto del perché la parola democrazia non divide piú. Da sempre, ci sono stati molti modi di intenderla. Ma oggi lo sviluppo della tecnologia nella comunicazione politica e le novità che esso permette nel rapporto governanti-governati rendono possibile addirittura far passare nel campo della democrazia, come regimi fondati sul consenso, forme di governo che in passato si sarebbero facilmente ascritte al campo dell’autoritarismo antidemocratico. Di piú: questa trasmigrazione si presenta sotto il segno del massimo ossequio alla volontà del popolo sovrano, dunque dell’optimum desiderabile. L’ambiguità è il carattere della democrazia del nostro tempo.
La «parola» democrazia non divide piú, ma la «cosa», cioè le concezioni della democrazia, dividono oggi come non avveniva dai tempi piú caldi della guerra fredda e della grande divisione tra partiti di obbedienza occidentale e orientale. Lo stile e gli argomenti della campagna elettorale per le elezioni politiche e delle vicende politiche degli ultimi anni mostrano che l’argomento democratico è ridiventato l’arma nelle mani di forze che cercano di sopraffarsi, squalificandosi vicendevolmente. Le circostanze storiche mutano, ma la democrazia nel nostro Paese continua cosí a essere debole, perché non cessa di costituire un punto di discordia.
Non ci sarebbe nulla di strano se una nozione, comunque la si intenda, tanto carica di significati prescrittivi fosse usata come criterio di valutazione e critica dei comportamenti degli avversari, e quindi anche come strumento della contesa tra partiti. Per quanto interessato, questo genere di contesa si risolverebbe alla fine in un omaggio comune e quindi in un rafforzamento della democrazia. Ma ora, da noi, non è cosí. Oggi sono possibili nuovi camuffamenti. Tutti possono rendere omaggio alla democrazia-parola, ma concepire la cosa molto diversamente. Una democrazia è posta contro un’altra democrazia, in un muro contro muro che può diventare tanto piú distruttivo perché si svolge nella stessa casa, come una guerra civile non tra avversari ma tra traditori della medesima fede.
Non possiamo pensare che la disputa sia oziosa, che si tratti di una di quelle controversie, vuote di contenuto e senza importanza, che alimentano la lotta tra partiti con lo scopo di impressionare il pubblico e catturare voti. La posta è grande, la questione è reale. Chi serve la democrazia e chi se ne serve? Per rendere intelligibile e produttiva questa domanda, abbiamo bisogno di qualche categoria sufficientemente precisa per poterla sottrarre al moralismo costituzionale, un terreno sul quale non si è mai concluso nulla e si è sempre e solo fomentata la confusione. Le tre concezioni della democrazia che propongo – le concezioni dogmatica, scettica e critica – vorrebbero essere un contributo a questa chiarificazione.
Ritorniamo al processo di Gesú. Il pensiero dogmatico crede di trovarvi tutto, cioè la condanna inappellabile della democrazia; il pensiero scettico non vi trova nulla. L’uno e l’altro non sospettano che invece vi si parla di loro e della loro concezione della democrazia. Il pensiero critico non spera di trovarvi né tutto né niente, ma qualcosa. Precisamente: una rappresentazione delle possibilità insite nell’atto democratico tipico, l’appello al popolo, che aiuti a comprendere il significato di queste distinzioni e a separare i veri dai falsi amici della democrazia.
3. I Vangeli: paradigmi senza tempo.
Ci si può accostare alle Scritture con atteggiamenti molto diversi e tutti legittimi. Vi si possono cercare valori artistico-letterari, informazioni storiche per la ricostruzione della vita politica e sociale in quei luoghi e in quel tempo, insegnamenti per una visione morale della vita e, infine, parole che ci dicano di Dio per farne una teologia. Sono evidentemente prospettive indipendenti tra loro che non si implicano necess...