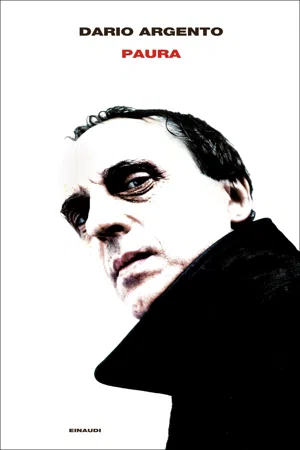Dunque studiavo al collegio Nazareno. Era un palazzo antico, con le pareti affrescate, grandi finestre con tende molto spesse, le aule piene di quadri raffiguranti vecchi vescovi o importanti condottieri, statue… C’erano corridoi di marmo lunghissimi, tetri – al cui confronto quello di casa mia era una bazzecola – che convergevano nella cappella, dove ogni mattina si teneva la messa.
Io però non andavo mai a messa. Non lí, almeno. Non mi piaceva che gli altri miei compagni mi vedessero come uno di loro, che seguiva supinamente gli ordini. Perché chi andava a prendere la comunione nella cappella del collegio, volente o nolente, diventava lo schiavetto dei preti. Volevo sentirmi libero di pregare per conto mio, di vivere la religione senza condizionamenti. Ero stato allenato da nonna Laudomia a frequentare la messa: nessuno in famiglia le dava grandi soddisfazioni sul versante religioso, tranne me. Era orgogliosa di poter condividere con qualcuno le preghiere, il rosario, il rito della comunione.
Quando a maggio c’era il mese mariano, per me era una consuetudine andarci da solo. La mattina, prima di entrare a scuola, entravo di nascosto in una chiesa dove si teneva la messa delle 7,30. Non era una fatica svegliarmi presto: avvertivo un senso di sacro che mi avvolgeva, che mi scaldava. Mi sentivo piú adulto rispetto ai miei coetanei. L’estraneità che avrei provato in altri momenti della mia vita cominciò a manifestarsi a quei tempi, che ricordo come un momento di puro misticismo infantile.
Il giorno del mio tredicesimo compleanno mia madre mi fece un regalo bellissimo, che conservo ancora. Il pacchetto era grande all’incirca quanto una scatola da scarpe, ma quando lo scartai dentro ci trovai due libri apparentemente identici. Avevano la copertina arancione, e sopra vi erano impresse due lettere: E G. Era l’Enciclopedia Universale Garzanti, che poi tutti avremmo chiamato la «Garzantina». A casa avevamo la Treccani, ma quei libroni erano grossi, ingombranti. Ora invece quei due volumi li potevo portare dappertutto, mi sembrava un’invenzione rivoluzionaria.
Presi a leggerla dalla prima pagina, come fosse un romanzo, e nelle settimane seguenti scorsi tutte le voci del primo voume A-L, e poi passai al secondo, M-Z. Me la portavo anche a scuola, e quando mi annoiavo sbirciavo la mia enciclopedia portatile. Trovavo straordinaria la possibilità di tenere nella cartella tutto lo scibile umano.
Un po’ perché stare in mezzo ai preti proprio non mi piaceva (sospettavo persino di aver perso la fede a causa loro), un po’ perché la nuova scuola era piú vicina a casa, abbandonai il Nazareno e per un paio d’anni frequentai il liceo Mamiani. Molta gente dice di ricordare il periodo scolastico come il peggiore degli incubi, e io pure non sono da meno, tanto che in quegli stessi corridoi del Mamiani – dove fra una lezione e l’altra mi aggiravo guardingo – ci avrei ambientato una sequenza di Profondo rosso.
Ero l’ultimo arrivato, e per via del mio carattere introverso mi feci subito qualche nemico: la professoressa di italiano, ad esempio. Si capiva che non le stavo simpatico, quando poteva cercava sempre di mettermi in difficoltà davanti alla classe.
Eppure ero bravo a scrivere, le storie mi venivano facili. Passavo pomeriggi interi a imbastire inizi di racconti, brevi trame, poesie, insomma un turbinio di idee. Quando acquistai un po’ di coraggio cominciai a recensire i primi film, se cosí si può dire: stavo davanti alla macchina per scrivere e battendo sui tasti li commentavo, li raccontavo – prima di tutto a me stesso. Pubblicavo questi pezzi sul giornalino della scuola, e su alcune riviste specializzate autoprodotte che trovavo nei cineclub. Era l’epoca delle fanzine, e io ero molto fiero di questa cosa. Guardare film, scrivere e leggere: non avrei fatto altro.
L’insegnante di italiano una volta mi disse: «Perché non hai letto le pagine di Manzoni che ti ho assegnato?»
Io sollevai le spalle e risposi serafico: «Perché dovevo leggere Dos Passos».
Tornai a casa con una bella nota: quella strega mi aveva sospeso per un paio di giorni, e avevo il riassunto di non so piú quanti capitoli dei Promessi sposi da presentare in bella copia per quando sarei stato riammesso in classe.
Ho sempre avuto un rapporto burrascoso con la scuola (e con le istituzioni in generale), ma almeno non mi vergognavo piú di ammettere che leggere mi piaceva cosí tanto. Da quando i miei genitori avevano scoperto che andavo pazzo per i libri, poi, avevo libero accesso alla biblioteca di mio padre.
Il peccato peggiore che potessi compiere, l’ultimo tabú, era leggere i romanzi gialli: me li facevo prestare da qualche ragazzo piú grande. Quando ricevevo clandestinamente quei libri dalle pagine mezze rovinate, consumate da chissà quanti occhi prima dei miei, lungo la schiena mi correva un brivido di piacere. Quelle vicende piene di morti ammazzati con un coltello in pancia, di strangolamenti, di veleno per topi nell’impasto della torta, mi davano emozioni fortissime. Era strano e forse può sembrare un po’ presuntuoso, ma al contrario dei miei coetanei, dei miei fratelli, di tutte le persone che mi erano vicine, sentivo che le cose che leggevo – non solo i gialli, tutte quante – facevano parte di me. Le capivo benissimo, anche le piú lontane o bizzarre: era come se, leggendo, ricordassi qualcosa che avevo dimenticato.
Questa consapevolezza mi incoraggiò a divorare davvero qualsiasi cosa trovassi: i soliti russi che abbiamo letto tutti da ragazzini, e poi gli americani, i francesi… Certo c’era pure la tv: m’interessava meno, anche se qualche anno dopo avrei seguito con inquietudine ed eccitazione la serie di Ai confini della realtà. Rimasi molto impressionato da un episodio in particolare: quello in cui sulla Terra sopravvive un solo uomo, e lui è contento perché finalmente – adesso che l’umanità non c’è piú – può leggere tutti i libri che vuole. E proprio in quel momento gli si rompono gli occhiali! Mi sembrava di poter toccare con mano la sua disperazione.
Ebbi una fastidiosa febbre reumatica che mi tenne a letto per alcuni mesi. Essere costretto a stare sotto le coperte sembrava la scusa perfetta per leggere in santa pace senza nessuno intorno: proprio come in Ai confini della realtà. E cosí in un paio di giorni divorai Cyrano de Bergerac, quella romantica e tormentata storia d’amore mi conquistò e commosse come poche cose. Ma trovai anche dei libri che non erano proprio adatti alla mia età: come Il piacere di D’Annunzio (la scena in cui Andrea ed Elena bevono a piccoli sorsi il tè l’uno dalla bocca dell’altra mi turbò moltissimo), o Le mille e una notte nell’edizione integrale Einaudi. Erano vicende molto spinte, c’era questo mistero che gli adulti chiamavano sesso. La scoperta della masturbazione per me avvenne cosí.
Dietro piazza di Spagna, al numero 8 di vicolo del Bottino, all’ultimo piano c’è la casa in cui si dice che D’Annunzio abbia scritto proprio Il piacere. Io diedi la mancia al portiere e mi avventurai nella sua abitazione: avevo una curiosità sfrenata. Era stretta, e anche se non ricchissima si trattava comunque di una casa molto bella: mi figurai il Vate che sul finire dell’Ottocento scriveva alla luce di quelle finestre, che si affacciava al balcone e guardava di sotto, e immaginava chissà quali torbide vicende.
Una mattina, però, durante uno dei miei abituali saccheggi alla biblioteca di casa, successe qualcosa di imprevisto. M’imbattei in un libro che riuscí a spazzare via in un colpo solo le trame piú fantasiose di Dashiell Hammett e Raymond Chandler, cosí come le avventure amorose narrate da Shahrazād. Era un grosso volume dalla copertina nera e dal titolo in rilievo, a lettere dorate: I racconti del Grottesco e dell’Arabesco, di Edgar Allan Poe. Lo lessi da cima a fondo, e poi ricominciai dalla prima pagina. Un po’ alla volta, inoltrandomi nelle sue storie, mandandole a memoria, mi resi conto che era come se avessi trovato la chiave di una stanza che c’era da sempre nella mia testa, ma di cui ignoravo l’esistenza. Era una stanza vuota, senza un mobile né null’altro, però c’erano delle finestre. Sapevo che bastava spalancarle, proprio come mi bastava aprire il libro di Poe, e davanti a me si sarebbe schiuso un paesaggio popolato da creature ignote. Non ero piú un bambino magro e timido, ammalato nel suo letto, forse non avevo piú neppure un corpo. All’improvviso avevo scoperto un mondo dove c’erano persone sepolte vive, dove i gatti murati rivelavano la presenza di cadaveri, dove i denti e i cuori delle persone amate venivano strappati via dai corpi… E in quel mondo mi sentivo finalmente me stesso. Come mi è già capitato di dire, quel giorno accadde qualcosa di fondamentale. In un batter d’occhio, e senza soluzione di continuità, passai dalla masturbazione al culto dell’orrore e del mistero.
Anni dopo, quando rilessi i racconti di Poe in un’altra edizione, ne ricavai un’impressione strana: mi sembravano diversi. Le trame erano sempre le stesse, certo, però era come se i dettagli macabri e truculenti si fossero moltiplicati. Ormai quel volume appartenuto a mio padre chissà dov’era finito, quindi non potei fare un confronto, ma mi convinsi che la versione letta da bambino fosse stata edulcorata. Dunque, incredibile ma vero, si era ripetuto ciò che già era accaduto con mia nonna e con i film, e che negli anni a venire avrebbe segnato tutta la mia esistenza: la censura era una creatura subdola, e poteva annidarsi ovunque come un serpente velenoso pronto ad aggredirti.
Fra i compagni di scuola avevo degli amici, non molti a dire la verità, che frequentavo piú che altro per andare al cinema; ogni tanto facevamo sega a scuola e andavamo tutti alla matinée, spesso senza pagare. Ci imbucavamo, entravamo da una porticina che aveva scoperto il piú scaltro di noi. La maschera lo sapeva ma non ci diceva niente, si vede che gli stavamo simpatici. Eravamo quattro o cinque e ci guardavamo un film dopo l’altro, senza essere mai sazi: western, storie d’amore, peplum, tutto ciò che passava la casa. Quello che c’era c’era.
Se fra i banchi di scuola, nei corridoi e in generale quando stavo insieme ai miei coetanei cercavo di spostarmi senza far rumore, come se dovessi scomparire da un momento all’altro, non appena entravo in un cinema perdevo tutta la timidezza e diventavo quasi sfrontato. La mia passione per i film era aggressiva, totalizzante, anche a scuola cominciai a organizzare dei dibattiti, ci confrontavamo, e io mi trasformavo in un’altra persona. Facevo il gradasso, sapevo di aver visto piú film dei miei compagni e quindi pretendevo sempre di avere l’ultima parola.
Con Sandro e Vincenzo, in particolare – quelli che allora si dicevano «amici del cuore» –, andare al cinema era qualcosa di piú che un semplice passatempo.
Ricordo che a un certo punto io e Sandro, chissà perché, ci mettemmo in testa di partecipare a un quiz radiofonico. Avremmo portato come argomento il cinema: ci sentivamo abbastanza preparati e ci dicevamo, credendoci, che avremmo potuto vincere una bella sommetta. A parte i film di Totò e Alberto Sordi, il cinema italiano mi interessava poco. Prendemmo cosí a studiare in maniera sistematica la storia del cinema americano, a percorrerla come dei pazzi in lungo e in largo. Ci facevamo le domande sui titoli originali, i nomi degli attori, i premi vinti… Ma andavamo ben oltre il puro nozionismo, azzardavamo collegamenti e ragionamenti sulla tecnica di regia o sulla messa in scena, paragonavamo un regista a un altro: eravamo due giovani critici pieni di entusiasmo e ingenuità.
Un giorno eravamo in sala mentre scorrevano i titoli di coda di Giungla d’asfalto, di John Huston: la storia di una rapina andata a finire male, tra gli attori c’era pure una Marilyn Monroe ragazzina. Prima ancora di alzarmi dalla seggiola domandai quasi a tradimento a Sandro: «Non ti ha ricordato niente, questa storia?»
Lui sembrava smarrito, e allora io gli dissi che quell’altro film ci era piaciuto cosí tanto che eravamo tornati a vederlo. Anche il regista della pellicola a cui mi stavo riferendo doveva aver visto e amato Giungla d’asfalto: in entrambi i film – dissi dandogli un’imbeccata – c’era addirittura lo stesso attore, Sterling Hayden.
Ancora niente, taceva e mi fissava.
«Guarda che dal quiz ti avrebbero già cacciato, – lo stuzzicai. – Prova a concentrarti».
Punto nell’orgoglio stette al gioco: «Sono pronto!»
«Hai un minuto di tempo per rispondere, – dissi a mio agio nel ruolo del presentatore. – È un film del ’56, tratto da un romanzo e…»
«Rapina a mano armata di Kubrick!» m’interruppe con foga.
«Bravo!» replicai assestandogli un pugno sulla spalla.
«Immagina di poter intervistare John Huston, – mi fece Sandro di rimando con gli occhi sognanti. – Cosa gli chiederesti?»
Mi venne da ridere: «Seeee, adesso John Huston sta ad ascoltare me…»
«Ma tu immagina, – insistette. – Che ti costa? Tu e John Huston soli, gli puoi chiedere tutto quello che ti passa per la testa».
Ci pensai su un po’. «Non lo so, – risposi alla fine, – forse lo ringrazierei e basta…»
Le cose che si dicono da ragazzini, uno dovrebbe segnarsele, metterle da parte e poi rileggersele quando è uomo fatto. Quante sciocchezze e contraddizioni, quante speranze e sorprese, ma soprattutto quante assurde e incomprensibili promesse di futuro ci troverebbe dentro?
Come quando mio padre mi propose di accompagnarlo un fine settimana per un viaggio di lavoro.
«Ti faccio vedere una città molto bella», mi disse soltanto, ma io dentro di me avevo già accettato: mi piaceva l’idea di spostarmi, conoscere altri luoghi. Era inverno, e la sera in cui arrivammo a Torino aveva piovuto da poco. L’impressione che mi fece fu molto nitida: i lastroni bagnati, le luci gialle dei lampioni che si riflettevano sull’acqua e rendevano le strade simili a serpenti luccicanti… Era una città livida e misteriosa, e mi conquistò subito. In quel paio di giorni vagai per le sue piazze maestose e austere, imbattendomi nei monumenti che spuntavano nei posti piú impensati, o scoprendo gli scorci mozzafiato che si trovavano dietro ogni angolo di strada. Aveva un’aria malinconica ma anche piuttosto inquietante: le case Art déco, i cortili, le palazzine Liberty… La mia mente aveva cominciato a fantasticare. Mi dissi che sarebbe stato un posto ideale per girarci un film, anche se all’epoca mai avrei immaginato di fare cinema. Di un fatto però ero certo: quella città mi stava parlando, mi comunicava qualcosa. Pensieri strani, forse persino un po’ morbosi. I paesaggi bizzarri hanno ricoperto un ruolo fondamentale nella formazione del mio immaginario. Sono certo che, se il cinema non avesse avuto la meglio su di me, sarei potuto diventare un architetto.
Un giorno mio zio Elio, il fratello di mia madre (da un pezzo lui lavorava a Milano, dove faceva importanti mostre fotografiche), venne a trovarci a Roma in compagnia di mio cugino Livio, il figlio maggiore. A fine pranzo, mentre sorseggiava il caffè, mi chiese di seguirlo: voleva farmi scoprire una parte della città che, assicurò, «non avevo mai visto prima». Cosí caricò in macchina me e mio cugino e si mise alla guida: dopo alcuni giri, finimmo in una strada molto ampia che sbucava in un campo. Era una bella giornata di sole, e in lontananza s’intravedevano delle strutture bianche, dalle forme insolite. Effettivamente lí non c’ero mai stato, non mi sembrava neppure piú di essere a Roma.
Parcheggiò l’auto e ci disse che avremmo dovuto proseguire a piedi: man mano che ci avvicinavamo pareva di entrare in una città del futuro. Percorremmo un lungo viale costeggiato da pini mediterranei, e dopo un po’ raggiungemmo l’Eur, completamente abbandonato a se stesso come in quel vecchio film dell’orrore con Vincent Price, L’ultimo uomo della Terra.
Mio zio era un fascista, tanto nelle idee quanto nell’aspetto fisico (aveva persino la mascella quadrata), e non perse l’occasione per fare un po’ di propaganda. Era troppo orgoglioso all’idea di farci vedere quel quartiere che dopo la guerra era stato ignorato dallo Stato i...