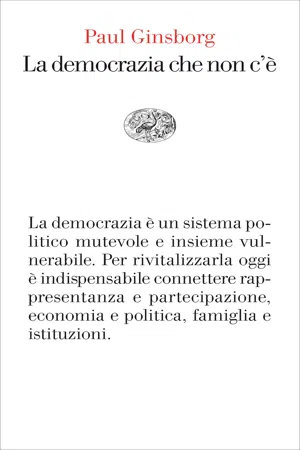![]()
1. Democrazia economica.
Fin qui ho concentrato la mia analisi sulla democrazia come sistema politico, ma le cause della crisi attuale non sono, come abbiamo visto, esclusivamente politiche. Devo ora ampliare il raggio di osservazione e prendere in esame altri fattori che hanno incidenza sul nostro tema centrale. Uno dei piú importanti è l’economia. Gran parte della letteratura sulla democrazia, in particolare quella di stampo liberale, condivide la tesi che le evidenti disparità di ricchezza e potere tra i singoli cittadini nelle moderne democrazie abbiano scarso peso sulla qualità di queste ultime. È vero esattamente l’opposto. Se i cittadini godono di pari diritti nella sfera politica ma vivono manifeste sproporzioni in quella economica, la democrazia rischia di uscirne profondamente incrinata. Spesso le democrazie di piú lunga data vengono definite “mature”. Ma se, come nel caso americano, sono caratterizzate da drastiche ineguaglianze economiche che si ripercuotono direttamente e incisivamente sulla democrazia politica attraverso meccanismi quali i finanziamenti elettorali e le lobby imprenditoriali, meglio forse allora definirle “troppo mature”.
Sostenere, come ho fatto, la necessità di un sistema di connessioni politiche tra famiglie, società civile e stato, per poi trascurare del tutto le relazioni economiche, sarebbe abbastanza contraddittorio. Robert A. Dahl, uno dei piú valenti teorici americani della democrazia, è molto esplicito circa l’esigenza di una connessione tra le due sfere. Arriva addirittura a sostenere la tesi, argomentandondola per esteso, che «se la democrazia è legittimata a governare lo stato, deve esserlo anche a governare le imprese economiche. Affermare che non è legittimata a governare le imprese economiche sottende che non è legittimata a governare lo stato»1 . Sotto il profilo storico egli ci pone di fronte a un forte interrogativo controfattuale: «Saremmo diversi noi americani se negli anni Ottanta dell’Ottocento avessimo scelto come soluzione standard un sistema di autogoverno delle imprese invece che il capitalismo imprenditoriale?»2 . L’eguaglianza agraria su ampia base che era stata il pilastro economico della giovane democrazia americana, e la cui autosufficienza e autorganizzazione avevano suscitato tanto entusiasmo in Tocqueville negli anni Trenta dell’Ottocento, non era piú predominante a cinquant’anni di distanza. Era tempo di porsi domande scomode sull’organizzazione della vita urbana americana e i suoi rapporti con il sistema politico. Non fu mai fatto. Come scrive Dahl, «gli americani non si sono mai posti stabilmente e su ampia base l’interrogativo se un’alternativa al corporate capitalism potesse essere piú coerente con il loro impegno democratico»3 .
Faccio ancora una volta un passo indietro, ai nostri due grandi pensatori vittoriani, per verificare in che misura abbiano fatto luce su questo problema quanto mai scabroso. Sarebbe corretto sostenere che Marx entra qui finalmente nel suo regno. In una precocissima fase del suo percorso intellettuale (1833-34) egli aveva già condannato un sistema politico in cui tutti gli uomini erano all’apparenza liberi ed eguali politicamente ma in cui in realtà restavano profondamente divisi da ineguaglianze di reddito e di opportunità di accesso al potere. Circa quarant’anni dopo Marx salutò con entusiasmo la Comune di Parigi non solo perché «l’esistenza stessa della Comune implicava […] la libertà a livello municipale locale», ma anche perché era «la forma politica finalmente scoperta, nella quale si poteva compiere l’emancipazione economica del lavoro»4 . Per Marx, in altri termini, abbracciare il modello della Comune di Parigi equivaleva a riconoscere che la democrazia politica ed economica potevano e in realtà dovevano avanzare di pari passo. E poco importa se in termini economici la Comune si era limitata ad abolire il lavoro notturno per i fornai e aveva lasciato intatta nel centro di Parigi la residenza di Adolphe Thiers, in seguito responsabile della selvaggia repressione dei Comunardi. Marx era convinto che il carattere fortemente egualitario e partecipativo della sfera pubblica democratica della Comune avrebbe per forza condotto quest’ultima, se fosse sopravvissuta, sul terreno della democrazia economica.
Tuttavia l’analisi di Marx va al di là degli eventi storici di cui fu testimone cosí partecipe. Soprattutto nei suoi Manoscritti economici-filosofici del 1844, egli attua una profonda riflessione sull’alienazione dell’uomo, anche se raramente e superficialmente, va detto, essa si estende alle donne. Secondo Marx, i campi dell’attività umana in cui si manifestava l’alienazione erano molteplici e diversi (religioso, politico ed economico), ma comune a tutti era il concetto che l’uomo aveva abdicato a favore di qualcuno o di qualcosa a una parte di ciò che era essenziale alla sua natura di “specie”. Fondamentalmente, l’uomo aveva alienato la capacità di controllare le proprie attività, di farsi soggetto del processo storico.
Per Marx questa tesi trovava conferma soprattutto nel sistema di produzione capitalista. In esso l’operaio subiva una duplice alienazione, in primo luogo rispetto al prodotto del suo lavoro, che assumeva la fisionomia di un «essere estraneo, come una potenza indipendente da colui che lo produce»5 . In secondo luogo nel processo stesso di produzione l’operaio non aveva controllo sul suo tempo e il suo lavoro era di proprietà altrui: «L’attività come passività, la forza come impotenza, la procreazione come svirilimento»6 . Il risultato finale di questi due processi fu descritto dal giovane Marx con straordinario acume e inimitabile efficacia:
Perciò l’operaio solo fuori del lavoro si sente presso di sé; e si sente fuori di sé nel lavoro. È a casa proprio se non lavora; e se lavora non è a casa propria. […] Quanto maggior valore produce, tanto minor valore e minore dignità egli possiede; quanto piú bello è il suo prodotto, tanto piú l’operaio diventa deforme; quanto piú raffinato il suo oggetto, tanto piú egli s’imbarbarisce; quanto piú potente il lavoro, tanto piú egli diventa impotente […] Il lavoro estraniato strappando all’uomo l’oggetto della sua produzione gli strappa la sua vita di essere appartenente a una specie, la sua oggettività reale specifica e muta il suo primato dinanzi agli animali nello svantaggio consistente nel fatto che il suo corpo inorganico, la natura, gli viene sottratta7 .
L’incisiva, innovativa analisi di Marx dell’alienazione nella fase iniziale del capitalismo e, bisogna aggiungere, dell’alienazione in gran parte del capitalismo globale di oggi, non è accompagnata in nessun momento della sua lunga carriera intellettuale da un programma dettagliato su come sia possibile superarla attraverso un connubio stabile e continuativo tra democrazia economica e democrazia politica. La sua soluzione a questo problema, che costituisce uno dei grandi enigmi della storia contemporanea, era molto piú catartica e impaziente. Era la rivoluzione, una categoria politica profondamente romantica in quanto celebra la forza di un singolo, sublime momento di azione politica, che per Marx restituirà all’uomo il suo essere specie e introdurrà l’era del comunismo.
L’abolizione della proprietà privata è il nucleo di questa rivoluzione. La proprietà privata, scriveva Marx in un passaggio che ha diretta incidenza sul consumismo odierno, «ci ha reso cosí ottusi e unilaterali che un oggetto è considerato nostro soltanto quando ci appartiene, e quindi quando esiste per noi come capitale o è immediatamente posseduto, mangiato, bevuto, addossato, abitato e cosí via, in breve quando viene da noi usato»8 . Solo superando questo infinito approccio proprietaristico l’uomo riuscirà a diventare un vero essere sociale, solo allora l’auto-alienazione umana terminerà, solo allora potrà aver luogo «la reale appropriazione dell’essenza dell’uomo mediante l’uomo e per l’uomo»9 . E anche se Marx giunse a credere che i lavoratori potessero in determinati paesi avanzati conquistare il potere e costruire la loro storia attraverso mezzi pacifici, egli non dubitò mai che la forza caratterizzante della rivoluzione imminente stesse nell’abolizione della proprietà privata. Il cammino della rivoluzione poteva variare, ma la sua essenza economica no.
Il pensiero di Mill è molto diverso, anche se presenta con sorprendente frequenza punti di contatto con Marx. A differenza di moltissimi liberali non scelse di glissare sullo sfruttamento economico della gran maggioranza della popolazione mondiale, o di dare a intendere che il meccanismo dell’«alta marea del capitalismo che solleverà tutte le barche» fosse l’unica strategia economica percorribile a lungo termine. Al contrario, denunciò con forza le macroscopiche diseguaglianze economiche della società moderna e in un linguaggio che non si discostava molto da quello di Marx:
A dispetto di tutto ciò che è stato fatto e di tutto ciò che presumibilmente sarà fatto nell’ambito dell’estensione dei diritti politici, pochi sono coloro nati e destinati a grandi ricchezze e molti all’indigenza, resa solo piú stridente per contrasto. Non piú resi schiavi o dipendenti con la forza della legge, la grande maggioranza degli individui lo sono con la forza della povertà. Sono ancora incatenati a un luogo, a un’occupazione e alla conformità al volere di un datore di lavoro, e privati per sorte di nascita sia dei diritti che dei vantaggi mentali e morali che altri ereditano senza sforzo e indipendentemente dal merito. Non sbagliano i poveri a credere che si tratta di un male pari a quasi tutti quelli contro cui l’umanità ha finora combattuto10 .
Era un male necessario? Ai poveri, prosegue Mill, verrà detto questo, ma farebbero bene a non crederci. Ripetutamente nella storia, sosteneva Mill in un passaggio tipicamente anticonformista, le «opinioni dell’umanità […] tendenzialmente hanno consacrato le realtà esistenti, dichiarando ciò che ancora non esiste o pericoloso o inattuabile». Al contrario egli riteneva necessario contestare e andare oltre l’opinione consolidata. «Le classi lavoratrici, – scriveva Mill, – hanno diritto a esigere che l’intero campo delle istituzioni sociali sia riesaminato e che ogni problematica venga discussa come se insorgesse ora per la prima volta»11 .
Scritte al termine della sua vita, queste parole di Mill lo conducono apparentemente molto vicino all’ambiente socialista, se non allo stesso Marx. Tuttavia questa sintonia non va esagerata. L’ardore con cui Marx e a dire il vero molti socialisti del XIX secolo, come Louis Blanc, con cui Mill intrattenne per anni corrispondenza, condannarono il nuovo sistema capitalista non trova equivalente in Mill.
Occorre qui porre una distinzione in termini sia di approccio sia di contenuto. Mill è spettatore delle grandi ingiustizie sociali tutto intorno a lui, prova profonda solidarietà per coloro che ne sono vittima, ma ne è distante. È altro da loro. Auspica e si adopera per la redenzione sociale e culturale delle classi inferiori ma affinché esse possano un giorno essere sue pari e come tali prendere le redini del governo della società. Marx, invece, è profondamente partecipe, non solo analiticamente ma anche emotivamente, delle vicissitudini di una classe che «sia la dissoluzione di tutte le classi, una sfera che, della sua sofferenza universale, possieda un carattere universale»12 . Non appartiene a quella classe, ma per nascita piú che per scelta, ed è convinto che il proletariato sia destinato dalla storia a redimere l’umanità intera.
Si tratta di approcci soggettivi tra loro diversissimi che trovano il loro equivalente in interpretazioni contrastanti del generale indirizzo storico del capitalismo. Per Marx il capitalismo è condannato, a ragione dei suoi stessi meccanismi economici interni, della caduta tendenziale del saggio del profitto, della sempre maggiore concentrazione di imprese, e per aver creato chi gli scaverà la fossa, il proletariato. Per Mill invece la tendenza alla crisi non è affatto netta. In determinati ambiti si profila un miglioramento, non un peggioramento. I salari non mostrano in generale la tendenza a diminuire. La pressione demografica è un male grave ma contenibil...